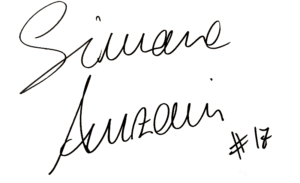Io, da bimbo, ero una vera peste.
Una peste buona, di quelle a cui, alla fine, ti fa quasi piacere perdonare le marachelle.
All’asilo, quando le suore ci mettevano in fila per uscire a fare la passeggiata all’aria aperta, io mi nascondevo negli armadietti, facendomi piccolo-piccolo, e aspettavo che tutti avessero lasciato la stanza.
Poi saltavo fuori e giocavo da solo, con tutto lo spazio della scuola a mia completa disposizione. Questo quando non ero finito direttamente in punizione per aver cercato di sfilare il velo dalla testa delle suore stesse.
Sentivo sempre il bisogno di legare con gli altri, alla costante ricerca del confronto e del dialogo: espansivo, vivace, a volte ai limiti dell’insopportabile.
Ma sempre fedele alla mia più intima natura.
Proprio come ora.


Una delle cose “belle-e-brutte” dello sport è che nello spogliatoio le bugie hanno vita breve, e il tuo carattere, chi sei veramente, alla fine esce sempre, a prescindere dai tuoi propositi di inizio stagione.
Ogni volta che comincia un campionato nuovo, e questo vale a qualunque livello, si mettono in agenda anche le proprie intenzioni: si cerca di imporre a se stessi di limare i difetti caratteriali, di essere più o meno egoista rispetto al passato.
Si cerca il più possibile di assomigliare a chi si vorrebbe essere, e meno a chi siamo veramente.
Poi iniziano le partite, gli allenamenti, le dinamiche interne, le pressioni, le aspettative, gli infortuni, le fatiche, e il tuo cervello, il tuo corpo e la tua anima tornano ad essere chi sono sempre stati.
Trasparenti.
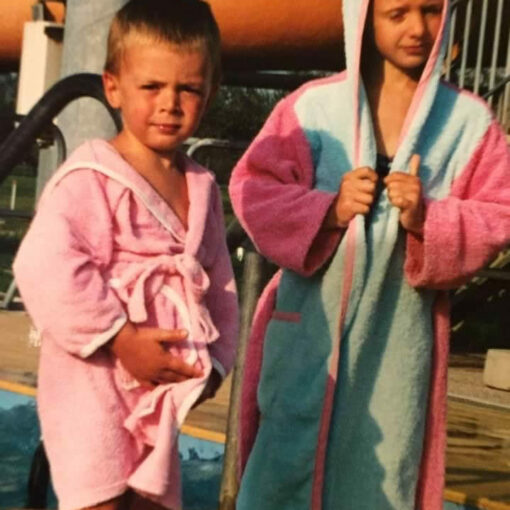

Non vorrei essere frainteso: cambiare è possibile.
Il tempo aiuta nei processi di crescita, e col passare degli anni ti porta a comprendere come alcuni luoghi comuni dello sport, in realtà siano delle assolute verità.
Invecchiando si diventa più aziendalisti, si cominciano a comprendere le dinamiche tecniche, quelle societarie e persino quelle territoriali, andando “oltre” il proprio orticello.
Sono scatti di coscienza che l’atleta fa man mano che si afferma, mano mano che smette di sentirsi in discussione e che comprende la natura mortale della sua parabola.
Perché la pallavolo sarà lì anche dopo la fine della nostra carriera.
Proprio come lo era prima.
Si cresce, si impara, si diventa più completi. E in questo viaggio, l'inconscio è prima un passeggero, poi un compagno, e infine il pilota.


Ma il carattere no.
Quello no.
Quello è profondamente ancorato nelle viscere, piantato come un ulivo alle origini del Mondo, e chi sei, in un modo o nell’altro, pur nel diventare grandi, resta chi sei.
Se sei un chiacchierone resti tale.
Se sei un taciturno, un insicuro, un compagnone o un paraculo, resti tale.
Se ti piace tirar tardi nello spogliatoio per raccontar cagate, continuerai a farlo.
Se hai bisogno di decomprimere i momenti no andando il più lontano possibile da quelle quattro mura, continuerai a farlo.
Lo sport è bellissimo anche per questa sua capacità di mettere a nudo l’animo di ognuno, e per i modi che ha di insegnarti che non è da quello che si giudicano le persone.
A scuola, all’università, al lavoro e in qualunque altro ambiente non è facile ottenere una linea tanto diretta alla natura delle persone, e tutte le deviazioni dalla narrativa finiscono con l’appiattire l’orizzonte. E far sembrare “diverso” chi non si uniforma alla presunta normalità.
Lo sport non è così: ogni spogliatoio, di qualunque squadra, a qualunque livello ha le sue unicità, le sue stranezze, e le protegge come parte di un espressione superiore, come parte di un condivisione pura.

Io ho sempre portato me stesso in ogni spogliatoio.
Anche se, per apprezzare chi sono senza se e senza ma, ci ho messo del tempo.
È stato facile, per esempio, esprimerlo appieno quando sono arrivato a Treviso, ragazzotto appena adolescente, perché erano i primi assaggi di vera libertà.
Avevo i primi peli addosso.
I primi accenni di baffi.
“Simone fai, Simone disfa”: stare da soli, lontano da casa, per quanto in un ambiente protetto, è il primo vero test per il carattere di un uomo. Come essere buttati in acqua per imparare a nuotare.
E io, proprio io che ero un casinista ribelle, durante gli anni a Treviso, in un settore giovanile strutturato e molto serio, quando tornavo e passavo del tempo con i miei vecchi compagni di scuola non mi rivedevo più in loro.
Mi sembravano diventati infantili, tutti d’un colpo, focalizzati su cose banali, mentre io invece avevo cominciato a sognare in grande, con i miei equilibri nuovi.

© Maurizio Spalvieri
La mia carriera, per quanto ancora a metà strada (o poco più) è stata già lunga e piena di quegli alti-e-bassi che ti permettono per davvero di capire di che pasta sei fatto.
Dopo la gavetta in Serie A2, ho trovato il posto perfetto, a Verona, dove per un attimo ho pensato che sarei anche potuto invecchiare in pace.
Un attimo durato quattro anni.
Ero felice, tutto girava a meraviglia: la squadra, la città, la vita privata.
Ancora oggi è il luogo dove vivo quando non sto giocando altrove, dove ho comprato casa.
Eppure, nonostante tutto questo, c’era qualcosa in me che non si sentiva completamente realizzato. E riuscire a comprenderlo non è stato affatto facile.
Mi è servita una ricerca, mi è servito confrontarmi con un mental coach per capire che dovevo andare “oltre”, mettermi alla prova ad un livello più alto.
Può sembrare banale, oggi.
Ma non lo era allora, che accumulavo presenze in nazionale ma non ero stato in grado di essere tra i convocati di Rio. Che mi sentivo forte e sicuro in campo, ma ad alzare i trofei erano gli altri.

Allora sono andato a Perugia, ed è stato un successo.
In un anno abbiamo vinto il Campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, e mentre tutti avevano un motivo per esultare, io pensavo ai miei.
C’erano state più ombre che luci nel mio recente passato e io mi stavo persuadendo a fare un passo indietro, convincendo me stesso che forse, quello non era davvero il mio livello.
Perché i dubbi arrivano, sempre.
Fanno parte della completezza di un viaggio.
Un viaggio in cui è troppo semplice essere felice quando tutto va bene.
A distanza di anni, è la reazione che resta.
La capacità di andare oltre la paura totalizzante di non essere abbastanza, e di farlo restando fedele alla persona che sei.
Crescere è soltanto una ricerca della pace.
Prima di tutto quella con se stessi.

© Max Marani
Nel tempo, il tuo atteggiamento diventa una costante, un’impronta.
Perché sei sempre meno propenso ad accettare compromessi, soprattutto se sai che la tua volontà è al posto giusto.
Cambia solo quello che vuoi ottenere, come atleta e come squadra, che a vent’anni, ovviamente, non può essere la stessa cosa che a trenta.
Le aspettative si fanno sempre più alte, la gente giudica molto in fretta, e più si fa sottile lo spazio in cui devi passare per soddisfare tutti e più devi essere consapevole di chi sei, e di come sei riuscito ad arrivare fin qui.
Quando sono arrivato a Macerata, entravo in uno spogliatoio “campione di tutto” e sapevo di doverlo fare in punta di piedi.
Non per mascherare chi sono.
Ma per dare tempo agli altri di capirlo, e per far emergere poi tutto il mio carattere.
Spigoli compresi.

© Maurizio Spalvieri
È questo modo di vivere lo sport che da sapore alle cose, perché protegge la storia di ognuno, e dà un valore universale, eppure unico, al viaggio di tutti.
Dagli errori si impara.
Ma dal loro ripetersi si può finire decapitati, sportivamente parlando.
Da una mancata Olimpiade si può attingere una nuova motivazione.
Ma con quel fuoco ci si può anche bruciare.
Così, nel continuo alternarsi di momenti sempre diversi e sempre uguali, spunta il mosaico di una carriera intera, cominciata a vent'anni e non ancora conclusa.

Quel ragazzo, che ha spesso dubitato di sé, ora ha in bacheca anche un oro Mondiale, e quando lo guarda ha il cuore spaccato a metà, perché per quanto sia bellissimo sentirsi realizzati, sa che il prossimo capitombolo potrebbe essere appena dietro l’angolo.
E quando succederà, tutto ciò che avrà per rialzarsi saranno le cose di sempre.
Carattere in primis.
Simone Anzani / Contributor