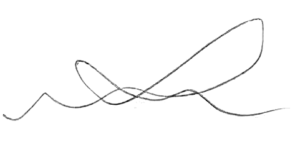Quello che resta della vita è una collezione di prime volte.
Perché sono quelle a dare un senso a tutto il resto.
Sono quelle che ti danno la forza di iniziare qualcosa di nuovo.
Di cambiare strada.
Di lasciarti il passato alle spalle.
Un passato piccolo o un passato grande, non fa alcuna differenza.
Il primo bacio.
Il primo giorno.
Il primo pugno.
Il primo ricordo che ho è quello di quando mi nascondevo dietro gli alberi, e mi facevo piccola-piccola, seguendo i passi di mio fratello per tutto il paese.
Perché io volevo essere come lui.
Io volevo giocare con lui e con i suoi amici.
Volevo fare gli sport da maschio.
Ero la sola ragazza in mezzo a tanti ragazzi, sempre sporca di polvere o di fango.
Sempre pronta ad inseguire un pallone, a prenderlo a calci, a lanciarlo lontano.

Non è stata un’infanzia facile.
L’Africa sa essere un luogo complesso, quando vuole.
Siamo stati cresciuti da nostra madre, una single mom, che faceva tanti lavori diversi.
Tantissimi lavori diversi.
Ci ha cresciuti facendo enormi sacrifici, in particolare sacrificando il suo tempo, perché aveva il sogno di offrirci un futuro migliore.
Cibo migliore.
Scuole migliori.
Carriere migliori.
Appena siamo stati in grado di farlo abbiamo iniziato a contribuire al bilancio familiare.
Piccoli lavoretti.
Mal pagati, certo.
Ma che ci facevano sentire già grandi.
Importanti.
Eppure, anche nei momenti più belli, il desiderio di avere qualcosa di più tornava sempre a bussare alla nostra porta. Con insistenza.
E di fronte alla prospettiva di quel che non hai, anche ciò che non conosci diventa presto una mancanza.

Sono arrivata in Gran Bretagna quando avevo soltanto 11 anni, e ormai ho trascorso più anni qui di quanti non ne abbia passati in Camerun.
All’inizio fui sopraffatta da tutto.
Lo stile di vita era completamente diverso da quello a cui ero abituata.
Era tutto eccitante e veloce.
Anche troppo, veloce.
Facevo fatica ad imparare l’inglese, e spesso a scuola venivo bullizzata per il mio accento pesante. Ero solo una bambina, ma ricordo ogni minimo dettaglio.
Ogni parola.
Ogni offesa.
Per quanto possa essere un cliché, mi hanno reso infinite volte più forte.
Smontandomi ogni giorno, e obbligandomi a ricostruirmi ogni notte.
Più spessa.
Più dura.
Più Cindy.
Poi il tempo passa, i bulli rimangono soli e soffrono più dei bullizzati, e la vita continua, mettendoti davanti ad una nuova selezione di prime volte.
Come la scatola di cioccolatini di Forrest Gump.
A volte belle e a volte brutte.
Tutte da ricordare.

Come la prima volta che ho passato la notte in carcere.
Mi portarono in un centro di detenzione, insieme a mio fratello Kennet.
Ci avevano prelevato direttamente dall’ufficio immigrazione, dove ci recavamo tutte le settimane a firmare il foglio presenze.
Passai la notte con la prospettiva di essere riportata contro la mia volontà in un Paese dove l’omosessualità è illegale, e dove sarei finita in carcere per quello che sono.
Oppure come la prima volta che ho messo i guantoni.
Quando avevo 15 anni, pesavo quasi 110 chili, e per dimagrire decisi di iniziare a giocare a calcio.
Era troppo leggero, per me.
Poca adrenalina.
Poco contatto.
Non abbastanza forte.
Così, un giorno, passeggiando per la città mi imbattei in una piccola palestra polverosa e puzzolente, dalla quale uscivano continui rumori fortissimi: “boom! boom!”
Poteva essere la porta dell’inferno, e invece per me era l’ingresso del paradiso.

© Times
Era la prima volta che vedevano entrare una ragazza.
Mi misi diligentemente in fila, e iniziai la procedura del riscaldamento insieme a tutti gli altri.
La corda.
Lo skip.
I sit-up.
Poi il coach disse di mettere i guantoni, ma quando mi avvicinai per prenderne un paio, lui mi fermò: “no. Tu fai lo skip”.
Feci skip per 90 minuti.
E lo rifeci il giorno dopo.
E quello dopo ancora.
Sorretta solo dalla speranza che se avessi fatto tutto quello che mi veniva chiesto anche io, prima o poi, avrei iniziato a dare i pugni al sacco.
Per un anno non feci altro.
Nient’altro.
Quando scesi a 90 kg mi diedero i guantoni e iniziammo a lavorare sul footwork e al sacco. Io e coach Dave.
Mesi di shadow boxing.
Mesi di tecnica.
Mesi di studio.

Ricordo anche la sensazione del primo colpo preso in faccia, per davvero, facendo sparring sul ring, con un ragazzo.
Corsi in bagno a piangere per il dolore.
Ma io non mi fermai.
E Dave non smise mai di essere duro con me, perché è sempre stato quello ciò che mi serve per migliorare.
Per tanti anni ho tentato di diventare una cittadina britannica.
Per rappresentare la Federazione che mi aveva accolta e protetta quando ne avevo più bisogno. Senza successo.
E allora quando mi hanno proposto di unirmi all’IOC Refugee Team, sempre grazie al supporto della Federazione, ho detto di sì, con orgoglio.
Ho detto sì, anche se la prima volta che mi hanno chiamata “rifugiata” ho provato un imbarazzo profondo, perché mi sono sentita impotente, indifesa.
Sola.
Per la prima volta nella mia vita.
Ora ho abbracciato il senso di questa opportunità.
Ora ho capito il suo valore.
Il suo significato.
Oggi so che questa squadra rappresenta milioni di persone, molte delle quali, durante Parigi non avranno neppure la possibilità di guardare i Giochi.
Persone in fuga.
Persone che corrono rischi solo per essere loro stesse.
E persone che saranno tutte racchiuse dentro i miei guantoni.
Sarà la prima volta, per una boxeur, e li renderò tutti fieri di me.
Cindy Ngamba / Contributor