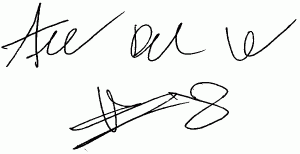Non so dire con esattezza se io sia stato davvero il primo, ma di certo a quei tempi la cosa non andava di moda come ora.
Non c’erano i riferimenti che ci sono adesso, e soprattutto non c’era modo di partire con la consapevolezza, o anche solo l'illusione, di sapere cosa si sarebbe trovato, una volta atterrati su quell'enorme pezzo di roccia.
Come un Neil Armstrong degli anni 2000, ho studiato più che ho potuto finché sono rimasto sulla Terra, per racimolare tutte le informazioni disponibili su quel posto lontano.
Poi, sono partito.
Nel mio caso è stato “un piccolo passo per l’uomo e niente di clamoroso per l’umanità”, ma il momento in cui sono sceso dall’aereo resta senza dubbio il punto di partenza perfetto per raccontare chi sono.

Quando parlo del mio allunaggio sugli Stati Uniti d’America, mi riferisco in realtà a quella volta in cui ci sono andato per restare. Perché di capatine in vacanza ne avevo già fatte diverse, e più ci tornavo più cresceva dentro di me il desiderio di passarci un periodo più lungo, dedicato solo al basket, di cui l’America è madre e allo stesso tempo è figlia.
Se penso alla mia infanzia mi restano davvero pochissimi ricordi, e quando cerco di andare a ritroso con la memoria mi blocco sempre a quel giorno: il momento esatto in cui, a Malpensa, è iniziato il mio viaggio.
Come se tutto quello che è successo prima fosse servito soltanto a portarmi fin lì, mentre supero i controlli di sicurezza fingendo di non vedere le lacrime di mia mamma, che è rimasta di qua. Mentre invece io, i miei 18 anni e la palla da basket siamo già di là, pronti sul nostro razzo lunare e con il conto alla rovescia che, ormai, è iniziato da un po’.
Durante il tragitto verso il Nevada, la mia mente non smetteva di fantasticare su quale sarebbe stata la mia routine a partire dal giorno seguente.
La scelta, ricaduta sulla Findlay Prep High School, era stata fatta molto in fretta, per motivi burocratici, e tutto ciò che sapevo sulla scuola lo avevo appreso dalla serie web autoprodotta dall’istituto e che raccontava le gesta della squadra di basket, la ragion d’essere dell’intera high school.

Certo, il binge watching di una serie youtube non è granché per decidere di affidare il proprio futuro a degli sconosciuti, e forse parte delle lacrime di mamma all’aeroporto erano causate proprio da questo alone di mistero.
Ma se c’è una cosa che io e quell’Armstrong famoso abbiamo in comune, è l’audacia di lanciarsi nel vuoto cosmico.
Lui letteralmente, io un po’ meno.
Una volta atterrato, la magia ha iniziato a compiersi, e se non fosse stato per una lattina di sprite esplosa nella macchina del coach dopo nemmeno 5 minuti dal mio arrivo, potrei dire che è stato tutto perfetto.

Certo i primi giorni sono stati tosti, perché in tutte le cose della vita ci vuole un periodo di adattamento. Capire gli spazi, i modi, entrare in una dimensione che fino a poche ore prima non ti apparteneva. Il tutto condito anche dall’essere l’unico italiano dell’intero istituto, titolare all’epoca di un inglese utile soltanto alla stretta sopravvivenza.
Per me, giorno dopo giorno, a parlare è stato il campo.
E il campo dice sempre la verità.
Dopotutto giocare è sempre stata l’unica cosa davvero importante.
Sono cresciuto vedendo mio padre in campo e ho sempre pensato che farne una professione non sarebbe stato altro che il normale svolgimento delle cose.
Diretta conseguenza del mio essere al mondo.
Io giocavo più che potevo, ogni volta che potevo, tipo che andare a fare 2 tiri a canestro era l’unico premio che mi spingeva a risolvere i problemi di matematica durante le ore di ripetizioni.
Giocare, tirare, segnare.
E all’high school ho segnato tanto.
Al college un po’ meno, ma il parquet era di quelli bollenti.

© Pallacanestro Brescia
La scelta del college è stata praticamente automatica.
L’esperienza all’high school era stata soltanto la prova generale per il vero debutto, quello nel campionato più bello e più pazzo del mondo.
E dopo la stagione che avevo fatto, gli atenei interessati ad avermi in squadra erano tantissimi.
Arrivavano lettere su lettere da università pronte a giurare che fossi davvero io l’arma vincente che mancava al loro roster, o ad assicurarmi che il mio arrivo in squadra avrebbe fatto fare il salto di qualità che cercavano da anni.
Mi riempivano di complimenti e io mi gonfiavo il petto ogni volta di più.
Alla 50esima proposta ho capito quale sarebbe stata la mia scelta: Ohio State, ovvero l’unica università a non avermi promesso nulla, anzi, la sola a non garantirmi nemmeno un buon minutaggio in campo.
Ma se sei sulla Luna, non guardi mica verso il basso, che cadere è un attimo.
E Ohio era il punto più alto della mia lista.
Mi sono detto che i minuti me li sarei guadagnati con pazienza, cogliendo ogni occasione che mi veniva data e dimostrando di essere a mio agio anche su un parquet bollente come quello della March Madness.

© Pallacanestro Brescia
Spiegare a parole cosa si prova a vivere un torneo NCAA da protagonisti è davvero difficile. L’aria che si respira in quei palazzi è tanto rarefatta da far girare la testa e per un istante, solo per un istante, è facile perdere il contatto con la realtà.
Quando sconosciuti per strada ti fermano per foto e autografi, quando migliaia di persone vengono a guardare le partite indossando una parrucca riccia che imita la tua capigliatura, quando ti senti al centro dell’universo, anche se un universo parallelo, rischi di abituartici.
Fare le valigie e tornare a casa non è stato semplice, né quando l’ho fatto per indossare la maglia della nazionale, né quando l’ho fatto da giocatore adulto, per entrare nel mondo del professionismo.
Il rientro in Italia è stato secco e spiazzante, come il rumore sordo di un oggetto che si schianta per terra in una stanza vuota.
La sera stessa in cui ho firmato il contratto con la Pallacanestro Reggiana, ero pronto a prendere le mie cose in spalla e fare l’Atlantico a nuoto, pur di tornare negli States.
Dopo averci dormito su, o forse obbligato dal mio senso del dovere, la mattina seguente ho messo piede in palestra, ricominciando tutto da capo.
Ero ancora una volta su un Pianeta diverso, dove i compagni di viaggio non erano più coetanei, resi amici dal quel senso di appartenenza che solo il college sa infondere, ma adulti, professionisti, ognuno con il proprio bagaglio stipato nell’armadietto. Tanto tecnico, quanto personale.

© Pallacanestro Brescia
Regole diverse, dentro e fuori dal campo.
Ritmi diversi.
Attenzioni diverse che, anche se a vedere le partite c’era un quarto delle persone presenti abitualmente alla Value City Arena, mi facevano sentire come se il peso specifico di ogni sguardo fosse quintuplicato.
Ci è voluto del tempo, qualche incazzatura, e la fiducia di chi mi circondava, che è il vero motore di ogni buon risultato, prima che potessi ritrovare il mio basket. Il mio gioco.
Ed è stata una cavalcata pazzesca, fino a quella struggente gara 7, che ci ha lasciati dal lato sbagliato della storia, ma che sono convinto sia stata utile a crescere più di quanto all’epoca sarei stato in grado di ammettere.
Da quel momento in avanti, la voglia di giocare, di scendere in campo il più possibile, e su più campi possibili, mi ha portato a prendere più di un aereo, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo.

© Pallacanestro Brescia
Voli brevi, con destinazione Malpensa.
E voli lunghi.
Come quello verso le spiagge di Las Palmas, dove il sole delle Canarie non è bastato a scaldarmi i polpastrelli quanto avrei voluto, ma che, senza dubbio, mi ha aiutato a mettere in prospettiva molte cose, compresa la mia idea di pallacanestro.
O come quello che mi ha fatto debuttare in Eurolega, con addosso una maglia, la divisa rosso-Olimpia, che porta con sé un peso speciale.
O ancora, come quello atterrato nella fredda terra di Montenegro, tanto rurale quanto diretta, proprio come i suoi abitanti. E questa volta posso dire con certezza di essere stato il primo italiano a giocare lì. Non sono arrivato pronto, più o meno come era successo in America, ma lo sono diventato con il tempo, facendomi apprezzare per come sto in campo, e trovando in panchina orecchie che avessero voglia di ascoltarmi.
Trovando fiducia negli altri e in me stesso, facendo tesoro di ogni consiglio, per poi tornare a casa, come nel più classico dei film.
L’America, l’Italia, poi l’Europa e ancora l’Italia.
Perdendomi e ritrovandomi ogni volta.
Chi non ha paura di rischiare si getta a capofitto dove vede l’occasione di crescere, per aggiungere un tassello nuovo nel grande puzzle delle proprie esperienze.
E sono tutte queste tessere a comporre il mosaico del giocatore che sono oggi a Brescia: maturo, consapevole, felice di essere dove sono.
Un ragazzo partito pioniere improvvisato, tornato scopritore di se stesso, che preferisce far parlare il campo.
Amedeo Della Valle / Contributor