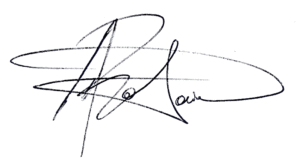Seduto sul bordo vasca.
La schiena contro il muro.
Osservo le corsie, osservo gli altri andare avanti e indietro.
Osservo e basta, fatico a fare altro, perché il cervello, oggi, non funziona.
Si muove a rilento.
Sembra quasi non accettare qualcosa.
Qualcosa di ieri, qualcosa di domani. Forse entrambe.
Il corpo è distrutto, non risponde più come una volta.
È stanco.
Pieno di dolori.
Vecchio.
Più vecchio di quello che in effetti è.

È un momento che ritorna, ciclico come una marea.
Ed è un momento tutto mio.
Nel bene e nel male.
Perché quando sento di non avere più una singola ragione per allenarmi, quando sento di non averne più la capacità, oppure la voglia, o magari il coraggio, proprio in quell’istante tutto si risolve .
E lo fa con immediata, ed elegante, semplicità.
L’acqua.
L’acqua è la mia risposta.
Nel preciso istante in cui convinco me stesso che devo soltanto trovare le forze di tuffarmi dentro l’acqua, il resto evapora.
Come se fossi ricoperto di fango, non di fatica.
Come se addosso avessi polvere, non pensieri.
E allora ecco che appena la testa riemerge per la prima volta, tutto scivola via.
Tutto è lavato, tutto è pulito.
Tutto ritorna al proprio posto.

Ci deve essere una ragione profonda, se funziono così.
Un’origine.
Un inizio.
Un seme antico, piantato dentro di me.
Che ha messo radici, e che è impossibile da rimuovere.
I miei genitori raccontano che quando ero bambino e mi facevano uscire dall’acqua del mare, specie da quella dell’Oceano, cominciavo a piangere disperatamente, e non smettevo fino a quando, tornati a casa, non mi immergevano in una piscina.
Come se non avessi mai voluto uscire dal liquido.
Come se non avessi mai voluto nascere davvero, ma preferissi restare sospeso in eterno, nello spazio senza nome, tra il cielo e la terra.
Uno spazio che è fatto di acqua e di amore.
Io non mi ricordo di quei pianti, non possono ricordarmeli.
Ero troppo piccolo.
Ma ricordo molto bene le estati al mare, nella casa di famiglia.
L’isola e la sua dolce vita.
Ricordo la lenta ripetitività di una routine che non avrei mai voluto interrompere, un ciclo fatto di colazioni, di gelati, di passeggiate in centro, di cartoni animati.
Fatto, soprattutto, di tantissima acqua.

Poco più tardi, ho iniziato a nuotare, nel senso proprio di praticare lo sport, un po’ perché l’acqua era il mio elemento ed era impossibile allontanarmi da lei, e uno po’ perché ero geloso di mia sorella.
Mia sorella maggiore.
Che ogni tanto andava via di casa per gli allenamenti e io non capivo il perché non rimanesse lì con me, come aveva sempre fatto.
Non capivo perché andasse via.
A me non interessava la competizione.
Almeno, non all’inizio.
Però, mi piaceva la sensazione di frenetica estasi che ti lascia l’imparare cose nuove, la soddisfazione muta che nasce dal capire qualcosa da soli, dal memorizzare un movimento, dal padroneggiare uno stile.
Amavo l’idea del miglioramento.
Della crescita.
Dell’abbassare il cronometro.
Gli stessi identici elementi che ancora oggi, tre Olimpiadi più tardi, mi danno la forza e la motivazione per continuare. Per tuffarmi in acqua anche quando la testa e il corpo ripetono, ossessivamente, no. Oggi no.
Il contorno è diverso, invece.
L’acqua resta acqua, ma io sono cambiato.
Da giovane mi preoccupavo solo della performance, della distanza, della fatica.
Da giovane non pensavo che mi servissero i giorni di riposo, e ritenevo che gli allenamenti più leggeri fossero soltanto una perdita di tempo.
Se non soffro non miglioro, se non miglioro cosa sto nuotando a fare?
Oggi non è più così.
Oggi mi so godere anche una seduta facile, so concentrarmi sulla singola bracciata, sulla tecnica, persino sul tempo che scorre via, vasca dopo vasca.
Giorni di vetro e di calma apparente, in cui riallacciare i discorsi con la tua persona.


Quattro cicli Olimpici, nell’esistenza di un atleta, significano molti anni e anche molti chilometri.
Sono partito da casa che ero poco più che un bambino e, come Ulisse, non ci sono ancora tornato.
Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, e poi Londra, Rio, Tokyo: un’Odissea lunga una vita, la mia vita, che ogni aereo che prendo, in realtà, più mi porta lontano e più mi fa sentire legato alla mia terra.
La mia Grecia, con le sue abitudini e le sue tradizioni.
E la mia famiglia, con i suoi riti e i suoi gesti.
Ci vorrà del tempo per tornare davvero a Itaca.
Tempo per cominciare una vita nuova, fuori dalla piscina, ma sempre dentro all’acqua. Una vita per la quale sto studiando, per la quale so di essere già pronto.
Vicino eppure lontano.
Capace ma non per questo ansioso, visto che sento di avere ancora molto da ottenere per l’atleta che vive in me.
E certo, non ho più l’esuberanza di quand’ero ragazzo.
Né la capacità fisica di recuperare energia tanto in fretta.
Ma, mai come oggi, sono stato così consapevole del senso di quest’avventura, del valore del programma a lungo termine, del piacere delle piccole cose.
Non sono mai stato così consapevole neppure del fatto che a volte è necessario perdersi, lungo la via. Che l’errore può essere enorme.
Che può farti dubitare, che può persino farti smettere.
E che va bene lo stesso.
Perché alla fine tutto ritrova la via, tutto ritrova il suo equilibrio.
Ritrova il suo spazio.
Parigi è alle porte, e poi ci sarà Los Angeles.
E poi, ancora, chissà.
In fondo, non è un problema mio.
Il mio problema è soltanto quello di navigare, nel sole e nella tempesta, con lo sguardo fisso all’orizzonte, un po’ voglioso e un po’ no di avvistare terra.
Andreas Vazaios / Contributor