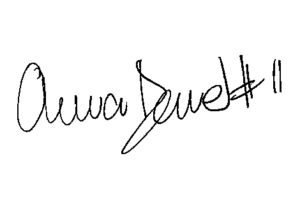Quando la misura è colma, non puoi più tornare indietro.
Quando il vaso trabocca.
Quando passi una soglia.
Quando capisci che oltre a quello che hai già sentito non c’è spazio per nulla di nuovo, tutto cambia.
E lo fa per il meglio.
È come se ti trovassi in una stanza enorme, piena di spifferi gelati che arrivano da ogni dove, e in cui non fai altro che correre da una porta ad una finestra per provare a mettere un cerotto.
Un cerotto emotivo.
Psicologico.
Fino al punto in cui molli.
Con dita, piedi e naso congelati, molli.
Lasci che il vento spalanchi ogni cosa, che sbatta le imposte e che ti investa.
Ed è lì che ti accorgi come stando in mezzo, proprio nell’occhio del ciclone, in realtà regni la calma.
Nulla ti può davvero toccare.
Sei impermeabile.
Nascosta in piena vista.
Che cos’altro potrete mai dire di me?
O di noi.

La nostra squadra, la nostra nazionale ha un vissuto enorme.
Pieno di successi e di delusioni, pieno soprattutto di tantissime parole altrui.
Quelle che ci hanno giudicato, definito, disumanizzato.
Quelle che a volte ci hanno fatto incazzare.
Sfinire.
Piangere.
E la verità è che eravamo tutte stufe.
Tremendamente stufe.
Stufe marce di sentirci realizzate a metà, delle occasioni perse, del fiume di commenti e di insulti che abbiamo ricevuto per anni.
E quando ci siamo trovate a ricominciare tutto da capo, a due passi da Parigi 2024, la sensazione condivisa da tutte, era quella di essere in cammino su un’ultima spiaggia.
Un’ultima grande occasione.
Almeno così.
Almeno con questo gruppo.
Con questo spogliatoio.

Un’ultima spiaggia, vera o figurata, chissà, non fa alcuna differenza, che ci ha come esposte, prima una all’altra e poi tutte insieme verso il resto del Mondo.
Queste siamo.
Questo è quello che c’è da fare.
O ne hai, e allora ne metti, altrimenti lascia stare.
Sarà semplice, sarà banale magari, ma è questo quello che è successo alla VNL e a Parigi. È stata questa esigenza nuova a trasformarsi in disponibilità, a farci accettare senza pensieri gli allenamenti extralarge, le richieste specifiche, l’attenzione ai dettagli, la cura maniacale di tutto ciò che circonda il gesto tecnico.
Un viaggio che, per me, è iniziato una domenica mattina di tanti mesi fa, quando sul cellulare è comparso un whatsapp di Julio: “Posso chiamarti? Dovrei parlarti di cose tecniche e organizzative.”
Era la seconda volta che lo sentivo in tutta la mia vita, la prima se si esclude la più semplice e asciutta delle presentazioni.
E il mio cuore ha iniziato a pompare, come raramente aveva fatto prima.
Non mi sentivo al mio meglio, nel club non riuscivo ad essere quello che ero sempre stata con continuità. Dubitavo di me stessa, e su quella richiesta di confronto ho proiettato tutte le mie insicurezze.


“Capitano? Io? Ma è sicuro?”
Il resto della telefonata non lo ricordo granché, perché il mio cervello si è fermato a quella prima domanda. A quella parola tanto evocativa e tanto complicata.
Pensaci su, non rispondere subito, mi ha detto.
Ma la risposta la sapevo già.
Chi mai rinuncerebbe a rappresentare qualcosa che ama visceralmente?
Chi mai non si sentirebbe apprezzata e capita da una richiesta così?
Il dubbio veniva da dentro.
Veniva dal mio carattere pacato e accomodante.
Più da team manager che da capitano.
O almeno questo pensavo.
E pensavo anche a tutta la storia della nostra squadra, al carisma di Miriam, all’importanza di Moki, al peso delle veterane, alle esperienze passate.
Chiedendomi se io sarei mai potuta essere all’altezza.
Che cosa avrei potuto portare io che le altre non avevano.
Che cosa avrebbe significato un fallimento sportivo.

Ho detto sì.
Chiaro che ho detto sì.
Tutti sanno che ho detto sì.
Ma l’importanza profonda di quel sì, per me e per il mio passato, è più difficile da spiegare a parole, compressa com’era in tanti anni di montagne russe emotive e di accerchiamento mediatico più furbo che onesto.
Più paraculo che professionale.
L’impatto è stato forte.
Lo stile di allenamento è cambiato, gli orari sono cambiati, le libertà sono cambiate.
E con esse anche il nostro modo di comunicare.
Sia a gesti che a parole.
Dal punto di vista tecnico, Julio è un decisionista.
Un grande decisionista.
Se dice A, deve essere A.
Non B.
Non A+.
Non A-.
E all’inizio non è stato affatto semplice costruire equilibri nuovi, dove capisci il valore assoluto della sua assunzione di responsabilità, della schermatura che ti regala, e che ti permette poi, dentro quel perimetro, di sentirti più leggera.
Feroce, certo.
Incazzata.
All’ultima spiaggia.
Ma leggera.

E quando ti senti così, anche le frasi che senti ripetere da una vita cambiano di sapore, diventano più incisive. Più efficaci.
Sentirmi dire, prima della finale di VNL, che “anche se tutti caricano di significato una finale, alla fine dei conti è soltanto un’altra partita, e noi dobbiamo giocarla” mi ha aperto gli occhi.
Pur essendo anni che la sentito dire.
Sarà il tono, sarà il modo.
O forse sarà che a cambiare è stato qualcosa che hai dentro tu.
A Tokyo 2020, dentro il Villaggio, le mie compagne quasi non le incrociavo neppure.
Parigi è stato come vivere un collegiale.
Lontane dal Villaggio.
Lontane da tutto il resto.
In albergo, a 10 minuti dalla palestra.
Con le famiglie vicino.
Solo volley.
Puro e semplice volley.
Certo, poi i Cinque Cerchi in campo le vedevi, ma la sensazione era quella di una bolla perfetta, tutta nostra, dove poter fare solo e soltanto il nostro mestiere.


La distanza dal clamore era tale che, ad un certo punto, per la quiete che si respirava, tra di noi, abbiamo iniziato a chiamarlo “il torneo della baguette”.
E io sono certa, al 100%, che ognuna di noi, in almeno un’occasione, quando si è trovata sotto stress, si è detta di non preoccuparsi, che in fondo è soltanto il torneo della baguette.
E lo so perché anche io me lo sono detta più di una volta.
Una linearità emotiva perfetta, dall’inizio alla fine, che ha coperto anche quello che tecnicamente, magari, non ha funzionato come immaginato prima del via.
I quarti e la semifinale sono state giocate al di sotto del nostro standard.
Eppure non ho mai sentito, neppure per un istante, il dubbio.
In nessuna forma.
Perché ero certa che tutte stavano condividendo il mio pensiero.
Che tutte eravamo lo stesso pensiero.
Un pensiero senza punti interrogativi.
In un sola occasione mi sono posta una domanda.
Dopo il primo set contro la Repubblica Dominicana, il primo dei nostri Giochi, il solo che abbiamo perso. E dopo il quale, per un brevissimo istante mi sono cagata sotto.
Non che mi interrogassi sul nostro valore.
Ma bensì sulla possibilità che quelle finestre aperte e quegli spifferi tornassero a tormentarci, a farci sentire in bilico, giudicate.
Bloccate nell’eterna narrativa del “vorrei ma non posso”.
Uno spazio che abbiamo occupato subito, insieme.

Perché quando le hai già sentite tutte.
Quando te ne hanno dette di tutti i colori.
Quando hanno già provato a farti sentire fallita o inadeguata in qualsiasi modo possibile e immaginabile, e tu sei ancora in piedi, cosa resta?
Nulla.
Solo giocare.
Solo riconoscere il proprio valore e quello delle altre.
Solo vedere la qualità reciproca, umana e tecnica, e prendersene cura.
Vincere è una conseguenza.
Da capitana o da panchinara.
Vincere è una conseguenza.
Alle Olimpiadi o al torneo della baguette.
Anna Danesi / Contributor