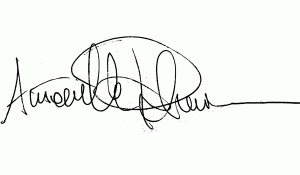Per i cambiamenti ci vuole tempo, e noi, marciando, facciamo il nostro.
Lamentarsi non cambia nulla, soprattutto se hai ragione.
Perché se hai ragione, ma nessuno ti ascolta, vuol dire che quel che stai combattendo è radicato nel profondo, e non basterà certo un’idea per abbatterlo.
Servirà una vita intera, da dedicare allo scopo.
Con il primo stipendio della mia vita ho comprato una macchina, anche se la patente non l’avevo ancora presa, perché volevo farmi trovare pronta quando la libertà avrebbe bussato alla mia porta.
Così, non appena è stato possibile, al raduno successivo mi ci sono presentata guidando: 500 chilometri tutti da sola, con la paura di una strada che non conoscevo affatto, e contro il parere della famiglia, che avrebbe preferito vedermi salire su un treno, o che qualcuno mi accompagnasse.
Un gesto semplice, da raccontare oggi.
Un riflesso d’orgoglio.
Che mi accomuna a molte donne, ma che ricordo ancora, più di tante altre cose, perché da qualche parte si deve pur cominciare, e quello è stato uno dei “miei” inizi.


Uno dei miei inizi.
Una di quelle prese di posizione che mi hanno permesso di capire chi fossi per davvero, e cosa volessi fare da grande.
A volte si cresce anche per negazione, oppure per esclusione, eliminando un pezzo alla volta tutto ciò che ti rende infelice.
Tutto ciò che ti rende triste.
Tutto ciò che è inaccettabile.
In casa non era visto tanto di buon occhio che io mi dedicassi allo sport, fin da quando era bambina. E mentre crescevo, ho dovuto fare i conti sempre con i tempi e i modi di una generazione diversa dalla mia.
Sono chi sono anche grazie ai divieti che mi sono stati imposti, che per contrasto mi hanno definita, e che ricordo senza nessun rancore, nonostante qualcuno, dopo l’oro di Tokyo, abbia deciso di affibbiarmene d’ufficio.
Che un po’ di dramma letterario aiuta sempre a vendere le copie.

La tradizione, però, in alcuni posti è ancora “la tradizione”.
Magnifica e bellissima, ospitale e generosa.
Granitica m impaurita di fronte allo scorrere del tempo. Mio padre, per esempio, che di quella stessa tradizione è sia figlio che protettore, avrebbe preferito sapermi devota ai doveri della casa, il focolare più antico che ci sia.
Ho dovuto dimostrare quanto contasse per me, fare altro.
Ho dovuto battermi per fare quello che mi piaceva davvero.
Ma non di meno oggi, il mio successo è anche il suo, che mi vuole bene e che ha capito come capirmi.
Non è un caso, perché niente lo è mai davvero, che mi porti dietro fin da allora il seme della competizione tra i sessi, il desiderio di voler finire comunque davanti ai maschi.

In ogni gara, in ogni allenamento.
Costi quel che costi.
È una forza che sento dentro, e che da dentro poi esce e investe chi mi sta accanto, come il mio allenatore, che spesso, nelle giornate in cui le gambe girano al meglio, mi guarda e sorride: “quando li batterai…”
Questa, forse, è la mia forma di femminismo contemporaneo, la mia lotta senza quartiere, la mia impronta sul Mondo, forgiata dalle estati secche dell’entroterra pugliese.
Casa mia.
Lo sport era il modo migliore per uscire di casa, se non l’unico.
Tolti i pomeriggi che passavo a scuola, quelli erano i soli momenti di svago che il paesino dove sono nata concedeva ad una bimba della mia età.
C’erano un palazzetto e due strade: o giocavo a pallavolo, e ci ho provato, senza troppo successo, oppure mi mettevo a correre.
Le abbiamo consumate, quelle stradine e anche le scarpe, e più andavo forte e più i risultati mi davano energia, mi facevano sentire grande, e indipendente.
Ogni tanto andavamo ad allenarci in un campo di cavoli, e per evitare di pestare i cavolfiori dovevi fare le andature.
Ginocchia al petto, calciata, saltelli: se colpivi un ortaggio finivi fare i conti con il padrone del campo, che non era sempre incline al perdono per direttissima.

Le soffrivo tutte tantissimo, quelle ripetizioni “strane”, e allora mi hanno fatto provare la marcia, che con il suo essere tutta all’altezza della terra mi sembrava decisamente più facile.
Forse era “più facile” soltanto per me, che comunque non avevo idea di quanto sacrificio mi avrebbe poi richiesto, negli anni a venire.
Nella marcia emerge tutta la mia sana incoscienza prestativa, quel flusso ininterrotto di attimi in cui non esiste altro all’infuori di me, e del mio gesto.
“Tu vai forte perché non pensi a nulla”: me lo dicono spesso, e forse è vero, perché quando mi metto in moto non riesco a sentire altro che il mio corpo.
Voglio sentire le mie gambe.
Voglio sentire le mie braccia.
Voglio sentire il fiato che risuona nel silenzio della mia testa, e chi mi accompagna fino al traguardo, che voglio attraversare senza aver conservato neppure la più piccola riserva di energia.
Voglio esserci soltanto io, senza neppure le mie avversarie, perché se no, finisco con l’inciampare nei miei pensieri.

Come è successo, per esempio ai Mondiali di Doha.
Arrivavo dal bronzo di Londra 2017, e quando tutto ciò che prima mi riusciva ha smesso di funzionare, mi sono ritrovata faccia a faccia con il fallimento e la paura. Non facevo altro che ripetermi che un atleta top deve essere “al top” sempre , e non può sbagliare mai.
E meno riuscivo ad esprimermi e più mi sentivo responsabile per chi credeva e investiva su di me. Più mi incastravo nei pensieri e più il corpo si rannicchiava su se stesso, lasciandomi sola a combattere le ombre.
Poi, mentre da infortunata ero costretta a guardare le altre allenarsi e migliorare, ho capito che non marcio soltanto per dire qualcosa, lo faccio anche per me.
Per me come persona.
E tutto è cambiato di nuovo: ho imparato a non pretendere sempre troppo dal mio corpo, ma ad aiutarlo ad esprimere tutto quello che ha.
Oggi.
Niente di più, niente di meno.
Un’idea semplice che mi sono portata poi anche in Giappone.

Perché alla fine, tra un quarto posto e un oro olimpico la differenza sta tutta nel rumore.
Assente, dopo Rio.
Assordante, dopo Tokyo.
La marcia ha sempre la stessa cadenza, e nelle motivazioni di chiunque batte comunque un’identica nota.
Ma quando sono tornata al campo la prima volta dopo aver vinto le Olimpiadi, ho trovato una fila di ragazzi e di ragazze che erano lì per iscriversi alla squadra, e per provare la marcia.
Molte, tra le bambine, guardavano i maschietti con aria di sfida, e quella per me è stata la medaglia più importante, perché so che per i cambiamenti ci vuole tempo, e noi, marciando, il nostro lo facciamo.
E soprattutto so che lamentarsi non serve a nulla, anche se hai ragione.
Antonella Palmisano / Contributor