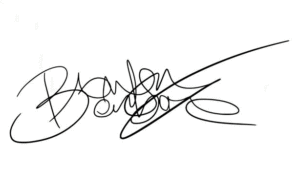Dico sempre di avere la memoria corta. E forse è vero.
Però le cose che riescono a tornarmi in mente hanno la forza per scorrermi davanti agli occhi come se fossero le immagini di un film, le posso mettere in pausa e rimandare indietro tutte le volte che voglio.
Tra tutte queste la mia pellicola preferita, quella di cui ormai ho consumato il nastro a furia di riavvolgerlo, è quella della mia primissima partita in assoluto.
Il paese dove sono nata è il classico esempio virtuoso della provincia italiana: poche persone che si conoscono tutte tra di loro, una comunità unita, nella quale i nomi dei propri compagni di scuola contano più dei loro cognomi.
I miei primi calci al pallone li ho tirati lì, più precisamente nel cortile sotto casa, insieme a mio fratello e a mio padre, che sono appassionati da sempre di quella palla di cuoio che poco più tardi rispetto a loro avrebbe stregato anche me.
Iniziai a seguire mio fratello al campo sportivo per poterlo guardare mentre si allenava con la sua squadra. Erano le prime esperienze di calcio organizzato per lui, i primi approcci di una lunga infanzia poi spesa tra le mura sacre dello spogliatoio.
Lo spogliatoio: la seconda casa di chiunque nello sport ci mette l’anima sul serio.
Nel tragitto verso il campo per ogni suo passo dovevo farne tre visto che non solo ero piccola d’età ma anche piuttosto esile. Una volta arrivati mi mettevo seduta composta sugli spalti, con le gambe penzoloni sopra i gradoni di cemento, e lo guardavo ammirata. Ci ho passato letteralmente le ore.
Avevo 3, 4 anni al massimo, e i miei pomeriggi trascorrevano con gli occhi incollati al prato, attratta da un desiderio di giocare fortissimo ma ancora muto a cui qualcuno molto presto avrebbe provato a dare una voce. Il primo a provarci fu l’allenatore di mio fratello che un giorno si avvicinò a quel mucchietto di ossa che non si perdeva un allenamento e mi chiese se non ero stufa di guardare gli altri giocare, se non fosse giunto il momento di provarci in prima persona.
Sono entrata in campo e, da allora, nessuno è più riuscito a farmi uscire.

Quell’anno ero sotto-età persino per la primissima categoria della scuola calcio e non potevo prendere parte alle partite, mi limitavo soltanto ad allenarmi insieme agli altri durante la settimana.
Mettevo un parastinchi di quelli con la cavigliera integrata, che si usavano una volta, ma anche la misura più piccola tra quelle che si trovavano in commercio mi andava enorme, il piede ci ballava dentro e, a volte, la protezione arrivava quasi alla coscia, impedendomi di piegare per bene il ginocchio.
Ero uno scricciolo, un fagottino di vestiti, parastinchi e di capelli, che tenevo lunghissimi e ricci. Mi riconoscevi anche da un chilometro di distanza.
Dopo una stagione passata senza giocare le partite, all’inizio dell’anno successivo, è arrivato il gran giorno dell’esordio e tutto ha preso una piega diversa. La prima, vera, sliding door della mia esistenza.
Fino a quel momento, e anche dopo di quello, la mia unica compagna di spogliatoio era stata la mia mamma. Mi accompagnava sempre lei infilandosi con me nello stanzino dedicato agli arbitri nel quale mi cambiavo, per assicurarsi che mettessi la maglia dal verso giusto e stringessi a sufficienza i lacci delle scarpette.
Ero la sola bambina di quel gruppo, sarei rimasta l’unica per tantissimo tempo e, per quanto i bambini siano un po’ più democratici degli adulti, io comunque non vivevo molto dentro lo spogliatoio dei maschietti.
Non mi era mai pesata quella piccola distanza, spessa quanto il muro che divideva le due stanze, non ci avevo neppure fatto caso forse, loro erano semplicemente i miei amici e io, con loro, giocavo a calcio e mi divertivo come una matta tre volte a settimana. Che la palla non ha sesso e non ha neppure età.

Nel giorno dell’esordio però c’era qualcosa di diverso.
Dentro la mia divisa un filo troppo grande, con i capelli sbarazzini, sulla passeggiata di cemento che portava dallo spogliatoio al campo io mi sono bloccata.
Ho visto tutti gli altri bambini schierati ordinatamente a centrocampo. Sugli spalti c’erano un gran numero di mamme e di papà, e quelli sul prato improvvisamente non erano più soltanto degli amici ma erano diventati, magia delle magliette ufficiali da partita, i miei compagni e i nostri avversari.
Erano tutti maschi ed io mi sono accorta solo in quel momento, per la prima volta dopo mesi, di essere l’unica femmina.
Ho puntato i piedi a terra, ho assunto la postura a braccia conserte, tipica di chi non vuol sentir ragioni, e mi sono abbandonata ad un pianto disperato:
“io in campo non ci entro”.
Ci ha provato l’allenatore, “in fondo ti sei sempre divertita” diceva, ma niente da fare.
Ero una bambina, avevo i capelli lunghi e non potevo neppure essere confusa con gli altri, tutti avrebbero guardato me e quindi no, nessun dubbio: non avrei giocato.
Poi, quando ormai gli altri bambini in campo iniziavano a spazientirsi, che la pazienza di un bambino è quanto di più fragile esista, è sceso il mio papà.
Non devi avere paura.
Pensa a quando giochi giù in cortile.
Fidati: è lo stesso identico gioco.
È lo stesso identico gioco.
Quella partita, dopo aver asciugato i lacrimoni nella manica troppo lunga, l’ho giocata tutta ed è stato l’inizio di una storia d’amore che mi ha portato davvero molto lontano e che non accenna neppure lontanamente ad affievolirsi.
È lo stesso identico gioco, quello di sempre e magnifico, anche se cambia la cornice del disegno ed è diventato ormai un affare per bambini molto cresciuti.
Essere bambina prima e donna poi, in un posto che cento anni di tradizione hanno descritto e raccontato come un inviolabile tempio maschile, porta con sé un carico emotivo straordinariamente potente, equamente ripartito tra difficoltà da superare ed energia rivoluzionaria.
O ti adegui e molli oppure lotti per cambiare le cose.

Fuori dal mio spogliatoio di bambina, lontano da quegli amici che erano anche i miei compagni, vivevo le sfide più complicate da gestire. Quando giravo per il paese con il pallone sottobraccio a volte qualcuno provava a togliermelo, “non è roba adatta ad una bambina”, ancor di più se prova a giocare insieme ai maschi.
Ho dovuto sentire dei commenti sciocchi, fatti da alcuni genitori presenti alle partite, che troppo spesso nelle giovanili si trasformano in dei veri e propri capi curva, incuranti del fatto che a me, come ad ogni bambina del mondo probabilmente, interessasse solo divertirmi.
Curiosamente però un paio di gol mettevano sempre tutti d’accordo.
È la dittatura del pallone, che sopravvive ai pareri della gente e alle maree delle mode: chi lo tratta con i guanti e gli sa dar del “tu” decide anche per tutti gli altri.
Perché si tratta sempre, e comunque, dello stesso identico gioco.
Anche oggi lo è.
Oggi che è diventato il mio mestiere pur non essendo ancora il mio lavoro.
Il professionista è tale perché così si comporta, non perché c’è un’etichetta che lo certifica e il nostro è un pianeta che non conosce giorni vuoti e mal digerisce i black-out.
Un atleta oggi deve essere maniacale nella cura dei dettagli per riuscire ad emergere.
Sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno, dal riposo all’alimentazione: più che portartelo a casa è che ci vivi proprio dentro, al tuo mestiere. E per me è sempre stato così.
Già quando ero in seconda media, per esempio, giocavo con gli esordienti ed ero talmente vogliosa (e meritevole) di stare in campo che facevo la partita del sabato, con i pari-età, da attaccante esterno e il giorno seguente invece facevo il terzino per la squadra dei ragazzi più grandi. Ogni weekend, io non aspettavo altro.
Dalle strade di periferia e dai campetti con più terra che prato per arrivare fino allo Stadium, che quest’anno siamo riuscite a riempire per intero, di strada ne va percorsa parecchia. Serve una rivoluzione di successo e di questo vado enormemente fiera.
La cornice del mio mestiere preferito è cambiata in maniera radicale ed è stata la consapevolezza del fatto che il gioco sia sacro così com’è, a prescindere da dove venga giocato, che mi ha permesso di mantenere sempre vive le cose in cui credo di più: l’allegria nel lavoro, la qualità nel lavoro e la convinzione che pensare positivo valga quanto allenare la tecnica individuale.
Ovviamente, come accade in tutte le cose che cambiano, alcuni momenti sono più indelebili di altri, certi istanti restano impressi nella memoria con un vigore impareggiabile.
Perché le conquiste non si devono contare ma pesare.
Che non sono tutte uguali.
Nella settimana che ha preceduto la partita di campionato con la Fiorentina i numeri si rincorrevano come le palline di un flipper andato in tilt.
Venduti 5 mila biglietti.
No: 10 mila.
Aspetta: siamo a venti.
Fino al punto in cui era chiaro a tutte che lo avremmo riempito per intero.

© Paolo Miccoli - GetSportMedia
Ho pianto sul pullman che ci portava allo stadio: lacrime di emozione, di puro e semplice orgoglio. Forse persino lacrime d’incredulità perché nulla del genere si era mai visto in Italia e non puoi mai avere la certezza di essere in grado di fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima.
Il nostro era un movimento che fino a pochi anni prima faticava ad emergere, ottenendo quella visibilità che avrebbe meritato da sempre. Ricordo partite, partite importanti, giocate davanti a poche manciate di spettatori. Ricordo il mio esordio con la maglia azzurra in Grecia, nel 2012, consumato in uno stadio di periferia, snobbato dalla stampa e dai tifosi. Sembra essere trascorsa una vita intera.
Invece sono passati solo pochi anni, durante i quali il lavoro di tante persone e l’intuito di pochi visionari, sono riusciti a mettere il calcio femminile al centro del villaggio. E nessuna di noi ha intenzione di fare marcia indietro, anzi.

© Paolo Miccoli - GetSportMedia
A giugno ci giocheremo un Mondiale, competizione dal fascino unico, capace di bloccare tutto il mondo calcistico per un mese e dalla quale mancavamo da davvero troppo tempo. È evidente che le esperienze straordinarie che abbiamo vissuto durante questa stagione io e le mie compagne ci permetteranno di arrivarci pronte, abituate ad un carico di pressione che non più tardi di 12 mesi fa avremmo fatto maggiore fatica a gestire.
A chiunque me l’abbia chiesto di recente io ho sempre risposto che noi, in Francia, ci andiamo con l’idea di vincere la competizione, che è il nostro naturale obiettivo. Molti rimangono di stucco, altri mi prendono per matta, ma io, che matta non lo sono ancora diventata, lo dico credendoci sinceramente.
In fondo chi può dire quali siano i nostri limiti?
Quante tra di noi e quanti tra di voi avrebbero avuto la forza di immaginare tutto questo qualche stagione fa?

© Paolo Miccoli - GetSportMedia
Anche questo infatti partecipa a rendere uniche le rivoluzioni: nessuno può sapere con certezza quando e se si fermeranno. E io, di questo palazzo, quando guardo all’insù, ancora non vedo il soffitto.
Quindi penso positivo e soprattutto parlo positivo, a pienissimi polmoni, perché il nostro futuro lo modelliamo così: con le parole, con i fatti e con l’amore verso lo stesso identico, e magnifico, gioco di sempre.
Barbara Bonansea / Contributor