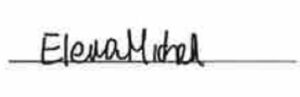Nel parlare della mia disciplina, le reazioni possibili, ormai, le ho viste praticamente tutte.
“No, ma che cos’è?”
“Ah sì, ma sai che conosco Daniele Masala?”
“Bah, mi sembra davvero una roba assurda”
“Figata! Cioè tutto insieme? Nella stessa gara?”
“A me questi nuovi sport non piacciono per niente!”
E non importa se poi ti metti lì, con pazienza, a spiegare cosa sia davvero il pentathlon moderno, che cosa rappresenti, o se ti metti a raccontare di come “no, non è uno sport “nuovo”, ma è nato proprio per volere del Barone, è nato con De Coubertin”, ed è (anche) per questo che non esce dai sofisticatissimi (e importantissimi) radar Olimpici.

Non che non ci abbiano provato, a cambiarlo, a frantumarlo, a distruggerlo.
Questo no: è sempre sulla bocca di tutti.
Perché nel corso degli anni, col passare delle edizioni, la discussione sul valore e sulla sostenibilità del nostro sport, si è fatta sempre più rumorosa.
Sempre più presente.
Sempre più amara.
Ogni pentatleta del Pianeta sente le polemiche. In superficie e dentro di sé.
Le abbraccia.
Le accoglie.
Le assorbe, con la stessa grazia con cui, per gran parte della sua vita, ha probabilmente parato i colpi di chi non ne riusciva a capire il senso, a cogliere la bellezza, oppure ad apprezzare la grande storicità.

È un limbo di amore e odio, tra passato e futuro, dove un ponte sottile ed esposto ai venti, collega mondi ormai lontani, ideati e cresciuti in epoche tremendamente distanti.
Da un lato c’è il passato, che è il passato glorioso di una disciplina che in realtà ne racchiude cinque, tutte con un proprio significato intrinseco, la corsa campestre, la scherma, il nuoto, l’equitazione e il tiro a segno; una disciplina che seleziona il meglio di tutte, che lo riassume, e che mette l’atleta di fronte all’ultimo esercizio di equilibrio, il più complesso e insindacabile, dove far confluire forza e destrezza.
Sensibilità e resistenza alla fatica.
Precisione e furia agonistica.
E dall’altro, invece, c’è futuro, il moderno, da non intendersi più, però, come contrapposizione all’antico, ai Giochi dell’antica Grecia, proprio come dice il nome, ma in senso lato, in senso di contemporaneo.
In senso di sport che deve essere per forza televisivo.
In senso di sponsor, di numeri.
Di denaro.
Sono due mondi che vivono nel riflesso reciproco, costantemente.
Eppure sono anche distanti l’uno dall’altro, e fanno fatica a dialogare, perché allontanati, giorno dopo giorno, dalle loro più intime strutture e necessità.
Finché arriverà il giorno in cui, in quello stesso specchio, uno dei due diventerà soltanto un puntino irriconoscibile, dimenticato dagli altri.
E anche restando attaccati, con le unghie e con i denti a questa narrativa a Cinque Cerchi, non è difficile immaginare a chi toccherà la sorte più dura.

E nel mezzo di questo guado, in questo spazio, restano gli atleti.
Quelli di ieri, quelli di oggi e soprattutto quelli di domani.
Ragazzi e ragazze che come me, un giorno, si sono innamorati di questo magnifico sport, e non si sono più voltati indietro.
Perché questa, forse, è la cosa più vera che io abbia appreso in una vita passata nel pentathlon e con il pentathlon: che quando qualcuno lo conosce, lo conosce davvero, se ne innamora sempre.
Sempre e per sempre.
Il 100% delle volte.
Proprio come è capitato a me.

C’è un modo di dire, nel pentathlon moderno, che suona un po’ ironico e un po’ no.
Che dice un gran pezzo di verità, senza però dirla tutta quanta.
E cioè che i pentatleti sono, per lo più, dei nuotatori mancati.
Gente che si è buttata in piscina, e che quando ha capito di essere brava, ma non brava abbastanza per eccellere davvero, ha dirottato tutte le proprie forze e aspirazioni su uno sport più di nicchia, più elitario, in cui fosse più semplice arrivare in alto.
Ed in effetti, c’è tutta una fetta di atleti che al pentathlon è arrivata davvero così.
Ma io no.
E per qualche ragione profonda, che sento essere a metà strada tra un motivo tecnico e uno più sentimentale, sono felice così.
Io sono cresciuta in una famiglia che del pentathlon si è innamorata tutta.
In blocco.
Completamente e selvaggiamente.

Vicino casa c’era un piccolo centro sportivo, con la piscina, i campi da calcio, quelli da tennis, con le squadre di nuoto sincronizzato, di volley e molto altro ancora.
E quando l’istruttore della società ha fondato la Polisportiva Lazio, dedicata unicamente al pentathlon moderno, io e i miei fratelli, ancora bambini, ci siamo buttati dentro con tutte le scarpe.
Con la rincorsa.
Senza più cambiare idea.
Un po’ perché in famiglia siamo tutti, fieramente, laziali. E ok.
Ma non sarebbe comunque durata se io, Roberto e Giorgio non avessimo subito perso la testa per questa disciplina così unica: completamente diversa da qualsiasi cosa avessimo potuto provare, prima o dopo di essa.
Uno sport che ci ha cementati l’uno con l’altro, regalandoci uno spazio comune, capace di appassionarci, di unirci, di renderci, se possibile, ancora più fratelli.

Quando mi guardo indietro, in qualsiasi ricordo felice di famiglia, il pentathlon c’è.
Il punto di contatto.
Il motivo del tragitto o della discussione, della gioia o della tristezza.
Come quando, in macchina, con i nostri genitori, stretti tutti e tre sul sedile posteriore, litigando per chi avesse diritto alla proprietà di un finestrino piuttosto che l’altro (e guai, a guardare fuori dal “mio” finestrino) c’era sempre una gara di pentathlon alla fine o all’inizio del nostro viaggio.
O come quando, ancora oggi, dopo una gara, di qualsiasi livello, dalle Olimpiadi al campionato italiano, ognuno di noi sente e amplifica al cielo le emozioni dell’altro.
Festeggia il buon piazzamento.
Soffre per il fallimento.
Ancora oggi, la mia famiglia funziona “intorno” al pentathlon.
Alla sua poesia.
Alla sua magnifica forza aggregante.
Una potenza che mi ha fatto crescere e mi ha definita, e che rappresenta una parte fondamentale del mio essere.

Certo, adesso è tutto diverso.
Adesso ci sono i titoli mondiali e la qualifica olimpica, forse la gara che più mi ha emozionato, in tutta la carriera: il giorno in cui ho sentito davvero di essere capace di grandi cose, a prescindere dal contesto. Dal contorno. Dallo stato di forma.
C’è quel filo sottilissimo che unisce la pressione e la felicità, di fronte alla prospettiva dei Giochi di Parigi, delle medaglie, del successo.
Di quello che potrei, dovrei e vorrei ottenere.
Eppure, sotto-sotto, continuo a sentire che il mio compito, il mio vero compito, sia ancora quello di divertirmi e di fare tutto il possibile per raccontare questo bellissimo sport agli altri. Nonostante le reazioni, a volte, siano ancora di stupore.
Finché esisterà.
Finché esisterà in questa forma.
Finché sarà una porta sul passato.
E finché crederò che sia un modo stupendo di unire le generazioni, io sarò qui.
Elena Micheli / Contributor