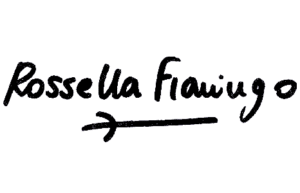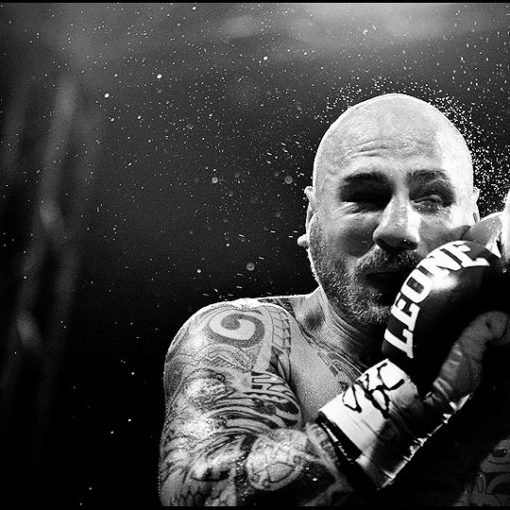Ho iniziato a tirare di scherma a sette anni.
A dire il vero mi sarebbe piaciuto farlo anche prima ma mi dissero che ero troppo esile e consigliarono di aspettare ancora un po’. A chiedermi di pazientare fu colui che poi sarebbe diventato il mio maestro e che oggi, tanti anni dopo, lo è ancora.
Siamo cresciuti insieme io e lui, muovendo i nostri primi passi, io sulla pedana e lui come allenatore. Dalle prime lezioni di una bimba fino alle Olimpiadi, è qualcosa di raro e sono una delle pochissime a poter dire di avere avuto questa fortuna.
Il maestro, nel nostro sport, va ben oltre l’essere un semplice insegnante.
Durante tutto l’arco della nostra scalata è stato difficile trovare il tempo di fermarci a riflettere sulla portata di questo viaggio straordinario perché c’è sempre qualcosa davanti. Una competizione, un obiettivo, un evento che calamita tutte le tue energie.
Ma quando riusciamo a respirare un po’ e ci prendiamo un attimo per guardarci alle spalle, il percorso assume davvero i contorni di un magnifico miracolo siciliano.
Quando mi presentai in palestra per la prima volta lo feci in parte per il desiderio di seguire l’esempio di mio fratello, che aveva iniziato con il fioretto, e in parte per un piccolo desiderio di ribellione.
Avevano portato a scuola dei volantini che invitavano i bambini a fare attività sportiva. Ce n’erano di due tipi: la scherma e la ginnastica artistica. Ricordo perfettamente la maestra chiedermi di aiutarla nel distribuirli:
dai questi alle femmine e quest’altri ai maschi
All’epoca si ragionava ancora così: sport da ragazzi da una parte e sport da ragazze dall’altra mettendo, magari involontariamente, un’etichetta sopra alle aspirazioni e ai talenti dei più piccoli: “lascia stare questo che non fa per te”.
Per fortuna oggi non esiste più lo sport di genere.
Esiste solo lo sport e basta e questa è una conquista per tutti, non soltanto per quelli che in passato venivano guardati storto per colpa delle proprie passioni.

© Olfa Pignataro
Ironia della sorte, dopo un paio di stagioni trascorse ad alternare si due sport, nella palestra smisero di fare la ginnastica e non mi rimase altro da fare che buttarmi a capo chino sulla pedana. Una fortuna.
La mia prima arma è stata il fioretto di plastica. Si inizia tutti da lì perché è l’arma “dell’esercizio”, quella che, più delle altre, ti permette di focalizzarti sullo studio della tecnica. Di imparare. Poi, crescendo è l’arma che sceglie te e non viceversa.
In Italia esistono diverse scuole e la tradizione, si sa, è qualcosa da rispettare e da tener presente. La spada si preferisce al sud, il fioretto al nord e le migliori scuole di sciabola sono al centro. Una divisione che rispecchia anche il carattere delle nostre terre.
La sciabola è istinto allo stato puro ed ogni assalto si decide in pochissimi secondi.
Lo spadista invece è più riflessivo e gli incontri assomigliano ad una partita di scacchi.
Il fioretto è una via di mezzo tra le due, e padroneggiarlo rappresenta la perfezione dell’esecuzione tecnica.
Nella scelta di un’arma c’è parte del racconto dell’atleta che la impugna. C’è la sua indole, il suo approccio alla disciplina e allo sport.
Io e la mia spada siamo una cosa sola, ci capiamo a meraviglia.
La scherma è diventata presto il mio sport preferito, il solo che riuscisse a smuovermi qualcosa dentro e la sua massima espressione la si poteva osservare solamente all’ombra dei 5 cerchi.
Non ero ancora una “fissata”, forse non lo sono mai diventata, ma le Olimpiadi per me potevano significare soltanto: scherma, medaglie, gloria eterna.
Ricordo l’edizione di Atene 2004, con l’oro della Vezzali e l’urlo di gioia pazzo di Aldo Montano per il trionfo nella sciabola. Immagini indelebili della storia azzurra, istanti che non scorderò mai.
Ma il momento in assoluto più emozionante vissuto davanti alla tv è stato, senza ombra di dubbio, il successo di Tagliariol a Pechino 2008. Una spada italiana sul tetto del Mondo e io, che le Olimpiadi cominciavo a sognarle la notte, mi dissi che 4 anni più tardi, a Londra, sarebbe toccato a me.
Nel 2010, a metà strada nel nuovo quadriennio olimpico, che è il solo calendario che un atleta riconosce, ho iniziato a raccogliere risultati importanti. Avevo ancora l’età per essere una under 20 ma combattevo già con le grandi e ho cominciato a sperare in un passaggio che mi trasformasse da spettatrice olimpica a protagonista in pedana.
Il successivo Mondiale di Catania, che ha avuto un sapore speciale per me, da sempre così legata alla mia amata Sicilia, mi ha proiettato definitivamente nella scherma che conta ed una serie di podi, raccolti nei mesi successivi, mi sono valsi la qualifica per Londra 2012.

© Olfa Pignataro
In quell’edizione sono stata la più piccolina di tutta la scherma presentandomi all’evento da mezza sconosciuta, soprattutto rispetto ai campioni straordinari che la nostra nazionale poteva schierare.
Durante la cerimonia d’apertura ricordo di essermi sentita letteralmente al centro del Mondo quando la nostra delegazione è entrata allo stadio.
Un urlo pazzesco, un boato capace di farmi venire immediatamente un vuoto allo stomaco.
Davvero i calciatori sentono una scossa del genere ogni weekend
mi sono chiesta.
Ero estasiata.
La competizione in sé mi ha lasciato un po’ di rammarico, perché pur essendo la più giovane mi sono fermata ad un soffio dal podio, sconfitta ai quarti dalla cinese Sun negli ultimissimi secondi del minuto supplementare. Sarebbe bastata una stoccata in più, uno spostamento minimo e avrei potuto scrivere, già da quella edizione, una storia differente.
Ma non era il momento, a quanto pare.
Le vittorie arrivano sempre quando sono mature al punto giusto, competere per vincere è come raccogliere una bella arancia: non basta la voglia di allungare la mano, a volte serve anche la pazienza di saper aspettare che il sole faccia il suo lavoro.
Quella sconfitta mi ha aiutato molto negli anni successivi.
Mi ha aiutato a crearmi una mentalità vincente, a diventare feroce e più precisa, incapace di scendere sotto i livelli di eccellenza assoluta.
Senza quella sconfitta a Londra non credo che avrei vinto il Mondiale del 2014 e quello del 2015, diventando la terza spadista nella storia a raccogliere questo prestigioso traguardo.
Le sconfitte servono eccome.
Per quanto possano sembrare lunghi, quattro anni volano via in un istante.
Se la tua vita sportiva si misura in numero di Olimpiadi, come accade nella scherma, credetemi, il tempo scivola velocemente tra le dita e non si può far nulla per farlo rallentare. All’improvviso ti ritrovi nuovamente all’inizio di uno sprint a cinque cerchi, sul rettilineo finale, quando ancora è caldo nella tua testa e nel tuo cuore il ricordo di quello precedente.
L’olimpiade è un frullatore, che consuma tutto, che attira a sé tutte le cose importanti, tutte le fatiche e i sacrifici. È una stella cometa appena fuori dalla punta del naso degli atleti, stiamo tutti guardando lì e chi si distrae per un istante rischia di perderne la scia.
A Rio 2016 sono arrivata con uno spirito completamente diverso.
Ero più matura, molto più consapevole dei miei mezzi. I risultati raccolti nelle stagioni precedenti avevano lo strano effetto di rendere più serena me ma allo stesso tempo più frizzante l’ambiente circostante, che si aspettava una medaglia d’oro.
A volte la dava persino per scontata, senza tener conto che nella scherma, e nello sport, non esiste nulla che sia vero a prescindere.
Quattro anni prima, a Londra, avevo fatto dell’essere una semi-sconsociuta la mia forza principale vivendo tutta l’esperienza come una specie di guerra sportiva. Una spedizione senza domani, da vivere in apnea, concentrata solamente sul provare a fare qualcosa di grande e di inatteso.
A Rio ero già diventata una donna diversa, notevolmente più esperta e per questo sono riuscita a godermi di più il clima di festa che si respirava nel villaggio. Il mio equilibrio risiedeva nell’altalena tra: la fame agonistica, che mi monta sempre sotto pelle nell’avvicinamento alle competizioni, e la serenità interiore dei momenti passati fuori dalla pedana.
Nessuna di noi ha un interruttore alla base del collo che ti può mettere in modalità “gara” a piacimento, ma maggiore è il controllo che si riesce ad ottenere di questa specie di aggressività cosciente dei giorni precedenti alla gara e meglio si riesce poi ad esprimersi con la spada in mano.
Troppa foga e ti bruci, consumandoti nell’attesa.
Troppa tranquillità e non ti accendi più, neppure quando arrivi faccia a faccia con l’avversaria.

A Rio sono stata brava in questo.
C’era una grande pressione su di me, si aspettavano tutti che vincessi la duecentesima medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi e chiunque trovava il modo di ricordarmelo.
Io mettevo le mani avanti. Cercavo di spiegare che nella scherma non può esserci mai la certezza matematica di essere sul podio. Per nessuno. Perché la concorrenza è spietata.
La mia gara era in programma nel primo giorno di manifestazione e, per questo, mi sono persa la cerimonia d’apertura. Niente secondo boato da mal di pancia per me.
La giornata di gara è trascorsa serena, forse anche più serena del previsto, forte di un momento della mia carriera di totale convinzione ed equilibrio.
Fino alla finale.
Anzi: fino al punto dell’11 a 7 della finale contro l’ungherese Szasz.
Poi all’improvviso ho pensato.
Il mio cervello è uscito per la prima volta dalla maschera nel corso dell’intera giornata.
L’ha fatto per guardarsi attorno, respirare la grandezza del momento e chiedersi:
lo sto davvero facendo?”
E all’improvviso il mondo si è materializzato intorno alla pedana, non eravamo più soltanto io contro di lei, ma c’erano tutti lì a guardarmi.
C’erano le conseguenze di una vittoria e le conseguenze di una sconfitta.
Mi sono bloccata, ho avuto paura di vincere e ho perso.
La premiazione è avvenuta immediatamente dopo la finale e ricordo che non sapevo cosa dovessi pensare. Non sapevo se fossi autorizzata ad essere felice o se fossi invece tenuta a sentirmi delusa.
Il tempo mi ha spiegato che quel blocco avvenuto sulla pedana di Rio va visto come un segnale. Come un monito da tenermi dentro per i successivi quattro anni che, guarda caso, sono scivolati via in un baleno pure questi.
Ci sono cose, infatti, che non si possono insegnare, ma che s’imparano dall’insegnante universale: il tempo. E quello non conosce riassunti.
Nella scherma si raggiunge la piena maturità dopo i trent’anni di solito, perché in un duello con la spada più dell’irruenza della giovane può la memoria dell’esperta.
Essere stata precoce a livello di risultati mi ha sicuramente permesso di togliermi soddisfazioni grandi, ma il difficile diventa ripetersi.
Più sei giovane e più gare hai davanti agli occhi in cui puoi correre il rischio di sbagliare qualcosa. Serve avere pazienza e servono le spalle larghe.
Perché prima magari le cose accadevano da sole ed era tutto semplice, ora invece devi farle accadere tu e l’interruttore che fa questo si chiama esperienza.
L’esperienza, però, non si compra. Perché non la vende nessuno.

Io ci sto arrivando, piano piano, alla mia piena espressione, al mio massimo, ed inizio a pregustarmi quella che sarà la prossima avventura olimpica.
Tra pochi giorni parto per Tokyo, ci vado in vacanza.
Vado a vedere la città che tanto ha significato per ogni atleta del Mondo in questo quadriennio ma che quasi tutti quelli che andranno all’Olimpiade guarderanno da una prospettiva soltanto: quella del villaggio e degli impianti.
Io voglio di più: ne voglio un’immagine precisa in testa.
Vado per fare la turista, certo. Vado a riposarmi.
Vado per iniziare a respirare l’aria di un evento che spero mi veda grande protagonista.
Ma ci vado con il cuore leggero di chi sa che anche se dalle prossime Olimpiadi vuole una medaglia (e la vuole d’oro), è certa che non sarà quel pezzo di metallo a decidere se in Giappone si divertirà oppure no.
Perché di quello non ha alcun dubbio.
Questione di esperienza.
Rossella Fiamingo / Contributor