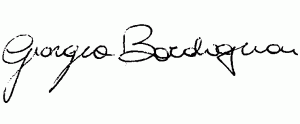Le aspettative altrui hanno il potere di farti dimenticare chi sei.
Basta un secondo, il tempo di un’alzata.
Il tempo di uno strappo.
Tra le mani callose ti passa un momento, magari di quelli da ricordare, per quanto è bello. E invece tu te lo scordi non appena si è spento, lo lasci scivolare via, accompagnato alla porta dalla voce degli altri.
Ci vuole una vita, e a volte non basta neppure quella, per capire che ciò che pensa la gente non definisce te. Definisce la gente.
Sulla pedana di Tokyo, appena è finita la mia ultima ripetizione, dalla gola mi è partito un urlo, che ha fatto tremare le pareti ed è risuonato nel silenzio di una stanza vuota come la mia pancia stracolma di farfalle. Quello stesso silenzio che aveva reso “mio” lo spazio di tutti, alla fine è stato squarciato da una voce potente.
Non sapevo di aver vinto una medaglia.
Non ancora.
Non mi importava neppure di aver vinto una medaglia.
Io ero felice per me.

Dopo mesi, dopo stagioni, dopo anni interi: ero finalmente tornata ad essere felice per me, e per una gara che mi aveva restituito tutte le mie ragioni, tutti i miei perché.
Avevo scordato cosa lo rendesse bello.
I motivi per cui mi metto per 4 ore sotto al bilanciere, caricandolo ogni giorno di più: un chilo alla volta su una scala senza traguardo. Avevo dimenticato cosa mi spinge a sopportare i dolori fisici, le articolazioni che scricchiolano, le cosce che bruciano, le ossa rotte.
Tutto scordato fino al giorno della finale Olimpica, un giorno talmente unico da correre il rischio di finire sminuito da qualunque parola usassi per raccontarlo. Allora mi lego ai fatti, quelli me li ricordo: la sola cosa che sono certa di saper mettere in fila dall’inizio alla fine.
La bellezza del Villaggio mi ha lasciato a bocca aperta, e come una bambina qualsiasi non facevo altro che chiedere a me stessa: “ma non si potrebbe vivere sempre così?”.
Un Villaggio permanente, che trascende il tempo e lo spazio, e che resta sempre con me.
Ancora oggi ho i brividi, e mi viene persino da piangere, perché in Giappone, nel momento più importante della mia carriera ho fatto la miglior gara della mia vita.
L’ho sentita dentro.
Ogni ripetizione, ogni alzata, ogni rotazione.
Per la prima volta ho avuto la sensazione di sapere esattamente cosa stavo facendo, fin nel più piccolo dettaglio. Tutto era al posto giusto, come un sistema solare, di cui ero al centro, in asse con il bilanciere, in asse con il passato e con il Mondo intero.
I Giochi oltre i Giochi.
Il successo oltre la medaglia.
La luce del sole, e il sole che ero io.

Ho gridato forte per celebrare la mia soddisfazione, non il risultato, che non conoscevo neppure. Ho gridato perché mi ero divertita. Ho gridato perché finalmente la mia mente e il mio corpo avevano realizzato un pomeriggio di armonia perfetta. Abbracciati l’un l’altra, pur nella loro diversità.
Il corpo controlla la tecnica, ed è il primo elemento fondamentale del sollevamento pesi.
Quella che esprime non è forza pura, come potrebbe sembrare.
È potenza, che, per realizzarsi, ha bisogno della velocità d’esecuzione.
Più vuoi essere veloce e più devi avvicinarti alla perfezione tecnica, perché basta anche la più piccola imprecisione per mandare all’aria una ripetizione, o addirittura per farsi male. La consapevolezza del gesto è una lotta quotidiana, che vinci o che perdi tutte le volte che entri in una palestra.
La testa invece è una questione completamente diversa, ed è grigia, come la materia che ci trovi all’interno. A volte è un’alleata, altre volte la tua peggior nemica, e si palesa sempre nel giorno più atteso, quando ne può essere un’assoluta protagonista.
Il pensiero e la paura sono i suoi due volti, che intervengono soltanto sulla gara, spesso in maniera incontrollabile, e che segnano la differenza tra una giornata-no e una giornata-si.
La paura striscia, il pensiero invece no.
La paura è irrazionale, il pensiero invece no.
Più sono diventata adulta e più la paura ha assunto un carattere nuovo, ed è entrata nella dimensione fisica, che sarà anche banale, ma non meno paralizzante.
Finisci col chiederti: “e se mi faccio male?”.
La sana incoscienza della gioventù si perde nel tempo, acciacco dopo acciacco, e può succedere, prima di iniziare, di visualizzare lo scenario peggiore.
Mentre il pensiero, invece, da coraggio, e costruisce convinzioni positive sulla base del lavoro che hai fatto per arrivare fin lì. Sulla pedana di Tokyo, per esempio, a rendere perfetto l’incontro di corpo e mente è stata una semplice frase, che, forse per la prima volta, mi è rimbalzata tra le orecchie all’inizio di tutto: “Non devo più dimostrare nulla a nessuno.”
Semplice.
Ma intoccabile.
A 34 anni, con la coscienza a posto e nulla da perdere, i miei astri si sono allineati, e tutto quello che ho fatto e che sono diventata, si è riassunto in una notte da ricordare.

Dentro quell’urlo c’era tutto il mio passato, arrivato finalmente al pettine, come un nodo che incontri proprio in fondo ai capelli.
C’era la bambina che faceva le gite in montagna con i nonni e che si stancava talmente tanto a portare su e giù il bob di plastica, da addormentarsi in macchina, sulla via di casa.
C’era l’adolescente che trovato la propria strada solo quando ha capito che il problema non può essere il bilanciere, perché quello pesa sempre uguale.
In quell’urlo c’era tutto il mio sport, che conosce tutto di me e che mi ha fatto conoscere tutto di me, insegnandomi la disciplina, la cura del dettaglio e la pazienza.
In quell’urlo c’era anche tutto il mio corpo, con i suoi muscoli in tensione e le sue forme così diverse da quelle che ho visto sui quotidiani e le riviste per una vita intera.
Ma soprattutto in quell’urlo c’ero io, che sono fatta da tutte queste cose.
Che sono bella e che sono forte.
Che ho paura e che ho coraggio.
Che ho anche una medaglia olimpica a casa, ma di quello mi sono accorta dopo.
Giorgia Bordignon / Contributor