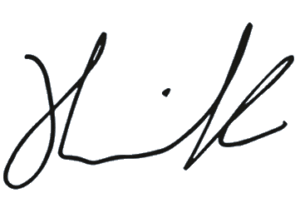Da piccolo non ero esattamente uno studente modello.
Non ero molto portato per lo studio e passavo la maggior parte del tempo con la testa appoggiata tra le mani, annoiato.
Con lo sguardo intento a spiare fuori dalla finestra e contando le ore che mi separavano al weekend.
Sì, perché nei weekend andavo a sciare, dal venerdì alla domenica, e quelle 48 ore spese a fare su e giù per la montagna davano un senso a tutto il resto della mia settimana.
Ero sempre triste la domenica sera perché era il momento più distante in assoluto dalla prossima gita sulla neve.
I miei genitori hanno sempre avuto una grande passione per lo sport e l’hanno trasmessa anche a me e a mio fratello Magnus.
Il loro obiettivo non è mai stato quello di creare dei piccoli-grandi campioni, ma piuttosto quello di farci crescere come brave persone.
O almeno di riempirci così tanto i pomeriggi da non lasciarci il tempo di fare cose stupide.
I risparmi di famiglia non venivano mai usati per vacanze esotiche, o per lunghi viaggi, ma erano le risorse che permettevano a me e Magnus di fare tante attività diverse durante l’anno.
E per un ragazzo attivo e pieno di energia come me, era la cosa più bella del mondo.
Bicicletta, corsa, sci, hockey, persino il motocross, uno sport che ho scoperto quando avevo 5 o 6 anni e che non ho ancora abbandonato, anche se ovviamente adesso lo faccio nei ritagli di tempo e stando molto attento a non prendere rischi.

Poi, crescendo, con lo sci, sono diventato talmente bravo da non dovermi più preoccupare di essere triste la domenica sera, perché i miei giorni erano diventate tutte domeniche.
Settimane intere passate sulla neve, mattina e pomeriggio, per costruire pezzo dopo pezzo la mia futura carriera da professionista.
Da quando sono diventato grande abbastanza per decidere che cosa valesse la pena di sognare, lo sciatore è sempre stato in cima alla mia lista.
Più che in cima: la sola opzione.
Volevo essere uno dei migliori.
A guardare indietro, nel passato, tutto potrebbe sembrare scontato, quasi inevitabile.
Ma l’universo non era obbligato ad avere un senso per me, è solo più facile credere nel destino quando qualcosa ha dato una forma precisa alla tua vita.
Sono stato un talento precoce, ho vinto tantissimo già nelle categorie giovanili e quando mi sono ritrovato a competere con i grandi non ho sentito alcuna differenza.
Almeno non in pista.
Che siano le Olimpiadi, la Coppa del Mondo o la Coppa Europa non c’è differenza per me.
Quando penso alla gara, io vedo una montagna.
Vedo l’impianto di risalita.
Vedo il cancelletto, le traiettorie e il cronometro.
Ho vinto tutto mantenendo lo stesso identico approccio: fai quello che devi fare, non commettere errori e passa la linea del traguardo.
Il resto non conta.
Tanto nel bene quanto nel male.

Non vuoi mai scendere sotto il giusto livello di adrenalina, non vuoi arrivare scarico, non vuoi sbagliare per colpa della tensione.
Allo stesso modo però devi anche sapere navigare a vista in mezzo agli alti e bassi della stagione, perché se vuoi stare in alto, devi andare a podio sempre, anche quando non sei al top.
Ogni giorno deve essere un giorno buono.
A prescindere da tutto.
Normalizzare la gara mi aiuta, la spoglia.
La rende semplice, anche se semplice, ovviamente, non è.
Nel momento esatto in cui inizi a pensare a tutto quello che circonda la competizione, tutto ciò che rende un weekend diverso dall’altro, ecco che perdi il focus e ti scordi delle cose pratiche.
E sono le cose pratiche a farti vincere o perdere.
La gara è solo una gara, e la neve è sempre neve.
Niente di più. Niente di meno.
Quando ho iniziato a sciare non immaginavo che sarebbe andata così, non credevo che tutto quello che circonda lo sci sarebbe stato così complesso.
Il mio sogno non è mai stato quello di essere famoso.
Ma quando passi il traguardo che ti rendi conto veramente di dove stia la differenza tra il grande palcoscenico ed il piccolo teatro di provincia, perché il circo dei media accompagna la carovana in ogni dove, e ne diventa quasi un pezzo.
A volte è un sostenitore, a volte è solo un impegno, a volte qualcosa a metà strada.

Quando ho vinto la mia prima medaglia olimpica avevo solo 19 anni e per quanto sapessi già sciare faccia a faccia con i migliori, non avevo ancora idea di come mi dovessi comportare davanti ai microfoni.
La verità ti colpisce dopo: al più alto livello, lo sport è intrattenimento.
E magari se fai, oppure dici, qualcosa di sbagliato finisci con l’intrattenere il pubblico più di quanto volessi, ma non proprio nel modo in cui avevi pianificato di farlo.
Parlare di sé crea un ponte, apre uno squarcio sulla vita privata, e ti prosciuga le energie, perché è come un patto verbale che si crea tra te e chi racconta di te al grande pubblico.
Tu gli affidi pezzi del tuo pensiero, frammenti di stati d’animo ed in cambio loro aiutano chi ascolta ad entrare in sintonia con la tua storia, a capirne il background.
Una volta arrivato in nazionale maggiore, per esempio, mi sono ritrovato in un ambiente nuovo, nel quale ho dovuto imparare tante cose.
Nelle prove tecniche non c’era nessuno che arrivasse nella top 30 in Coppa del Mondo, e io sono stato il primo dopo 10 anni a riportare la Norvegia sul podio e a vincere.
Per i ragazzi della velocità era tutto diverso, erano e sono tuttora una squadra fortissima, dinamica e completa, dove tutti si spalleggiano l’uno con l’altro.
Dove tutti si guardano le spalle.
Aksel Svindal, il nostro veterano, mi ha aiutato molto a capire come muovermi fuori dalla perimetro della pista, e la cosa più importante che ho imparato è che devo sempre cercare di essere onesto.
Con me stesso e con gli altri.
Perché la sensazione più bella in assoluto è riuscire a fare le cose alla propria maniera e anche perché lo sci, oggi, è tutta la mia vita, e nulla mi può rendere triste, la domenica, quando viene sera.
Henrik Kristoffersen / Contributor