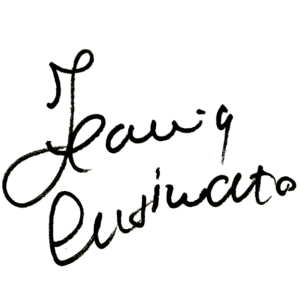Se sei una nuotatrice il tuo corpo è come un pezzo di carne.
Sempre sul bancone, così che tutti lo possano vedere.
Io amo il mio corpo.
Io odio il mio corpo.
Entrambe cose vere.
Entrambi pensieri che hanno il potere di prendere una mattina e di ribaltarla in un battito di ciglia. Come dal giorno alla notte.
A volte, star zitta è la mossa più comoda.
“Tanto” dici a te stessa “che differenza vuoi che faccia?”
Che ognuno combatta per sé.
E perda, magari.
La mia, di battaglia, è alle spalle, o almeno credo.
Non me ne voglio più preoccupare.

Poi, ci sono dei momenti in cui mi sento più forte di così.
Forte abbastanza da far qualcosa del mio dolore.
Mi guardo allo specchio, mi piace quel che vedo e trovo un motivo per uscire allo scoperto: fare coscienza.
Fare coscienza, perché chissà quante persone ci stanno passando e non riescono a parlarne.
In fondo anche io ho avuto bisogno di leggere una storia come la mia, per capire che avevo davvero una storia da raccontare.
Sono arrivata al Centro Federale di Ostia che ero solo una ragazzina di 16 anni, con tantissima energia in corpo e altrettanta leggerezza nella testa.
Quella non si ferma mai
pensava la gente.
Il mio primo, vero, collegiale di alto livello è stato un trauma.
Eravamo a Flagstaff, Arizona, per un periodo di allenamento in altura.
Tutte le altre erano delle fondiste, ma a quell'età è difficile realizzare queste piccole sfumature, ed è molto più semplice farsi travolgere dal contesto.
In mezzo a loro mi vedevo grassa, mi sentivo grassa.
Io ero grassa.
Ci vuol poco ad accendere la retorica dello spogliatoio.
Una battuta, un commento, gli altri che ridono.
Mi sembravano tutte, e tutti, così consapevoli, così adulti, nei comportamenti e negli atteggiamenti. Io ero agli inizi, e mi sentivo allo sbaraglio.

Sono iniziati così 2 lunghissimi anni di gravi disordini alimentari, che mi hanno ferita, che mi hanno portata all’esaurimento e che mi hanno messo di fronte ad una grande montagna da scalare, la più alta di tutte: chiedere una mano.
Capitava anche due, o tre volte al giorno, che mi sfondassi di cibo.
Il cibo mi faceva sentire piena. Soddisfatta.
Poi il vomito auto-indotto.
E il ciclo ripartiva.
Ero capace di spendere 60 euro in un’unica spesa, tutta di dolci, che poi consumavo come in un raptus, durante la sera.
Altre volte invece mangiavo pochissimo e vomitavo lo stesso, tanto era fragile l’equilibrio del mio corpo.
Un equilibrio che dipendeva principalmente dai numeretti che vedevo comparire sulla bilancia.
64, 66, 60.
Il mio terno sulla ruota di Ostia.
In base all’estrazione potevo avere picchi di isteria o di inattesa felicità.

Ho iniziato a vivere in una bolla, distante dalla realtà delle cose, in cui bastava una parola buona, un complimento ricevuto o negato, a cambiare il mio umore.
Il 2018 è stato il mio anno peggiore e la mia stagione migliore.
Ricordo quando, sul bordo vasca, sentivo un semplice: “Ilaria, sei in gran forma!”
Mi stavo consumando ma ero felicissima di quelle parole.
Il mio corpo aveva raggiunto un equilibrio tutto suo.
Fatto di nervi, di privazioni e di eccessi, ma il tutto stava, miracolosamente, in piedi.
Le storie degli altri, spesso, sono poco più che una statistica.
Quante persone hanno disturbi alimentari in Italia?
Quante intorno a me?
Come lo leggi l’hai già dimenticato, perché le battaglie altrui sono sempre quelle meno importanti.
Poi, a volte, succede che un dettaglio, un piccolo particolare del racconto, ti resti appiccicato tra le dita, come una zanzara che ti ronza vicino alla testa in un’afosa notte d’estate.
Qualcosa di crudo, o di schifoso, che non riesci a ricondurre all’indifferenza.
E quel dettaglio diventa la storia stessa.
Un pezzo di nuvola, un angolo di cielo che ti permette finalmente di capire che tutt’intorno è una tempesta.

Le cose che non dimenticherò, di quei tre anni, sono tante.
Ma due immagini in particolare mi tormentano al pensiero.
La prima è l’immagine riflessa, con il volto trasfigurato e il mascara sbavato, che, dopo aver vomitato, non riconoscevo più essere la mia.
L’altra è il secondo spazzolino che tenevo sempre pronto in bagno perché a furia di indurmi il vomito con le mani avevo tutte le nocche spaccate e incise dai denti.
Stufa di rovinarmi le dita, io che sono pure vanitosa, ho iniziato a infilarmi in gola lo spazzolino.
Nessuno sapeva. Quasi nessuno.
Sono una testarda, una zuccona, e farmi aiutare non era tra le opzioni contemplate.
Persino i miei genitori, tanto amati, erano all’oscuro di tutto.
Finché una persona a me cara, a cui avevo permesso di venire vicino, ha chiamato mia sorella e rotto l’argine.
Come una diga che crolla, ho raccontato tutto in un fiume di parole e sono tornata a casa.
Allenarsi lontano da un Centro Federale, nel nostro sport, cambia le prospettive.
Si è scritto molto del perché delle mie scelte, ma nessuno ha fatto terno.
I commenti, le chiacchiere e i giudizi affrettati fanno parte del processo.
Almeno in Italia.

Per anni sono arrivata al limite, senza mostrarlo mai, fino al punto in cui, guardandomi le spalle, ho visto che il confine l’avevo oltrepassato da un bel po’.
Ancora oggi basta un commento sciocco, o superficiale, sul mio corpo a farmi avere una crisi di pianto e mollare a metà un allenamento.
Il mio fisico sta riprendendo gli spazi suoi, al prezzo di un equilibrio nuovo, tutto da inventare.
Il bronzo agli ultimi Europei non sarà un granché, ma per me vale quanto vale un nuovo inizio. Imperfetto e pieno di eccitazione.
Tra tante peripezie e mezzi disastri ho vissuto un anno strano da quando ho lasciato il Centro Federale, ma è stato un anno tutto mio, e non è successo mai, neppure una volta, che al mattino non riconoscessi la persona riflessa nello specchio.
Fare coscienza è un primo passo.
Vale per me, vale per tutti.
Io amo il mio corpo.
Io odio il mio corpo.
Ed entrambe le cose sono vere.
Ilaria Cusinato / Contributor