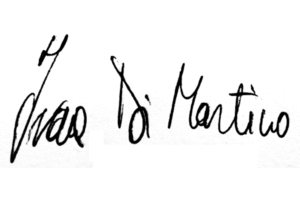La vita è un foglio bianco e non esistono cose che “vanno fatte” ma solo cose si decide di voler fare. Molte di quelle che incrociamo giornalmente rientrano nel gruppone delle cose che si dovrebbero fare, ma di questa categoria di solito si prende carico l’opinione pubblica, che decide per tutti. O che almeno prova a farlo.
Eppure nessuno ci sta davvero aspettando al varco con una pistola carica nel cinturone, nessuno decide per noi quali saranno le svolte da prendere di fronte ai bivi della vita. È tutta un’illusione, una costruzione scenica straordinaria, messa in piedi da coloro che desiderano provare a venderci qualcosa.
E spesso, quindi, ci ritroviamo ad inseguire un tipo di benessere che è inafferrabile per definizione, strategicamente appollaiato lassù, solamente ad un acquisto di distanza.
Ad una vacanza esotica di distanza.
Ad un follower di distanza.
La macchina dell’insoddisfazione perpetua che delude il venditore tanto quanto l’acquirente perché sono entrambi, in fin dei conti, ingranaggi dello stesso archibugio.
Poi capita di incontrare qualcuno.
Qualcuno che la pistola fumante l’ha avuta davanti ai propri occhi per davvero.
Qualcuno che ha vissuto faccia a faccia con la distruzione e non ha potuto fare altro che resistere per poi provare, se ne aveva le forze, a costruire di nuovo.
A chi viene diagnosticato il cancro non si offre mai una scelta.
Per davvero.
E nonostante tu un’opzione alternativa vera non ce l’abbia, devi trovare la forza di mentire a te stesso per convincerti che accettare la malattia è stata una tua scelta sincera, onesta. Pescata in mezzo al mazzo tra le altre.
Accettala o lasciati andare.
Bisogna accettarla, stringerla così forte da soffocarla nel tuo abbraccio.
Silenziarla. Sconfiggerla.
Cosciente del fatto che comunque vada quella diagnosi non scadrà mai, come se il dottore te l’avesse tatuata sulla pelle invece che scritta su un pezzo di carta, perché il cancro è recidivo.
Perché il cancro è infinito.
Finisci prima tu che la paura che lui ritorni.

Di donne che hanno fronteggiato la malattia ne ho conosciute moltissime in questi anni e di ognuna di loro rammento qualcosa, tanto delle vinte quanto delle vincitrici.
Un sorriso, il racconto, le lacrime o i pensieri.
Qualcosa di chiunque di loro.
Tutti parlano di resilienza oggi; va di moda.
Qualche anno fa era l’empatia, oggi invece è questa.
Parole grandi, che riempiono la bocca e saziano il cervello.
Frasi apparentemente nuove, talmente usurate da diventare frasi fatte, che piacciono ai maestri della comunicazione e ai luminari del marketing.
“Resilienza” è, prima di tutto, un prestito dal mondo dell’ingegneria: definisce la capacità di un corpo di resistere agli urti, alle forze esterne. È la sua abilità nel non rompersi, pur modificando sé stesso per assorbire tutto quello che gli viene lanciato addosso. O è resiliente o si spezza.
Prima che un fenomeno di costume, prima che una categoria di definizione psicologica, semplificata e incollata nel curriculum di tutti, la resilienza è qualità di un corpo.
Il corpo cambia durante la malattia: viene prosciugato, attaccato, scarnificato e reso fragile, come un ramoscello secco che balla in mezzo del vento. Cadono i capelli, si esauriscono le energie, si perde colorito e si fatica a fare qualunque cosa. Le persone che riescono a sopravvivere lo fanno uccidendo l’immagine che avevano di sé e abituandosi al nuovo riflesso restituito dallo specchio.
Sono lottatori e lottatrici.

E della loro resilienza e del loro coraggio io mi sono innamorata.
Me ne sono innamorata perché sono soliti riportare al Mondo quello che il dolore ha insegnato loro: che la vita è un foglio bianco e che non esistono cose che si “devono fare”. Esistono soltanto le cose che desideri fare e le cose che non hai voglia di fare; in quale delle due categorie investirai il tuo tempo è affar tuo, per il quale non potrai colpevolizzare nessun altro.
Quando queste persone guariscono escono dal torpore. Non soltanto quello fisico, indotto dalle medicine e dalle terapie, ma anche quello personale, figlio della società in cui sono cresciuti, e iniziano ad inseguire i loro sogni.
Ognuno a caccia delle proprie utopie professionali e umane.
La vita su questa terra è limitata: lo sanno tutti, ma loro lo sentono anche.
Passare il tempo con loro è sempre un momento di scoperta.
Per questo ho deciso di imbarcarmi in una nuova impresa: per passare del tempo con loro. Più di un’ora, più di un giorno, vorrei stare con loro un intero Everest.
L’Everest, una montagna leggendaria, simulacro delle vette personali di ognuno di noi. Simbolo di una conquista o metro di paragone di un fallimento:
sei pazza? è come scalare il monte Everest.

Oltre 8000 metri di altitudine, smembrati e ri-assemblati qui, sulle nostre montagne; partendo da Cortina, l’11 di settembre e arrivando allo Stelvio, non saprei dire con certezza quando perché i viaggi più soddisfacenti sono quelli dei quali il navigatore non riesce calcolare il tragitto in 5 secondi, vittima anche lui, per una volta, dell’imprevedibilità della vita.
Una corsa di più giorni, quindi, nella quale coprirò lo stesso dislivello del monte Everest accompagnata da un gruppo di donne coraggiose che hanno deciso di mettersi in gioco al mio fianco, dopo aver sconfitto vette ben più impegnative di queste.
Alcune lo faranno per brevi tratti, altri per intere tappe.
Corsa e cammino, solitudine e convivialità.
Tutto mescolato per colorare a nostro piacimento la pagina bianca dell’arrivo.
Unica certezza: taglieremo il traguardo tutte insieme, in parata.
Metafora semplice, e quindi perfetta, di una fatica atroce, affrontata per forza e conquistata per desiderio. Resa possibile grazie anche al supporto degli “altri”.
Un’impresa unica, faticosa, che spero mi possa aiutare a sostenere questi “altri”, nello specifico la Fondazione Umberto Veronesi, che è presente sul territorio a supporto di queste donne straordinarie. Ho avuto la fortuna di conoscere molte loro ricercatrici e di scoprire che quello che fanno tutti i giorni non è un lavoro, non è nemmeno un mestiere, è una vera e propria missione.
E quando ti innamori delle persone e delle loro convinzioni finisci sempre con l’innamorarti anche di quello che fanno.
Ivana Di Martino / Contributor