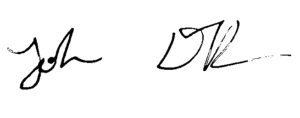Non tutti i club sono uguali.
Non tutti i club hanno la stessa storia, la stessa importanza, la stessa rilevanza per la propria comunità.
Il basket è bello ovunque.
Il basket è un messaggio di speranza ovunque.
Il basket è uno strumento sociale ovunque.
Ma in pochissimi posti diventa anche l’identità di una nazione, l’immagine di un popolo, un mezzo per tenere viva la storia.
Fino ai primi giorni della Seconda Guerra Mondiale, le divise del Maccabi Tel Aviv erano bianche e blu, come la bandiera di Israele. Poi, nel 1942, è stato inserito il giallo, il colore con cui oggi è riconosciuto in tutto il mondo.
È il colore della Stella di David: un gesto di solidarietà per tutti quegli ebrei d’Europea che erano costretti a portarla sopra ai propri vestiti, come simbolo delle loro origini, della loro fede da emarginati. Una toppa, che serviva per dire a tutti i altri cittadini che quelli potevano essere discriminati, umiliati, scherniti.
Il giallo del Maccabi Tel Aviv ha un peso diverso da tutti gli altri gialli del mondo, ed è per questo che lo vestiamo tutte le volte che ci viene permesso di farlo, tanto in casa quanto in trasferta. Tanto in Israele quanto fuori, perché tutti sappiano che il nostro cuore non dimentica, e che il ricordo del dolore non potrà mai svanire con esso.

Significa molto giocare qui, perché quello che fa il Maccabi in campo internazionale si riflette sull’intera nazione e su tutte le comunità ebraiche d’Europa.
Ovunque andiamo a giocare, in ogni palazzetto, è facile trovare delle grosse macchie gialle tra il pubblico: è la nostra gente, che a prescindere dalla passione per lo sport e per il basket, ci raggiunge al campo, per sostenere le proprie origini, per manifestare la propria appartenenza.
Il Maccabi Tel Aviv è più che un club, è un riassunto della Storia.
E con il suo carico emotivo arrivano anche le responsabilità, che non riguardano solo quello che succede in campo, ma che riguardano soprattutto il modo in cui si sta in campo.
L’attitudine.
L’umiltà.
La fierezza.
L’essenza di questa fede e di questa cultura vive in me fin dal principio, essendo il figlio dell’unione tra un italiano cattolico e un’ebrea russa. Sono cresciuto in Connecticut, come il perfetto risultato delle esperienze e della vita dei miei genitori.
Con papà celebravamo il Natale e la Pasqua, e andavamo in Chiesa la domenica mattina. Mentre con la mamma e il “suo” lato della famiglia, festeggiavamo il Passover, la Pasqua Ebraica.
Mi sono sempre sentito molto amato.
Ho avuto la fortuna di vivere entrambe le religioni e di comprendere che questa diversità è un dono, oltre che un’occasione da non sprecare.

Mio padre era più legato alla spiritualità di quanto non fosse mia madre, e per questo mi sono avvicinato più al cristianesimo che non all’ebraismo.
Poi, la vita, con i suoi modi creativi di mescolare le carte, ha voluto portarmi fino alle porte di Israele, quasi per costringermi a porgere omaggio alla storia dei miei avi.
Da sette anni vivo in uno Stato che si identifica con la propria fede, che è la fede della mia ragazza e della sua famiglia, con cui celebro le festività oggi.
Non ho perso contatto con le mie origini, con la Chiesa di mio padre e con il mio passato, ma entrambe le realtà vivono in me e nella mia quotidianità.
E credo che continuerà ad essere così per il resto della mia vita.
Sono entrambi pezzi della mia storia e del mio viaggio, che ha finalmente trovato la sua destinazione.
Da quando tiravo nel piccolo canestro di plastica della Fisher Price, con mio papà e il suo miglior amico, Cal, che facevano il tifo perché schiacciassi, al palcoscenico più importante d’Europa. Non è stato un percorso semplice.
È stata un’avventura, ma il bambino che ero non avrebbe mai accettato nulla di meno divertente.
Da piccolo ero un buono, avevo un buon carattere, o almeno questo è quello che i miei genitori preferiscono raccontare di me.
Ma non sopportavo l’idea di perdere tempo.
Non dormivo quasi mai, perché chiudendo gli occhi mi sembrava di rinunciare a qualcosa, qualcosa che potevo fare, oppure progettare, o anche solo guardare.

Un po’ di pazienza l’ho imparata in Spagna, alla mia prima esperienza al di qua dell’Oceano, quando ho dovuto convivere con la siesta.
Mi piaceva tutto della Spagna: il clima, la cultura, lo stile di vita. E anche se ero lontano dalla famiglia e non parlavo la lingua, mi sentivo comunque felice.
Mi stupiva però sapere che tutti, negozianti compresi, dopo pranzo facessero la siesta, e che se avevi bisogno di qualcosa in quel preciso momento del giorno, non potevi far altro che aspettare.
All’inizio era frustrante, poi ho imparato ad apprezzarla, perché è un modo per prendersi cura di sé.
Come ho imparato ad apprezzare tutto il basket europeo, adattandomi ai 24 secondi, rispetto ai 35 del college, e a convivere con una durezza fisica e mentale a me sconosciuta fin lì.
All’inizio non ho gestito bene l’aggiustamento con l’Eurolega, e ci è voluto tempo per tirare fuori il meglio di me.
Perché in Eurolega ogni singolo possesso conta, e il risultato di una partita può dipendere anche dagli aggiustamenti più piccoli.
Se in difesa sei un solo passetto indietro, o più lento degli altri, vieni punito sistematicamente. Ed è quella stessa debolezza che devi provare a capitalizzare quando la palla ce l’hai in mano tu.

È la seconda miglior Lega al Mondo, e il perché è visibile a tutti, in ogni singola partita.
Ed è la seconda miglior lega al Mondo anche perché in campo non ci vanno soltanto i giocatori, gli allenatori e i dirigenti.
Ci vanno intere città, intere regioni e, come nel caso del Maccabi, un intero popolo.
Un popolo che è il mio, da sempre.
E un popolo che con la mia pallacanestro spero di onorare, di raccontare e, in qualche modo, di proteggere.
John Di Bartolomeo - Maccabi Tel Aviv B.C / Contributor