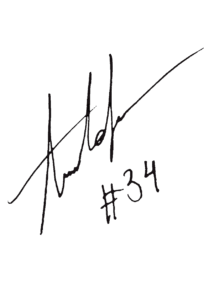Dopo quattro figli maschi, la mamma era molto felice che fossi arrivata io.
Poi ne sarebbero nati altri due, un maschio e una femmina, per arrivare a sette, ma quando sono venuta al Mondo io, ero la prima ragazza della famiglia.
E a mamma Margaret sarebbe piaciuto che mi comportassi di conseguenza.
Era molto protettiva nei miei confronti, gli piaceva che vivessi la casa, che la sentissi mia.
A me, però, piaceva stare all’aria aperta, piaceva correre.
A me piaceva lo sport.

Vivevo fianco a fianco con i miei fratelli maggiori, che sono nati tutti a pochissimi anni di distanza l’uno dall’altro.
Quella dei Kuier, oltre che una famiglia, è sempre stata anche una piccola squadra, mossa dalle sue dinamiche e dalle sue regole interne. Come uno spogliatoio: loro si proteggevano a vicenda, e poi tutti proteggevano me.
Almeno quando eravamo fuori.
Mentre dentro, invece, tutto diventava una ragione per discutere, per essere competitivi, per sfidarci in ogni cosa.
Così, sono cresciuta un po’ da maschiaccio, sempre pronta a buttarmi nella mischia con e contro i ragazzi, sempre pronta a provare nuovi giochi.
Ricordo i pomeriggi passati in giro.
Ricordo lo sport e le discussioni con i miei genitori.
Ci ricordo tutti ammassati su un divano, oppure per terra, a guardare Disney Channel insieme.

Tutte le mie prime memorie sono in Finlandia.
In ogni immagine, noi siamo già arrivati lì.
Ma questo non significa che l’origine della nostra famiglia non sia parte di me.
Non significa che la nostra storia non sia anche mia.
Dal Sud Sudan all’Egitto, per scappare alla Guerra Civile; dall’Egitto alla Finlandia; da Il Cairo a Kotka; dal caldo secco africano al freddo del nord, il freddo del mare, quello con tanto vento e tanta umidità: nulla è andato perso.
E mai lo farà.
Quando ero piccola, mamma ci mostrava spesso le foto del loro viaggio, le immagini del treno che li aveva portati via, sul quale erano stati messi in salvo.
Quello sul quale erano saliti pensando principalmente a noi, e al nostro futuro.
Io avevo due anni.
In casa si è continuato a respirare l’aria degli inizi, perché i miei genitori hanno sempre fatto tutto il possibile affinché la nostra cultura e le nostre radici fossero parte integrante della vita di ogni giorno.
Il Sud Sudan ce lo siamo portati dietro, e la sua impronta non è mai stata cancellata. Sono riusciti a imprimerla in ognuno di noi.
È chiara dentro di me, che pure sono cresciuta altrove e che altrove, oggi, vivo.

Ci sono molte ragioni per cui questo accade.
C’è l’orgoglio di voler sapere chi sei.
La volontà di non dimenticarlo, neppure quando sei lontano.
Il desiderio di farlo sopravvivere al tempo e al dolore.
E c’è anche il bisogno di proteggere se stessi. Penso ai miei genitori, che non avevano mai visto la neve in vita loro, e che si sono ritrovati in luogo nuovo, diverso da tutto ciò che avevano conosciuto fin lì.
Un conto è farlo quando sei troppo piccolo per ricordare, come è successo a me.
Un conto è farlo da adulti, da genitori.
Da uomini fatti.
Abbiamo imparato la lingua prima di loro.
Abbiamo imparato la cultura finlandese prima di loro, perché per noi è parte di chi siamo tanto quanto quella sudanese. Per loro invece no.
Per noi è stata un’infanzia.
Per loro è stata una battaglia.
Per noi una conseguenza, per loro una scelta.
E ci siamo presi cura di loro, tanto quanto loro si sono presi cura di noi.

Non è sempre stato facile.
Abbiamo vissuto situazioni che ci hanno fatto sentire diversi dagli altri, specie da piccoli, perché, si sa, che i bambini sanno essere cattivi.
Per me è stato molto importante lo sport, perché in quella comunità c’è maggiore rispetto che altrove, maggior possibilità di essere accettati.
Gli atleti che guardi con ammirazione arrivano da ogni angolo del Pianeta, e sono espressione di tante culture diverse. Vederli primeggiare nello stesso gioco, a prescindere da chi sono e dove sono nati è un messaggio potentissimo, che solo lo sport sa dare, e che ha dato a me.
Mi ha fatto sempre sentire a mio agio.

A partire dagli anni dell’atletica leggera.
Facevo il salto in alto, il salto in lungo e anche la corsa.
Ero portata.
Però poi è arrivato il basket, che ho scoperto seguendo i miei fratelli, e lì, nel giorno della mia prima vera partita, mi sono completamente innamorata del gioco.
Ho abbandonato tutto il resto e dedicato me stessa soltanto alla pallacanestro.
Mi sono trasferita ad Helsinki e sono entrata in una squadra di high school molto più strutturata di quella in cui avevo iniziato.
Ci allenavamo due volte al giorno e c’era un approccio professionale al gioco.
All’inizio è stato uno shock, mi ci è voluto un mese a comprendere quello che mi veniva richiesto per salire di livello e per adeguarmi al lavoro delle altre.
Ho dovuto imparare a convivere con la distanza, con l’impossibilità di vedere la mia famiglia e i miei fratelli come facevo quando vivevo ancora in casa con loro.
Ma l’ho fatto comunque.
Per amore del gioco e di quello che mi da ogni volta che scendo in campo.
All’high school come in Italia, in WNBA come con la nazionale.

E so che ogni volta che scendo in campo, la mia storia viene con me.
So che è parte di chi sono oggi.
Non potrò mai essere soltanto una giocatrice, perché il viaggio della mia famiglia sarà sempre al mio fianco, e con esso anche tutta la narrativa che lo circonda.
Non è una storia molto comune, la mia, iniziata in un continente e poi proseguita scappando in un altro. Con due genitori costretti a portare i propri figli dall’altra parte del Mondo per sfuggire ad una guerra.
Diventa un simbolo, diventa un messaggio, che io lo voglia oppure no.
Non lo voglio, non lo cerco, ma sono grata lo stesso che tutto questo sia successo, perché non posso separare i fatti, anche quelli dolorosi, dalla persona che sono adesso, e quella è una persona felice.
Una persona grata, che conosce molto bene il proprio ruolo e la propria cultura, e che, proprio per quello, è sempre pronta a conoscerne altre.
Kuier Awak / Contributor