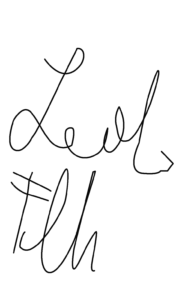Io amo i record.
Amo l’idea che esista un limite da superare, un muro da abbattere.
Amo il pensiero che ci sia stato qualcuno che ha fatto qualcosa che nessuno aveva fatto prima di allora.
E, più di ogni altra cosa, amo batterli.
Nel mio sport, e in particolare nella mia disciplina, chi è nato negli ultimi 30 anni è cresciuto all’ombra dei Giganti che hanno calcato le pedane a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90.
Prestazioni di cui si fatica a trovare video o registrazioni, che non si possono certo analizzare come fossero video in HD, e che anche per questo vivono circondate da un magico alone di mistero.
Risultati fatti quando la Terra non era nemmeno divisa come dice il mappamondo di oggi. Ora che tutto dura il tempo di un secondo, di un clic e di una scrollata veloce alla bacheca, i lanci di quei Giganti sono ancora lì, imponenti e apparentemente inscalfibili, che sembrano quasi esserci sempre stati.
E così sono cresciuto anche io, che di anni ne ho 23, esattamente dieci in meno di quanti ne ha già compiuti il record che, secondo me, è il più importante di tutti.
Quello con la R maiuscola.
La R del Re tra i Giganti, Alessandro Andrei.
Ovunque io gareggi c’è un suo record, per qualunque statistica un suo primato, per ogni categoria un suo risultato a cui mirare.
I suoi lanci nella magica notte di Viareggio del 1987, quando per ben 3 volte sbriciolò il record mondiale, sono per me una dolcissima ossessione.
Fatti con la tecnica della traslocazione, allora pioneristica, ma ormai superata al giorno d’oggi, e viene da chiedersi cos’avrebbe potuto fare in rotazione.

Alcuni di quei record li ho battuti, come il primato italiano assoluto indoor, che se ne stava lì da quando in radio passava Nostalgia Canaglia e la Fiorentina era allenata da Eugenio Bersellini.
Ci sono voluti quasi 33 anni perché un italiano potesse scrivere il suo nome accanto a quello di Alessandro nell’albo d’oro.
Dopo quel risultato ho ricevuto anche un suo messaggio, stentavo a crederci, è stato come se Zeus avesse deciso di farsi uomo per venire a farmi visita.
Quasi a colmare in un istante solo l’enormità che ho sempre sentito dividere le leggende e me, Leonardo. Andrei il Grande, però, era davvero dall’altra parte del filo invisibile, quello del telefono, e se era lui a digitare, allora era fatto di carne ed ossa come me.
E sempre di carne e di ossa, di pensieri e di paure, è fatto anche David Storl, l’altro idolo alla cui ombra sono diventato grande.
Lui, tedesco nella nazione e tedesco nei modi, duro e riservato, espressione di efficienza intoccabile e perfetta, mi ha regalato un sorriso eterno.
La prima volta che ho gareggiato accanto lui, mi sono fatto piccolo-piccolo, e l’ho osservato sciogliersi come neve al sole quando gli ho confessato di essere cresciuto nel suo mito.
Piccolo-piccolo, anche se piccolo non sono mai stato.
A guardare le foto della mia famiglia sembra quasi un remake di quel capolavoro di prospettive che è il film Elf, dove il piccolo Buddy, scambiato nella culla alla nascita, cresce in un modo che non è fatto su misura per lui.

Sono grande e grosso e lo sono da sempre.
Ero un bimbo molto timido e non amavo né lo sport né la fatica.
Il sangue però non mente mai e se è vero che la stazza non l’ho presa né da mamma né da babbo, è stata la testardaggine del vecchio a farmi scoprire che il talento per l’atletica era nel mio corredo genetico.
Mamma ha fatto sport a livello agonistico, nuoto.
Ma babbo, babbo è stato davvero un grande atleta.
Un velocista, rapido e compatto.
Vanta un ottimo personale di 10”9 sui 100.
Un Gigante anche lui nella mia personalissima storia di bambino.
Bravo e basta. Ma anche bravo il doppio di chi aveva attorno ai blocchi perché lui, sordo, doveva alzare lo sguardo verso la pistola per scattare alla partenza.
Il mio primo vero ricordo sul tartan è proprio una grandissima festa per il babbo, con uno stadio gremito di gente che urlava e si divertiva.
Era la sua ultima gara, io avrò avuto 4 o 5 anni e sentivo nell’aria quanto fosse amato da amici e tifosi, quanto fosse profondo il suo lascito.


Io non è che amassi andare al campo a faticare.
Dicono che i primi tempi mio padre mi dovesse letteralmente trascinare al campo, ma più piantavo i piedi più lui insisteva per portarmici.
Non avrebbe potuto farmi regalo più grande.
L’atletica mi ha preso per mano. Con pazienza ha insegnato ad un bambino oversize a prender confidenza con il proprio corpo, a divertirsi.
E adesso mi diverto da matti.
Come Elf in missione a Manhattan, ho dovuto aspettare un po’ prima di trovarmi faccia a faccia con altri bestioni grandi come me. Ricordo un mondiale Under 18: per la prima volta ero circondato da lanciatori che superavano i miei 2 metri di altezza, ed era stato in qualche modo liberatorio sentirmi finalmente piccolo.
Quelle di Tokyo saranno le mie prime Olimpiadi.
Solo nominarle mi mette i brividi. Con il mio allenatore, Paolo, abbiamo sempre lavorato in vista di Parigi 2024, quando avrò la maturità fisica e l’esperienza giusta per considerarmi all’apice della mia carriera.
Questi Giochi arrivano in un momento particolare, dopo una stagione per me esaltante che mi ha visto al secondo posto del Ranking Mondiale. Un anno in cui non tutti gli atleti hanno potuto esprimersi al meglio, io tra loro, e per questo anche se so di poter puntare a qualcosa di grande, non sento alcuna aspettativa.

Certo un sogno ce l’ho, e non è chiuso nel cassetto ma appoggiato ogni giorno accanto alla mia pedana.
Qualunque risultato verrà, sarà per me, che amo questo sport dal profondo del cuore. Per la mia famiglia, che ama me dal profondo del cuore.
E per Paolo, il mio allenatore, che mi ha insegnato ad essere un professionista e che un pezzettino di cuore lo ha lasciato ad Atlanta 1996, quando, dopo essersi presentato ai lanci di finale in testa alla classifica provvisoria, ha concluso l’Olimpiade al quarto posto per un solo centimetro. Da allora, nessun italiano ha più messo piede in una finale a cinque cerchi.
Sarà una sfida, sarà una festa e magari anche il mio biglietto d’ingresso per il mondo dei Giganti.
Leonardo Fabbri / Contributor