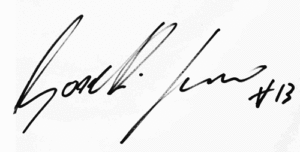La chiamano PET.
È più semplice da ricordare rispetto a: tomografia ad emissione di positroni.
È anche un nome che fa meno paura, gli inglesi non definiscono forse così i loro animali domestici?
Ci si arriva digiuni.
Ti infilano un ago nella vena e ti iniettano un farmaco radioattivo.
Il farmaco, passati 10 minuti, si ridistribuisce nel tuo corpo e si attacca alle cellule malate.
Serve per valutare l’estensione di un tumore.
Mentre il liquido è nel tuo organismo non puoi stare a contatto con le altre persone, per diverse ore sei molto contagioso, e vieni confinato in stanze apposite, dove altri, come te, stanno facendo questo esame.
Durante uno di questi esami, un giorno, mi sono ritrovato in stanza con un bambino.
2, massimo 3 anni.
Non saprei dire con certezza quanto pesasse, ma dubito più di 15 chili.
Piangeva disperato.
Davvero incontrollabile.
Un bambino che non poteva certo capire quello che gli stava succedendo, il perché questo accadesse.
Il mondo non ha bisogno di eroi, lo so.
Ma ho pensato con tutto il cuore che ero contento.
Ero contento che questa sfida fosse capitata a me, piuttosto che ad un altro bambino così piccolo.
Flashback.
Sono a Vibo Valentia.
Alzatore in una squadra di serie A.
Il campionato italiano di pallavolo è il più importante del mondo.
Ho 22 anni e mi sono sempre sentito un leone fisicamente.
Ho giocato a calcio nelle giovanili dell’Atalanta, poi nell’estate tra i 16 ed i 17 anni ho deciso di dedicarmi al volley, così da zero, senza averci mai giocato prima.
Semplice passione.
E tutto mi è venuto con una grande naturalezza fin dal principio, in maniera sorprendente.
12 mesi dopo aver alzato la mia prima palla ero nel settore giovanile della Sisley Treviso, che, in quegli anni, era la squadra più forte ed importante al mondo.
Ma ora, seduto in questo spogliatoio mi sento sfinito.
Petto nudo, caviglie fasciate e gomiti appoggiati sulle ginocchia.
Dopo ogni allenamento mi sento incredibilmente stanco, sia fisicamente che mentalmente.
Ho perso molti chili in questa stagione e non riesco a sentire più quella straordinaria voglia di giocare che ho sempre avuto.
Il mio cuore, la mia anima hanno percepito chiaramente che qualcosa non va, ma non riesco a capire di cosa si tratta.
Un malessere latente, profondissimo, che mi butta in down come niente era mai riuscito a fare prima. Il corpo, con la sua straordinaria memoria interiore, con la sua indescrivibile sensibilità mi dice che sono in pericolo.
Ma il cervello non riesce a capire appieno cosa sta succedendo e sente solo un muro di stanchezza che non aveva mia visto prima; somatizzo nella voglia di smettere di giocare.

Metà stagione cambio: Cantù.
Il mio corpo mostra i primi segnali di cedimento: in un mese mi sono strappato per due volte i muscoli addominali, un infortunio strano, abbastanza raro.
Una stagione tormentata, nella quale ho giocato nella sensazione di un infinito scontro fisico con me stesso, alla disperata ricerca del mio benessere che sembrava perso.
Ho inseguito il me stesso che ero solito conoscere per tantissimi mesi, invano.
Come Peter Pan con la sua ombra: imprendibile.
L’estate seguente è stata durissima.
Mi sentivo uno straccio, il mal di schiena era diventato così forte da impedirmi anche di dormire la notte.
Una sequenza lunghissima di specialisti, di visite.
C’era un massaggiatore in particolare del quale mi fidavo come nessun'altro, un luminare che purtroppo abbiamo dovuto salutare qualche anno fa.
Nel corso della carriera mi aveva sempre aiutato con i mille piccoli problemi che un atleta deve affrontare: lui mi risistemava anima e corpo, mi conosceva, sentiva la mia energia al minimo tocco, lui capiva il mio stato d’animo appena entravo nel suo studio.
Alla fine mi rimetteva sempre in piedi.
Vedere lui preoccupato mi ha allarmato molto.
E aveva ragione.
Nella pancia avevo un linfonodo grosso quanto una palla da baseball che premeva contro gli organi.
Ricordo un particolare che testimonia la mia innocenza di quegli anni, la mia incapacità anche solo di concepire questo tipo di male.
Sul referto c’era scritto: possibile linfoma, contattare specialista.
Non conoscendo all’epoca il significato di linfoma me ne andai a fare colazione fuori, serenamente, lasciando il foglio sul comodino, con l’intenzione di valutare il da farsi più tardi, magari il giorno dopo.
Una delle più grandi verità su queste gravi e terribili malattie è che per tutti sono solo e soltanto dei numeri, quasi delle curiosità scientifiche o statistiche.
Quando si leggono certi dati:
il numero di persone che hanno contratto una malattia
il numero di bambini che l’hanno fatto
il numero di morti che fa
le percentuali di persone a cui ricapita dopo essere guariti
le ore di terapie
i costi delle medicine
tutto ci rimbalza addosso, tutto ci sembra solo un’eco lontana di un problema di altri, disperso nel mondo dell’impossibile.
Non interessa la ricerca, non interessa il sostegno, l’informazione.
Fino a prova contraria.
Fino a che non viene diagnosticata a qualcuno intorno a noi.
Quel giorno tutto cambia.
I numeri prendono vita e diventano uomini, donne e bambini.
Ci si rende conto che esiste un esercito di malati che combattono e muoiono ogni giorno, in ogni ospedale.
Ieri.
Domani.
E anche oggi, nell’ospedale dove sei andato a fare la visita medica per la patente o a togliere l’appendice.
In ognuno di quegli ospedali c’è una stanza dove si fa la chemioterapia.
Ci si trova tutti la mattina presto, verso le 6.30
In un anticamera dove a tutti viene dato un bigliettino numerato.
Per chi ti cura sei numero.
E tale devi essere. Lo capisco, ed è normale.
Chi potrebbe mai sopportare il dolore di così tante persone sulle proprie spalle?
Chi ti assiste in questi percorsi deve riuscire a mantenere il giusto equilibrio, o non riuscirebbe più ad aiutare nessuno.
Resta comunque una sensazione straniante: tante persone, ogni mattina, di età profondamente diverse, spalla spalla in attesa, con un numero in mano.

Per prima cosa ti fanno un prelievo: si fa la conta dei globuli bianchi per valutare se ne hai a sufficienza per sopportare la chemio.
Sono i globuli bianchi ad impedirti di morire per un banale raffreddore ed il tuo corpo dopo queste terapie sarà sfinito, pertanto meglio valutare prima se puoi farcela o no.
Nella stanza della terapia di solito si entra a gruppetti; ti fanno sedere su una poltrona molto comoda perché ci starai diverse ore, abitualmente 4, senza poterti muovere.
Ad ogni paziente viene infilato in vena un ago a farfalla, attraverso il quale ti svuoteranno nel corpo 3 o 4 sacche di liquido.
Una di queste sacche è di un intenso colore fucsia e per questo la prima volta che fai la pipì a terapia ultimata può capitare che sia rosso rubino.
Se non lo sai, ti si gela il sangue nelle vene.
In queste lunghe ore tu puoi, in sostanza, fare quello che desideri, guardare serie TV, leggere e anche mangiare.
Mi sono sempre portato una scorta di yogurt, marmellate e di miele perché la terapia mi faceva sentire un terribile sapore amaro in bocca che non riuscivo a sopportare.
Più la terapia va avanti e più il tuo corpo ne è debilitato e, verso il finire del trattamento, molti sono allo stremo delle forze, al limite della propria sopportazione.
Subentrano la sonnolenza, i formicolii, il senso di vomito.
Per tanti diventa impossibile non mugugnare e lamentarsi.
Il dolore degli altri è sempre straziante, dà quasi più fastidio del proprio.
Ogni poltrona è dotata di una tenda che la può oscurare dalla vista degli altri pazienti.
Ma in questi momenti cala tra i pazienti un silenzio raggelante, fatto di grande paura e allo stesso tempo di grande rispetto.
Tutto questo non esiste.
Non esiste finché non lo si vede, non lo si prova, o non si assiste un caro durante il processo.

Io sono un uomo incredibilmente fortunato.
Il mio corpo ha reagito in maniera sorprendente alle cure.
Ma è corretto dire che avevo iniziato il processo di guarigione il giorno stesso della diagnosi.
Era trascorso quasi un mese infatti dal mio ricovero e notavo intorno a me facce che non mi piacevano da parte dei dottori. Chi entrava in ospedale con me riceveva risposte rapide, io, invece, venivo lasciato in sospeso, come se ci fosse un segreto inconfessabile che tutti sapevano, tranne me.
Ma non avrei mai permesso ad un medico di avvisare la mia famiglia di un problema serio e per questo pretesi di avere io le notizie, tutte le notizie.
Volevo essere io a parlarne a casa perché in questo modo avrei saputo mostrare la mia forza e la mia sicurezza e l’avrei passata per osmosi ai miei cari.
Molto meglio del freddo gergo medico.
Mi preoccupavo molto più della mia famiglia che di me stesso.
Al 90% hai un tumore al sangue.
Si può guarire?
Oh sì, in 6 mesi di terapie se il tuo corpo reagisce bene.
In quel preciso istante la mia mente ha messo una data di scadenza.
Non a me, ma alla mia malattia.
Il mio cervello, quello stesso cervello che un anno prima aveva intuito che mi stavo ammalando, ha deciso che in 6 mesi io sarei guarito.
E questa fede incrollabile, irrazionale, non ha mai vacillato.
Mai durante la chemio, mai durante i giorni più difficili, mai.
Non ho mai permesso a nessuno di vedere se soffrivo oppure no.
A volte ho persino fatto il contrario di quello che mi veniva raccomandato. Non mi sono mai negato una birra con gli amici o una passeggiata, anche se all’aria aperta magari rischiavo una polmonite.
Sono persino andato all’Octoberfest.
Ora, non mi sognerei mai di consigliare a qualcuno di ignorare i pareri medici, anzi!
Ma durante questo tipo di battaglie credo che sia fondamentale ricordare chi sei.
Chi sei tu veramente.
Sia a te stesso che agli altri.
Cosa ami fare, con chi e dove. Compatibilmente con l’energia che hai.
Perché se tu resti te stesso, magari senza i capelli, smagrito e con un po’ di occhiaie…ma se tu resti te stesso, allora gli altri continueranno a riconoscerti e a trattarti come tale.

I miei amici non hanno smesso di prendermi in giro se combinavo qualcosa, mia madre non ha smesso di sgridarmi se me lo meritavo, ed io non ho smesso di amare.
Amare il volley, visto che mi allenavo un po’ di nascosto, attento a non passare troppo tempo negli spogliatoi che può essere pericoloso (troppi germi).
Amare la natura, nella quale mi ricaricavo passeggiando quasi tutti i giorni.
Amare e basta: ho conosciuto la donna della mia vita, Isabella, in quei mesi e presto ci sposeremo.
Lei che ha visto me e se ne è innamorata, ed è stato possibile perché io non me ne sono mai andato, non sono cambiato, non ho mai smesso di condividermi.
In molti si vergognano a dire di essere malati, di far parte di quell’esercito che per gli altri è solo un insieme di numeri.
Ma tu resti tu, sempre.
Gli altri non ti tratteranno diversamente se tu non lo fai.
Ci sono giorni terribili, certo.
E non è possibile nascondersi dietro un dito: non tutti riescono a sconfiggere il male; io, in questo, sono stato estremamente fortunato.
Ma esiste una dignità sola, uguale identica per tutti, da mantenere.
Una gemma da difendere e perseguire in ogni momento: la normalità.
Avevo i miei modi di capire come stavo giorno per giorno.
Facevo sempre la stessa salita in bici. Sempre lei: non troppo impegnativa, ma neppure troppo leggera.
Se, arrivato in cima, non avevo il fiatone allora era uno dei giorni buoni e mi concedevo qualcosa in più, altrimenti stavo un po’ più attento alle attività da fare.
Questo e l’appetito.
Quando avevo appetito mi sentivo meglio, perché il mio cervello lo collegava ad un’idea di benessere, di salute.
Sono un entusiasta della vita, da sempre. Quello che qualcuno definirebbe un compagnone, sempre allegro.
Ho scelto sempre di fare tutto quello che mi andava.
Durante la malattia l’ho fatto all’ennesima potenza.
Dopo due ore dall’ultima chemio ero in campo ad allenarmi.
Durante le settimane della radioterapia giocavo e mi allenavo tranquillamente con i miei compagni, solo che in mattinata, invece che al bar a fare la colazione passavo in ospedale.
La mia storia è unica, lo so.
La racconto con sempre con piacere, a chiunque la voglia conoscere, e non solo perché sono ambasciatore dell’Associazione Veronesi.
L’ho raccontata ai talk show, ai quotidiani e ne ho persino scritto un libro: Sotto Rete.

Cerco di ricordarne i dettagli, le sensazioni che ho provato e di condividerle nude e crude.
Perché sono tante le persone che anche oggi stanno affrontando percorsi simili, a volte anche peggiori.
Adulti, bambini e anziani, che sentono abbandono, o paura, o vergogna.
Io sono guarito.
Sono guarito senza mai perdere il contatto con me stesso ed impedendo ai miei cari di fare altrettanto.
Se le mie parole spingeranno anche pochissimi tra loro a trovare la voglia di provare a rifare ciò che hanno sempre amato, o se spingeranno qualcuno a volersi informarsi di più, a sostenere le Associazioni che aiutano i malati e le loro famiglie allora sarò felice.
I capelli sono ricresciuti, i miei muscoli anche.
Le mie gambe sono tornate forti come un tempo e la mia voglia di cambiare è tornata a bussare alla porta.
9 mesi dopo la chemioterapia ero in campo, titolare nella finale di Coppa Italia, davanti a seimila spettatori di tutte le età, giocando in un nuovo ruolo, quello di schiacciatore, mai fatto prima della malattia.
Poco prima di mettere un piede sul parquet ho pensato che, anche se dovessi vincerne 100 tra coppe e campionati, la mia vittoria più bella l’ho già messa a segno.
Mi è venuto da ridere.
Lorenzo Bonetti / Contributor