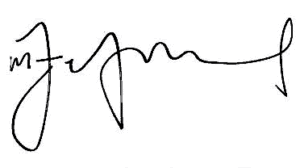Gli isolani non pensano molto al futuro.
O meglio, ci pensano, ma in modo diverso da tutti gli altri.
La terraferma sembra distante, e distante sembra anche il resto del Mondo, al di là dell’Oceano, così diverso da noi, con i suoi impegni, le sue necessità.
Con i suoi tempi.
Mentre sull’isola invece no, sull’isola tutto segue un ritmo più morbido, dettato dalla natura, dettato dalla famiglia, dettato dal nascere e dal morire del sole.
Che tutte le mattine sorge, e che tutte le sere tramonta.
È lui, il nostro orologio.
Sono nato e cresciuto a Tonga, su una piccola isola, insieme ad altri 14 tra fratelli e sorelle.
Oggi siamo tutti sparsi in giro per il Pianeta, tra Nuova Zelanda, Australia, Francia, Stati Uniti e Italia: luoghi distanti nel tempo e nello spazio, che ognuno ha raggiunto seguendo la propria strada, le proprie aspirazioni, il proprio mestiere.
Ma quando ero piccolo, almeno 8, 9 per volta vivevano nella casa dei miei genitori, e questo ci ha uniti enormemente, rendendoci più vicini e solidali che mai.

La nostra è una famiglia mormone, e per questo abbiamo sempre dato un certo valore ad alcuni gesti fondamentali. Alcune leggi non scritte.
Come la messa della domenica, o come i nostri family meeting del lunedì.
Ricordo le giornate all’aria aperta, trascorse giocando con i miei fratelli e le mie sorelle, con i miei cugini.
Ore infinite spese a giocare, a correre, ad inseguire un pallone.
A praticare sport.
Fino al tramonto.
Nessuno di noi immaginava davvero che cosa sarebbe diventato da grande.
Nessuno di noi pensava ad un lavoro specifico, oppure ad un titolo da ottenere.
Condividevamo tutto quello che avevamo, senza pensieri.
Perché quando fai quello che ami, giorno per giorno, non ti serve davvero guardare avanti. Il futuro è una terra straniera, che non ti appartiene, che non hai alcuna fretta di provare a conquistare.

Poi, l’isola ha iniziato piano piano a stringersi, intorno a me.
Come se il mare ne accorciasse le spiagge.
Come un vestito lavato alla temperatura sbagliata.
O forse ero soltanto io, a crescere in fretta e ad avere bisogno di uno spazio nuovo.
Il rugby era sempre stato un pezzo della mia equazione.
Era sempre stato uno dei miei motivi.
Un motivo per alzarmi.
Un motivo per divertirmi.
Un motivo per essere me stesso.

Che fossi bravo, probabilmente, l’ho sempre saputo.
Non soltanto perché lo sentivo nelle parole della gente.
Ma perché lo sentivo nell’animo.
Lo sentivo nel profondo delle mie ossa e della mia carne.
Fin da quando ho iniziato a fare parte delle diverse selezioni giovanili, anche se ero sempre più piccolo di tutti gli altri.
Eppure non ho capito, o forse non mi sono permesso di capire, che sarei potuto diventare un vero professionista fino ai 18 anni.
Fino a quando le cose sono diventate talmente grandi da non poter essere più ignorate.
Poco più che bambino, a 12 anni, sono partito, per andare in Nuova Zelanda, la patria del rugby, e per provare a fare qualcosa del mio talento.
8 ore di traghetto, più una di aereo: ma sono andato comunque molto più lontano di quanto dicessero i chilometri.
Un viaggio fuori dalla mia comfort zone, lontano da casa e dalla mia famiglia.
Lontano dal nostro modo di intendere e di vivere la vita.

Mi mancava.
Mi mancava Tonga e mi mancava il mio passato.
Mi mancava la spensieratezza e mi mancava quel senso di appartenenza.
Quello che non puoi descrivere a parole, ma che senti dentro, e che si materializza, per fede o per magia, ogni mattino, quando il sole sorge all’orizzonte.
Però, nonostante tutto questo, avevo anche la chiara e netta certezza di essere dentro qualcosa “più grande di me”, qualcosa di importante, qualcosa che forse mi avrebbe aperto scenari nuovi.
Cose che valeva la pena abbracciare.
Il momento in tutto ha fatto click, il momento in cui ho capito davvero cosa stava succedendo è stato la mia prima gara da professionista.
Con la mia famiglia davanti alla tv.
Sentivo il loro orgoglio, la loro forza.
Ero pronto.
Mentalmente e fisicamente.
E così tutto è cominciato.

Se potessi tornare indietro ed incrociare quel ragazzo che cerca di farsi uomo e di imbarcarsi per il mondo esterno, facendo del rugby anche un lavoro, credo che gli direi di lavorare sodo, ma anche di fare tutto quel che può per essere sempre gentile con gli altri.
Con tutti gli altri.
Sempre.
Perché viaggiando e giocando ho capito che non ti liberi mai davvero dei dubbi.
Nemmeno quando diventi un professionista e finisci nei grandi club europei.
Nemmeno quando vesti la divisa degli All Blacks, perché sotto di quella ci sei sempre tu, che sei umano, che sei piccolo, e che per imparare qualcosa devi prima sbagliare.
Ci sei tu, con la tua pelle e le tue insicurezze.
La maglietta nera la vedono tutti, quello che c’è sotto invece no.
E allora impari a convivere con la tua finitezza.
Con i tuoi limiti.
Li combatti, li alleni, li sposti un po’ più in là.
Devi imparare, con il tempo e con l’amore delle persone care, a dialogare con le voci che senti dentro, quelle che mettono in dubbio il tuo percorso, la tua strada.
Devi imparare ad essere consistente, anche nelle difficoltà.
Devi comprendere che la fatica è parte integrante del processo, e che quando ti senti perso, perché non riesci a performare o a sentirti a casa, oppure quando al mattino è difficile trovare una ragione per alzarsi, è proprio lì che devi affrontare l’uomo nello specchio, capire e amarne tutti gli spigoli.

Gli anni in Europa mi hanno insegnato la pazienza.
Mi hanno insegnato che non sono “bigger than the team”, e che, allo stesso tempo, il team non è la cosa più importante in assoluto.
Quelle, tutte le cose davvero importanti, sono fuori dal campo.
E allora, quando finalmente capisci che il rugby non è la cosa più importante del Mondo, o che non stai lottando contro qualcuno in particolare, quando non riesci a esprimerti in campo, o quando non ti fanno giocare titolare, solo allora inizi a apprezzarne il vero messaggio.
Il vero valore.
Solo allora inizi a vedere il lavoro che c’è dietro.
Un lavoro fatti di uomini, di relazioni, di dialogo.
Cominci a capire che i sogni e i desideri di tutti gli altri, sono proprio come i tuoi.
Esattamente come succedeva a me da bambino, con i miei fratelli, le mie sorelle e i miei cugini, sull’isola.
Quando nessuno sognava in grande, forse, per non oscurare con la propria volontà, anche la luce degli altri.
Perché la luce è sempre una, ed è di tutti.
La luce del sole.
Malakai Fekitoa / Contributor