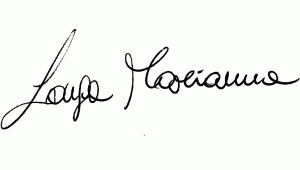La miglior versione di sé appare sempre riflessa negli altri, nelle loro qualità e nelle loro idee. Mondi paralleli, cambiati dal tempo, e resi differenti dalla vita, che prima o poi si sfiorano, e disegnano parabole comuni.
Almeno per un po’.
La prima volta in cui sono stati “gli altri” a tirar fuori la passione, la grinta e l’agonismo che sono in me, ero soltanto una bambina.
Nel freddo dell’inverno livignasco, il mio papà aveva deciso di farmi provare lo sci di fondo. A me che ero una discesista, e che mi sentivo una discesista. A quei tempi non c’era l’ampia scelta che c’è oggi e fare sport, in inverno, significava sciare oppure pattinare, nient’altro. Il corso a cui sono stata iscritta era di quelli organizzati dalla scuola, e se fosse stato per me, una lezione sarebbe già bastata e avanzata.
È stata devastante. Non solo era faticoso in senso assoluto ma, per me, era anche più faticoso degli altri, che sembravano scivolare leggeri sulla punta della neve.
Ultima, in fondo, staccata da tutti: sono tornata a casa ben convinta a non rifarlo mai più.
Ma i miei genitori avevano già pagato tutto il pacchetto di lezioni e quindi, quegli sci strani, stretti e con il tallone staccato, io, avrei dovuto metterli di nuovo. E così, è stato il gruppo a trascinarmi, risvegliando qualcosa che era già mio, anche se ancora non lo sapevo. Non volevo essere lontana dai migliori, arrancante nelle retrovie.
Volevo arrivare, raggiungere i primi.
E sciare con loro.

Giorno dopo giorno, mi hanno fatto innamorare dello sci di fondo, facendomi vedere che anche dentro la fatica il gioco esiste, esiste eccome. Creavamo percorsi, sfide, ci lanciavamo la palla, il tutto con gli sci saldi ai piedi, che sono diventati un prolungamento del mio corpo.
La seconda volta in cui mi sono specchiata dentro qualcuno, per scoprire qualcosa di me, è stato giusto qualche anno più tardi, quando mi sono dovuta trasferire per frequentare le superiori. A chi non conosce la montagna potrebbe anche sembrare strano, ma spesso a queste latitudini, tra tornanti e passi da scalare, le distanze vanno moltiplicate per due.
Quando sono arrivata in collegio, anche se in linea d’aria non ero poi tanto lontana da casa, tutto era distante, a partire dalla mia squadra di sci.
I ragazzi e le ragazze che mi avevano contagiato con la passione per il fondo, non c’erano più, e ho dovuto ricominciare tutto da capo. Ho pensato di smettere, come mi sarebbe capitato altre volte in carriera, ma per fortuna non l’ho fatto, come tutte le altre volte in carriera, a parte l’ultima.
A guidare la nuova squadra c’era un allenatore burbero e severo, di cui all’inizio non vedevo altro che gli spigoli. Ero un’adolescente timida, sempre sulle sue, che soltanto nell’agonismo riusciva ad esprimere compiutamente il proprio carattere.
E quella figura autoritaria mi incuteva timore.
Poi, ho iniziato a vedere riflesso in lui il mio stesso fuoco e la mia stessa voglia di arrivare. Ogni allenamento lo capivo un po’ di più, e altrettanto faceva lui, finché non abbiamo riconosciuto di avere lo stesso pensiero e siamo diventati inseparabili. È stata la mia pulce nell’orecchio, il mio mentore e la mia guida dai 14 anni fino a quando ho smesso di sciare, e ogni qual volta ho avuto un dubbio o una difficoltà, quattro passi insieme hanno sempre risolto tutto.
Dopo il trasferimento in collegio, è stata la volta delle Olimpiadi di Lillehammer 1994, e lì, guardando gli azzurri, penso proprio di non essere stata la sola aspirante fondista a sognare di diventare forte per davvero.
Silvio Fauner, Manuela Di Centa, Stefania Belmondo: una generazione di fenomeni ha trascinato il tricolore sul tetto del Mondo, e io, da Livigno, con gli occhi incollati dentro la tv, ho iniziato a fantasticare di unirmi a loro.
Di raggiungere le vette più alte e di girare ovunque a rappresentare il Paese, e anche a rappresentare il mio di paese, quello con la P minuscola, in cui ero cresciuta e in cui sarei tornata per costruire i miei anni migliori.

Per diventare un’atleta forte non ci sono scorciatoie né tunnel segreti. Avere un bel motore conta, questo non c’è dubbio, ma in uno sport come il fondo, a far la differenza è la fame. La semplice, sempreverde, fame.
Oggi non è raro veder passare per le strade, tanto in estate quanto in inverno, i grandi campioni internazionali, dai norvegesi in giù, che arrivano a Livigno per preparare la stagione in altura. E non posso non pensare a quanto mi sarebbe piaciuto che ci fossero stati anche vent’anni fa, quando l’orizzonte era completamente diverso.
Avrei pagato di tasca mia per aggregarmi ogni tanto al gruppo, per rubare qualche segreto dai migliori, o anche soltanto per allenarmi in compagnia.
Dopo gli anni della scuola sono tornata a casa e ho iniziato il mio percorso da atleta professionista, fatto in egual misura di testardaggine, amore per la fatica e un po’ di eroismo sportivo.
Mi allenavo per lo più da sola, senza riferimenti a fianco, macinando chilometri su chilometri nella solitudine più totale. Tolti i collegiali, tolti i viaggi e tolte le gare, la mia routine era tutta un assolo, e questo richiedeva un grande sforzo creativo.
Senza nessuno in cui riflettere me stessa, ho iniziato allora a immaginare di essere con gli altri, costruendo la mia squadra da sogno, composta solo di campioni e campionesse.
Ogni giorno, a seconda del tipo di allenamento che mi aspettava visualizzavo di avere a fianco, oppure davanti, l’avversaria o la compagna più forte che mi venisse in mente, e sui di lei facevo la gara.
Una sfida al dì, inseguendo il fantasma di turno, che mi dava lo stimolo per migliorare sempre, anche quando, magari, sarebbe sembrato impossibile farlo. La mia fantasia è riuscita a mantenere vivo il ricordo del gioco di bambina, quello che mi aveva fatto innamorare dello sci, e nonostante le intemperie, mi ha permesso di scalare la mia vetta.
L’immagine degli altri era soltanto un’illusione, ma a volte basta un trucco ben riuscito per fregare il destino e arrivare fino alle porte di Olimpia.
Durante i Giochi di Salt Lake City 2002 avevo soltanto 22 anni e vagavo per il Villaggio come Alice nel Paese delle Meraviglie. Era tutto enorme, in pieno stile americano: dalla Cerimonia di apertura agli atleti che incrociavo in mensa, fino alle responsabilità che sentivo di avere. Sotto i Cerchi: un’emozione fortissima e indescrivibile, che mi ha fatto restare in apnea per tutta la durata dell’evento.
Ben più terra-terra, e facilmente descrivibile, fu invece il giorno della gara, in cui la tensione mi ha giocato un brutto scherzo. La nostra staffetta ha perso una medaglia, e lo ha fatto per colpa mia, che a metà della frazione sono crollata, vinta dal contorno e dalla sua grandezza. È una sensazione strana quella di aver lasciato a piedi gli altri. C’è un po’ di amarezza e un po’ di vergogna. Che, però, alla fine, senti soltanto tu, perché gli altri rivedono nel tuo i loro fallimenti del passato, e ti perdonano in fretta.
Quello della sconfitta, nello sport, è un segreto di Pulcinella e il tempo sistema tutto. Anche se a volte lo fa in maniere curiose.

Il ciclo Olimpico successivo, infatti, era quello di Torino, quello dei Giochi di casa, e tutto il gruppo delle azzurre guardava all’appuntamento piemontese come l’occasione della vita. Ci sarei arrivata nel pieno della gioventù, con tutta la sua forza, ma anche con una discreta esperienza alle spalle. Non avevo fatto i conti, però, con il destino, che ha deciso di farmi diventare mamma proprio a cavallo tra i Mondiali di Oberstdorf 2005 e le Olimpiadi.
Sul momento è stata una sensazione strana, agrodolce, perché diventare mamma è un viaggio meraviglioso, ma mi era comunque costato due medaglie preziose, quelle vinte dalle mie compagne.
Sono stata ad un passo dal dire basta, come da bambina.
Quando diventi mamma non puoi più essere un’atleta professionista. Sembra un’esagerazione, ma non è distante dalla verità. Puoi continuare a lavorare duramente, puoi allungare a dismisura le ore del giorno per allenarti mentre tuo figlio dorme, ma non riuscirai lo stesso a riposare come prima, a dormire quanto prima e a dedicare tutte le tue energie mentali ad un solo obiettivo.
Ma è stata proprio questa differenza a farmi sentire forte. Riflessa negli occhi di mio figlio, ho vista l’immagine di una donna ancora forte, tenace, con il fisico felice di sopportare il dolore, e che ha fatto della propria testa dura un motivo d’orgoglio. E sono ripartita. Più decisa che mai, più cattiva di chiunque.
Continuavo e non mollavo. A volte mia madre mi seguiva in trasferta facendo un po’ da nonna e un po’ da baby sitter, mentre io mi dividevo tra mamma e atleta, cercando di offrire il meglio di entrambe le cose.
Così, otto anni dopo le prime, e quattro dopo quelle che ho guardato allattando, sono tornata alle Olimpiadi, di nuovo in America, questa volta a Vancouver. Ero una donna diversa, infinitamente più consapevole. Ero una mamma, cosciente che c’è altro nella vita oltre allo sci, e allo stesso tempo una sciatrice grata di essere ritornata a vivere lo sport ai massimi livelli. Siamo quarte anche lì, medaglia di legno come nel 2002, ma questa volta era un legno pregiato, perché sentivo finalmente di aver fatto tutto al meglio delle mie capacità.
Alla fine del viaggio ho capito che lo sport è una questione di riflessi e di luci, di immagini e parole, in cui il sapere di uno diventa un patrimonio di tutti, e la fatica e la fame ne sono i soli moltiplicatori.
Oggi mi emoziono per le gare degli altri, che vivo quasi in trance, come se in qualche modo provassi a trasmettere agli altri l’energia che ancora sento, anche se sono seduta sulla punta del mio divano. E ripenso alla piccola me che arrancava in fondo al gruppo, alla ricerca di una scintilla. Un luccichio improvviso che di colpo ti cambia la vita.
Marianna Longa / Contributor