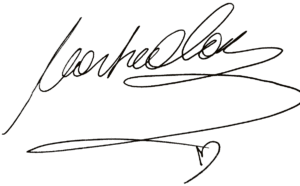Ad un mese dalla mia gara, ad un mese dall’oro olimpico, non avevo ancora fatto un singolo post. Non avevo ancora trovato le parole, o forse il tempo, per sedermi e scrivere qualcosa.
Qualcosa che poi restasse.
Qualcosa in grado di riassumere tutto quello che avevo dentro, dopo Parigi.
Ma non è soltanto questo.
Non è soltanto l’enormità dell’emozione, che devi ridurre ad un numero circoscritto di parole digitali. C’è di più.
C’è un profondo sballottamento fisiologico, che è tanto fisico quanto dell’anima, nella consapevolezza di aver chiuso così la carriera al più alto livello, e di avere tante persone a cui parlare di persona, prima di farlo online anche a tutti gli altri.

© Pagliaricci Bizzi Team
L’ho chiamato il “medal tour”, con il pezzo pregiato, grande protagonista, protetto in un calzino, così non si sciupa e non si rovina, ad accompagnarmi in giro per l’Italia.
Un viaggio senza capo né coda, guidato solo da gratitudine e ammirazione, da senso del dovere e dall’amore reciproco, per portare la medaglia tra le mani di chiunque avesse il sincero bisogno di sentirla tra le dita.
Dai Presidenti agli amici del bar, dalle persone che sono state con me fisicamente per tutto questo tempo, a chi invece mi ha scoperta soltanto ora.
Che non mi offende, anzi, va benissimo così.
Perché vincere non è soltanto un traguardo, ma è anche un’enorme responsabilità, e scoprire di riuscire a fare la differenza fino all’ultimissimo metro, ritagliando spazi per il nostro sport nel cuore di qualcuno, non ha prezzo.

© Bizzi

© Eva Pavia
Se la vendetta è meglio fredda, la medaglia invece no, è un piatto che va servito rigorosamente caldo, bollente, perché è in quel momento che esprime tutto il suo potenziale trasformativo.
È lì che può fare di più.
In 14 anni di carriera ai più alti livelli dello sport paralimpico, non saprei neppure fare una stima degli eventi pro-bono a cui sono stata invitata, delle scolaresche davanti a cui ho parlato, di quante associazioni mi hanno chiesto un racconto.
Nel 2012, dopo l’oro di Londra, hanno cominciato a chiamarmi “atleta”, prima no, e io ricordo la stranezza di quelle prime uscite pubbliche, o quei primi eventi aziendali, dove vedevo tanti uomini adulti che ascoltavano me, una ventiduenne, raccontare la propria vita.

© Eva Pavia
Ho e abbiamo lottato anni per questi spazi, per questi riconoscimenti, e ora lo dobbiamo a noi stessi, di presenziare, di raccontarci, di non smettere mai di guardare avanti.
E poco importa se non riesco, o se non posso, raccontare quanto e come vorrei di tutto il resto, di quello che ci sta dietro. La sensazione dello stomaco che si chiude, e la fatica nel dormire e nel mangiare, nel mese precedente alla gara.
I dubbi e la pressione della stampa, che dava tanto per scontato un nuovo trionfo tricolore, come a Tokyo.
Perché questo è l’aspetto sportivo, è ciò che ci accomuna a tutti gli altri atleti del Pianeta, quelli con due gambe e con due braccia, e alla gente, giusto o sbagliato che sia, nel nostro caso, interessa ancora meno di quanto dovrebbe.

© Eva Pavia
Prima arrivano le nostre storie.
Gli incidenti.
Le malattie.
Le guarigioni.
Quante volte me l’hanno chiesto. In quanti oratori ho dovuto raccontarlo.
Sempre con passione.
Sempre con sincerità.
Dal 2012 al 2024 ho visto il Mondo cambiare, un po’ da fuori e un po’ da dentro, come atleta e come rappresentante mia e dei miei colleghi, imparando a leggere tra le righe dei linguaggi più formali.
Imparando a capire di bilanci, di sponsorizzazioni e di ricerca.
Siamo partiti raccogliendo il testimone di chi c’era prima di noi, che per quanto banale possa sembrare, è il solo modo di progredire, quando devi lottare per i tuoi diritti.
Ricordo che Londra fu la prima edizione dei Giochi in cui esistevano dei premi monetari per i medagliati, e se quella, per me che ero all’inizio, era la normalità, per tutti coloro che l’avevano reso possibile nel tempo, era invece una grande conquista.

© Eva Pavia

© Eva Pavia
Così come per me è stata una battaglia contribuire al miglioramento delle protesi, visto che le prime scattavano, erano dolorose, e richiedevano lunghissimi test, e sedute, e prove per essere perfezionate, anche solo di un po’.
Vedere le ragazze più giovani raccogliere il frutto di quel lavoro, di quelle vesciche, di quei pianti, di quelle contratture, è un motivo di orgoglio profondo.
Una sensazione di fierezza e di pace.
E lo stesso si può dire di decine di altre cose, dall’ingresso nei gruppi armati alla narrativa che circonda il nostro sport, che si sta spostando, per quanto lentamente, a contemplare l’aspetto sportivo quanto quello umano.
A parlare di tempi e prestazioni, e non soltanto di ispirazione personale.
È una missione che non conosce pause, che non può avere tentennamenti, che richiede tutto quello che hai dentro, persino il “medal tour”, persino la rinuncia al primo anno “normale” che avresti tutto per te, e che invece di dedicare finalmente alla neve, all’arrampicata e alle passeggiate in montagna, passerai a rappresentare gli atleti presso World Para Athletics.
Un mestiere che mestiere non è.
Perché non si retribuisce una missione.
E io sogno un contesto in cui non esiste più la differenza con il mondo Olimpico, non soltanto in quanto ad attenzione mediatica oppure a sponsor, ma anche, se non soprattutto, come equiparazione sociale.
Sogno di contribuire alla formazione di un pubblico appassionato, che non guarda le gare paralimpiche a proprio uso, per sentirsi migliore attraverso il superamento dei limiti umani espresso dagli atleti in pista, oppure in vasca, oppure sul tatami.
Sogno una Paralimpiade, un Mondiale, persino un campionato italiano in cui parlare solo e soltanto di sport, e non perché il percorso umano degli atleti valga meno, ma perché si riconosca loro, prima di tutto, la pienezza della prestazione.
Il valore della disciplina.
Uno switch culturale di completa modernità.
Il testimone che ci passiamo di mano in mano e di protesi in protesi da decine di anni, e che non smetterò mai di fare del mio meglio per spingere verso il futuro.

© BIZZI
Martina Caironi / Contributor