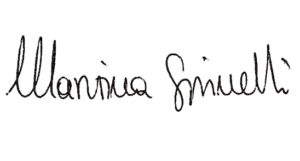Quando rientri da un brutto infortunio, nessuno pretende davvero qualcosa.
Tranne te.
Tutti sono pazienti.
Tranne te.
Chiunque è già sceso a patti con la strada che c’è ancora da fare.
Tranne te.
L’infortunio è un loop fisico e mentale, dove entra tutto quanto: tristezza, fatica, ego, dubbio, paura. Ci entra persino un piccolo senso di ingiustizia, perché anche se sai che fa parte del gioco, anche se lo vedi sugli altri, solo quando ti fai male tu, capisci quanto sia doloroso che ciò che ti piace fare ti venga tolto.
E che non puoi farci nulla, se non aspettare e lavorare.

La prima volta è successo nell’estate del 2021, alla terza partita del Mondiale Under 20. E non di un Mondiale qualsiasi, ma del “mio” Mondiale.
Non mi ero mai sentita così in forma, così in controllo, così capace di imporre il mio gioco.
In più, l’estate sarebbe finita con il passaggio a Ragusa, andando incontro per la prima volta al vero basket professionistico di alto livello.
Fino ad allora avevo giocato a Costa Masnaga, che è il posto in cui sono diventata grande, in cui ho assaggiato la mia prima Serie A, ma che sarà sempre e comunque “casa”. E a casa sei più protetta, sei amata a prescindere.
Mentre invece in Sicilia ci sarei andata senza paracadute, da atleta adulta, con le pressioni e tutto il resto.
Forse anche per questo era il “mio” Mondiale.
Per questo era il mio momento.
Terza partita, quindi, cronometro dei 24 che sta per scadere, e una palla che mi arriva in mano un po’ per caso. Attacco il centro dell’area, salto, tiro.
Ma ricado in maniera scomposta, innaturale.
Forse un cattivo appoggio, o una piccola esitazione su uno degli adesivi del parquet.
Forse troppo attrito.
Forse troppa stanchezza, o un angolo sbagliato, o magari un mix di tutte le cose precedenti.
La sensazione improvvisa di avere il ginocchio diviso in tre parti e che ognuna di esse fosse libera di andare in una direzione diversa.

Quando è grave, te ne rendi conto subito.
Non serve il dottore.
O meglio, il dottore serve, ma dopo, quando ormai la tua testa ha già iniziato a girare, a fare conti e congetture.
Mi sono sentita immediatamente disperata.
Come centinaia di ragazze e di ragazzi che si spaccano un crociato mi sono sentita privata di una mia proprietà, spogliata di qualcosa di mio.
Ero già spaventata dalla strada da fare.
Sono rimasta un po’ con la squadra, fino agli ottavi.
Poi sono rientrata.
Una piccola parte del mio cervello sperava che la diagnosi fatta in Ungheria fosse sbagliata. Sai, la lingua, il versamento, l’attrezzatura… ma sotto-sotto sapevo che fosse un pensiero infantile.
Il 10 settembre mi sono operata, e ho iniziato quella lunga trafila di piccole vittorie e sconfitte quotidiane che chiunque abbia mai ricostruito un crociato, conosce fin troppo bene.
Ho fatto gran parte della riabilitazione a Milano, lontano dalla squadra, anche perché vederle scendere in campo, se possibile, mi avrebbe fatto soffrire ancora di più.
Sono scesa in Sicilia a fine febbraio, quando ormai il peggio sembrava alle spalle e potevo iniziare a mettere nel mirino il ritorno in campo.

Però, la verità è che il peggio sembra sempre alle spalle, ma non lo è mai davvero.
Lo pensi quando ti dicono che l’operazione è andata bene.
Lo pensi quando togli le stampelle.
Lo pensi quando torni a correre, quando finisci la riabilitazione, quando ritorni in campo.
Invece più il tuo fisico migliora e più la frustrazione diventa sottile, infame, perché passa dall’essere qualcosa di fisico, che quindi puoi calcolare e comprendere, all’essere qualcosa di mentale, che è notevolmente più sfuggente e personale.
In campo vorresti subito tornare ad essere quella che eri, e ti incazzi se non ti vengono movimenti e giocate che hai fatto per tutta una vita.
È una sfida nella sfida, e spesso è quest’ultimo step a prendere il meglio di te.
Sono rientrata, giusto per poche partite, ma almeno erano i play-off, era la semifinale contro Schio, e quella sensazione di riconquista mi ha fatto quasi rinascere, anche al netto della costante frustrazione di dover ancora rincorrere la miglior versione di me.
Ma l’anno finisce e, questa volta per davvero, il “grosso” sembra passato.
Mi ero ripromessa di prendermi il mio tempo, almeno d’estate, magari per proseguire il recupero, per lavorare sul mio fisico, ma quando arriva la chiamata azzurra è davvero difficile dire di no.
Ne arrivano 2, quella senior, che però non ha grandi eventi internazionali all’orizzonte e quella Under 20, che ha in programma gli Europei e che sarebbe anche l’ultima volta in cui può convocarmi.
Insieme allo staff di Ragusa ne scelgo una, l’under, perché tutte e due sarebbero troppe per il mio ginocchio. Chiediamo di aiutarmi a monitorare la situazione, di diluire i miei carichi di lavoro, di continuare fare terapie.
Ma di tutto questo, viene fatto ben poco.
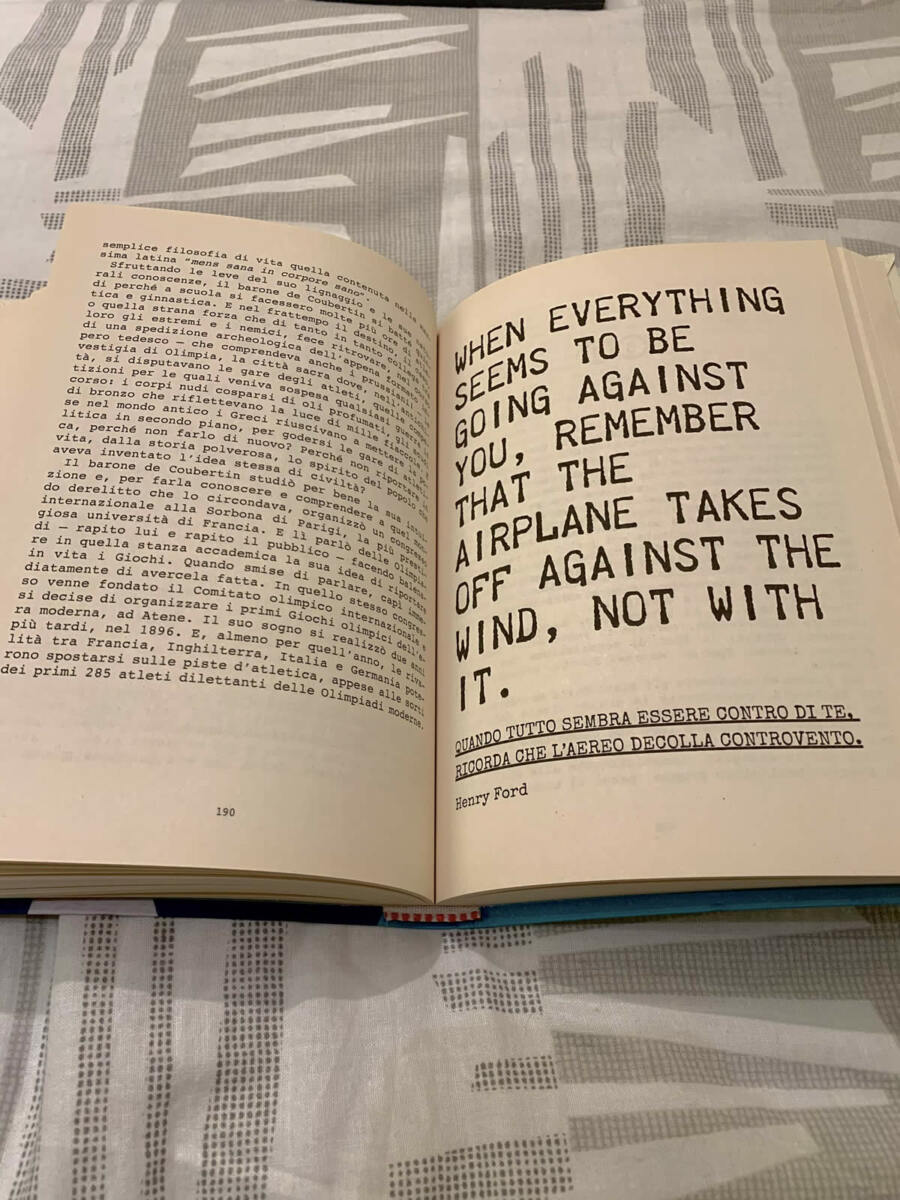
Amichevole, faccio un movimento strano, il ginocchio cede all’interno.
Il dolore è molto diverso da quello dell’anno prima e questo, più che spaventarmi, mi confonde. Per fortuna, la prima risonanza sembra dare esito negativo, il chirurgo che mi aveva operata me lo dice a chiare lettere “il crociato ha retto”.
Basta, mi dico, non rischio più niente, torno a casa, lo faccio sfiammare, riprendo la riabilitazione e ad agosto sono pronta per la stagione.
Dopo un mese il ginocchio si sgonfia e faccio una risonanza di controllo.
La spedisco a Ragusa, come da prassi, poi scendo in Sicilia e mi faccio visitare ancora una volta. Mi prescrivono 15 giorni di scarico totale e allora parto per le vacanze, felice di uscire per un po’ dalla palestra e dalla sala pesi.
Mentre sono in Francia, era un venerdì, un dirigente della squadra mi richiama. Dice che non sono sicuri, che vogliono farmi fare una visita ancora.
A Roma, il lunedì successivo, ad un anno esatto dal mio primo infortunio.
In quella sala d’attesa ero talmente serena da ingannare il tempo parlando del più e del meno con il mio procuratore, raccontandogli delle mie aspettative per la stagione nuova, dei miei sogni sportivi.
“Guarda che è rotto”.
Non solo è rotto, di nuovo, ma ho anche perso due mesi lavorando su una diagnosi errata. Mi è sembrato come se un masso mi fosse cascato sulla testa.
Chiedo un secondo parere, poi un terzo, un altro ancora.
Sono tutti concordi.
Tutti tranne il primo, quello che ha ricostruito il legamento la prima volta.

Poi sono arrivati i leoncini da tastiera, quelli dal commento facile, che quando hanno visto la notizia che mi sarei dovuta operare di nuovo, hanno scritto che mi ero fatta male in vacanza.
Che avevo nascosto il problema.
Che non ero una professionista.
Che ormai ero finita.
Ero a pezzi, e anche se sarebbe parte del mio mestiere provare ad ignorare tutto questo, prima o poi, nelle difficoltà, inizia a pesare.
Ho passato il primo mese a Roma, poi sono scesa a Ragusa, perché volevo stare accanto alle ragazze, volevo sentirmi parte del gruppo, sentirle vicine.
Forse perché volevo ancora sentirmi una giocatrice di basket.
Il secondo crociato è stato molto peggio del precedente, perché se durante la prima riabilitazione, ogni piccolo passo in avanti, almeno per un brevissimo istante, sembrava quello decisivo, questa volta sapevo che cosa mi aspettasse.
Ancora e ancora.
Ho avuto tantissimi bassi e pochissimi alti, tutti legati alle persone care, alle compagne, a chi mi ha dato qualcosa a livello umano.
Non sono tornata in campo, e ho passato tutta la primavera e l’estate a lavorare sul mio corpo, puntando direttamente alla stagione 2023/2024.
Una stagione ormai alle porte e una stagione in cui vorrei ripartire da zero, cancellando gli ultimi 24 mesi e riprendendo in mano la mia vita e le mie aspirazioni, quelle che giusto un paio di anni fa sembravano talmente vicine che mi sarebbe bastato allungare la mano per prenderle.
Martina Spinelli / Contributor