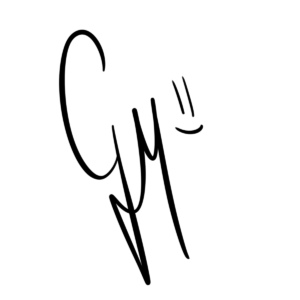La nostra casa era una specie di grande magazzino per l’attrezzatura sportiva.
Kayak, canoe, palloni di ogni grandezza e peso, rollerblade: ovunque ti girassi c’era qualcosa che ricordava lo sport.
Il paradiso dell’attività fisica: un parco giochi tutto per noi.
Il mio universo intero. Il mio e delle mie sorelle.
Io sono quella di mezzo, di due anni più giovane della maggiore, e di cinque anni più grande della minore. Eravamo come una piccola gang, come una squadra, e forse lo siamo ancora.
Lo sport è stato la nostra lingua comune, fin dal primo giorno.
Un modo per relazionarci, per confrontarci, per conoscerci davvero l’una con l’altra E insieme per conoscere il mondo che c’era fuori.
Un modo per capire chi fossi io, e chi fossimo noi.

Non ricordo di essermi mai sentita in competizione, con loro.
Neppure una volta.
Ma ricordo, invece, il tempo passato a giocare.
L’emozione di scoprire e di provare una disciplina nuova.
La voglia di sfidarci a vicenda, per vedere chi fosse più brava, per migliorare insieme.
Tutte le immagini che mi tornano in mente, quando penso alla mia infanzia, sono le nostre immagini. Sono le estati passate a saltare sul trampolino, oppure allo skatepark con il sole alto che ci scottava la faccia.
Le ginocchia sbucciate, le corse.
I giochi.
Papà è stato uno sciatore, e tutta questa cultura sportiva la dobbiamo a lui.
Dall’atletica leggera, forse il solo sport dove nasceva un po’ di competizione tra sorelle, al calcio. Dal pattinaggio a, ovviamente, lo sci.


Lo sci è nel nostro DNA da sempre, e per quello, a differenza di quasi tutti gli altri sport, serve il supporto dei genitori per iniziare.
Grazie alla carriera del papà, per noi è stato naturale andare sulla neve.
Un passaggio obbligato per diventare grandi davvero.
Quello che non era affatto scontato era il fatto che mi sarei innamorata del freestyle.
I salti, le evoluzioni, l’adrenalina: ci ho messo il naso dentro a 13 anni e non mi sono più voltata indietro.
Ho sempre avuto un’ottima coordinazione, secondo me per merito degli allenamenti al trampolino, e quando ho scoperto che potevo fare le stesse cose anche con gli sci attaccati ai piedi, tutto ha preso forma.
Non sapevo neppure che fosse un vero sport.
Non mi interessava che ci fossero delle gare.
Ero troppo giovane e troppo elettrizzata per preoccuparmi di avere dei sogni, a riguardo. Io volevo soltanto quella sensazione di libertà.
Volevo poter scegliere una cosa diversa da fare, da provare, in ogni singola run.
In ogni singolo salto.

© Elmar Bossard / Red Bull Content Pool
Così ho cominciato, poco alla volta, ad abbandonare tutti gli altri giochi e tutti gli altri sport, e a passare quanto più tempo riuscissi sulla neve per provare i miei trick.
Giorno dopo giorno sono diventata sempre più brava.
La mia famiglia non ha smesso per un istante di essere presente, anche se non ha mai spinto o forzato in nessuna direzione.
Dalle nostre parti c’era soltanto una piccola squadra, e le competizioni a cui potevo partecipare erano poche.
Non che mi interessasse più di tanto.
O meglio: non mi è interessato più di tanto fino al 2016, l’anno in cui ho partecipato ai Giochi Olimpici giovanili a Lillehammer, in Norvegia, il momento che ha cambiato tutta la mia percezione del futuro.
Soltanto lì ho capito che fosse davvero possibile viaggiare e gareggiare, grazie al freestyle. Solo davanti ai Cinque Cerchi ho percepito che quella passione non fosse soltanto mia, ma di migliaia di altri ragazzi e ragazze.
Solo davanti al cospetto delle Olimpiadi ho iniziato a sognare in grande.

© Lorenz Richard / Red Bull Content Pool
Non ho mai avuto dubbi, non fino al giorno in cui ho realizzato che quella della professionista era già diventata la mia vita.
Fino a quel momento era stato solo puro e semplice divertimento.
Poi è successo tutto estremamente in fretta: i Giochi Giovanili, il mio primo infortunio, i Giochi dei grandi, quelli veri.
Tutto nell’arco di un paio di anni.
Non ho avuto neppure il tempo di apprezzare fino in fondo la nuova prospettiva, quella ambiziosa, quella di Pyeongchang 2018, che mi sono fatta male.
Un infortunio stupido, un problema ad un ginocchio, ma era il primo, e il primo è sempre una scoperta. Se buona o cattiva dipende da te.
Il primo infortunio ti dice molto su che atleta sarai.
Ho iniziato a chiedermi se fossi davvero pronta ad affrontare la riabilitazione.
Ho iniziato a chiedermi se volessi davvero correre il rischio di rovinarmi la vita per lo sport, che da grande vorrei poter essere sufficientemente in salute per sciare il libertà, tutte le volte che voglio.
Pensieri semplici.
Pensieri sciocchi.
Pensieri di una ragazza ancora giovane, confusa dalla grandezza delle Olimpiadi e dalla velocità con cui stavano cambiando le cose.

© Dominic Berchtold / Red Bull Content Pool
Così, quando è davvero arrivato il momento di partire per la Corea, non sapevo cosa aspettarmi. Nè da me, né dagli altri.
Avevo recuperato giusto in tempo dal problema al ginocchio, e non ero affatto sicura che mi avrebbero convocata per i Giochi. Non avevo neppure avuto il tempo di rientrare in gare ufficiali, e per questo mi sentivo piuttosto insicura.
Quando sono arrivata al Villaggio, però, tutto è sparito e ho ritrovato la leggerezza degli inizi. Ho smesso di pensare, e ho iniziato a guardarmi intorno, a godermi la bellezza del momento e a sciare con la testa libera.
Già esserci era un regalo.
Era già sufficiente.
Forse è questo il motivo per cui quell’argento è stato così dolce.
Era sorprendente.
Inatteso.
Quasi ingenuo.
Come ingenua mi sento io, quando riguardo le immagini del momento in cui ho effettivamente capito di essere arrivata seconda.

© Lorenz Richard / Red Bull Content Pool
Quello è stato l’inizio di una nuova vita, quella che segue la via del professionismo.
Quattro anni più tardi, a Pechino, sentivo già addosso il peso delle aspettative e il mio stesso desiderio di fare qualcosa di importante.
Gli alti e bassi vissuti durante l’avvicinamento ai Giochi sono spariti completamente durante l’accensione del braciere, come volatilizzati tra le fiamme.
Sono riuscita a divertirmi, in gara, ma in modo diverso da come mi divertivo prima.
Sempre con quel piccolo pensiero nascosto, in fondo al cervello.
Sempre con la consapevolezza che esserci non mi bastava più.
Che volevo qualcos’altro.
Oggi guardo al futuro con occhi diversi, più maturi e forse più disincantati.
So benissimo che lo sport ha le sue regole e le sue complicazioni.
So che l’atleta si nutre della fame di grandezza e del desiderio di normalità, contemporaneamente.
So che non sono quello che faccio, ma che quello che faccio mi aiuta a costruire quello che sono.
So che la sconfitta e la vittoria vengono processati in maniera diversa nella testa e nel cuore, perché nello sport la giustizia non è uguale per tutti.
Ma so anche che, sotto-sotto, continuo ad essere la figlia dei miei genitori e della loro cultura, la sorella di mezzo, quella che non sa stare ferma e che ama fare sport.
Quella a cui interessava soltanto sciare, saltare e sentirsi libera.
Mathilde Gremaud / Contributor