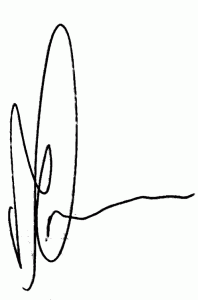Un passo avanti.
Un passo indietro.
Scatto di lato, finta, cambio di velocità.
L’idea parte da lontano, ma poi sbatte dritta contro quella di qualcun altro. Come quando ero bambino, e mi portarono per la prima volta a giocare a rugby.
Nella mia famiglia il gioco è molto più di un gioco: è parte della cultura. Un vero e proprio pezzo di quello che siamo, delle storie che vengono tramandate dai genitori ai figli, e dai nonni ai nipoti: è la lente attraverso cui guardiamo il Mondo.
Il nome stesso, Ioane, è piuttosto conosciuto nell’ambiente, e portarselo appresso significa farsi venire le spalle grandi il prima possibile, per non finire schiacciati sotto a tutto il suo peso.
Il mio papà, ai suoi tempi, era considerato un prospetto importante, uno di quelli che val la pena seguire con attenzione, perché di certo farà qualcosa di grande.
Ma non lo ha fatto.
Non in campo almeno, perché la disciplina non era esattamente il suo forte, e quando è uscito dal giro che conta, ha deciso di mettere quello che sapeva al servizio degli altri.

Le mani sul pallone.
La postura del corpo.
Gli angoli da scegliere per attaccare la linea.
Il primo studente d’eccezione è stato mio zio, Digby, che ha preso da lui tutto quello che c’era da prendere, ed è diventato tutto quello che poteva diventare.
Forte, veloce, intelligente: è arrivato più in alto di chiunque di noi.
Nove anni più tardi sarebbe stato il mio turno, e mentre io crescevo, papà cercava di trasmettermi le stesse identiche cose che avevano reso grande lo zio.
Quindi, a cinque anni, sono andato al campo, pronto a proseguire la tradizione della mia famiglia, armato di tutte le migliori intenzioni.
Da piccolo, però, non ero atletico come gli altri, non avevo gli stessi istinti per il gioco, come se il talento dei Ioane avesse saltato una generazione, e quello scarso fossi io.
Dopo un paio di settimane è arrivato il momento della prima partita ufficiale, che è un gran bel banco di prova, perché dall’altro lato del campo non ci sono più i tuoi compagni ed amici, ma persone sconosciute, pronte a scoprire, e farti scoprire, cosa significa competere. Ricordo di aver provato a fare un placcaggio e di essere stato spazzato via dal mio avversario. Ho provato un tale imbarazzo da decidere di non tornare più al campo e di lasciar perdere con il business di famiglia, per evitare a tutti la delusione di un cocente fallimento. A mio padre in primis.

Le stringhe allacciate.
Il paradenti stretto in bocca.
Il primo colpo che prendi è soltanto il primo.
Niente di più.
Anno dopo anno, le scarpe dello zio si facevano sempre più grandi, e con la loro dimensione aumentava anche la pressione che sentivo addosso di dover fare qualcosa di importante. Così, sono tornato a giocare, scendendo a patti con il mio spirito ribelle e con la voglia che avevo di non assomigliare a nessuno, se non a me stesso.
Non è stato un viaggio facile.
Vivere nell’ombra è strano, perché il sole non ti tocca mai per davvero, ma ti scotti lo stesso più in fretta degli altri. Non vieni mai valutato per quello che sei, o per quello che fai, ma soltanto in rapporto alle grandi storie del passato, che il tempo rende sempre meno realistiche e più fantasiose.
“Non è bravo abbastanza”.
“Non dovrebbe essere qui”.
Nessuno ha mai fatto mancare un’opinione non richiesta, senza farmi mai sapere però in che cosa “non ero bravo abbastanza” o perché “non avrei dovuto essere lì”.

La meta in mezzo ai pali è facile da trasformare.
Ma il pallone va riportato lo stesso a metà campo.
Perché ogni calcio d’inizio è sempre nuovo.
Intorno ai 16 anni, mi sono trasferito da Melbourne, dove non c’era una squadra professionistica, a Brisbane, per provare a costruirmi una carriera, un po’ per scelta e un po’ per senso del dovere. Credevo sempre di dover impressionare tutti per essere all’altezza del passato, e in questo processo non c’era lo spazio per capire chi fossi o cosa mi piacesse fare.
Finita la scuola sono andato in Francia, allo Stade Francais, con un contratto di due anni, per far parte di un roster in cui avrei ritrovato lo zio, che era una delle tante stelle di una squadra fortissima.
Sono state stagioni difficili, in cui faticavo a capire la transizione al gioco europeo, e dove ho raggiunto presto un punto di rottura. Ero lontano da casa e dalla mia compagna, stavo per diventare padre, e non avevo la più pallida idea di cosa avrei potuto fare di diverso dal rugby per provvedere alla mia famiglia.
Non avevo mai avuto un piano B.
E non avevo mai investito veramente nel piano A.
Quantomeno non emotivamente.
La mia era soltanto una fatica vuota.
Poi, dopo anni vissuti insieme, io e lo zio ci siamo separati: lui è rimasto in Francia e io sono andato in Nuova Zelanda, per quella che forse era la mia ultima chiamata.
Quando finalmente mi sono ritrovato da solo, tutto ha cambiato colore, e ho iniziato a comprendere quello che mi piaceva del rugby e della vita.
Ho preso una strada diversa, nella quale posso essere chi desidero essere, e nella quale ho capito che tutti i valori che la mia famiglia mi ha insegnato possono essere utilizzati anche per raggiungere la mia felicità personale.
Da allora è stato un percorso diverso, che prosegue oggi in Italia, dove mi sento coinvolto e realizzato.

Un passo avanti.
Un passo indietro.
Scatto di lato, finta, cambio di velocità.
A volte non basta fare la cosa giusta per andare in meta.
Se potessi, oppure dovessi, ricominciare tutto daccapo, non credo che cambierei nulla. E anche se questo è il cliché dei cliché, non potrei essere più sincero di così.
Essere felici è una materia delicata, e basta un minimo spostamento di qualcosa per mettere a rischio tutto quello che hai costruito. Oggi metto tutto nella giusta prospettiva, e sento di avere l’equilibrio giusto per affrontare quello che succede ogni giorno.
Anche quando succedono cose di cui è difficile parlare.
L’anno scorso ho avuto dei seri problemi di mental healt, e per qualche mese ho faticato a trovare le ragioni per andare avanti.
È un dolore strano, che chiunque può soffrire, qualunque sia la sua età, professione, fede oppure famiglia. È il male di tutti. Nessuno escluso.
Come un imbuto prende ogni pensiero, ogni possibilità esistente, ogni sensazione provata e li comprime in un unico punto, dove tutto è stretto, e dove tutto diventa scuro.
Il buco nero delle idee e della volontà: la mente si frammenta, vieni sopraffatto dalla responsabilità che senti di rimettere insieme i tasselli del mosaico, e finisci col vivere per inerzia, non per desiderio.
In ogni istante, di fronte a ogni scelta, il worst case scenario è il solo scenario che si riesce a visualizzare.
Non riuscivo più a godere del rugby.
Non riuscivo più ad essere felice nel tempo passato con le mie figlie o la mia compagna.
Non riuscivo a produrre nemmeno un singolo pensiero positivo.
Non riuscivo a parlarne con le persone che mi amano e che amo.
Ecco, non cambierei neppure quei mesi, perché quando ho deciso che ero stanco di soffrire e che volevo tornare ad essere l’uomo di prima, ho imparato a accettarmi, e a comprendere che anche quando le cose non vanno nella direzione che vorrei, ho il potere di andare oltre.
Ho il potere di guardare avanti, di essere felice, e di condividere quello che sento.
Sono Monty Ioane, e gioco a rugby.
Non raggiungerò i traguardi di mio zio, ma non ha importanza.
Sono un figlio e sono un padre, e anche se non sono sempre felice, so di avere tutta la forza, la fede e l’amore che servono per vivere.
Monty Ioane / Contributor