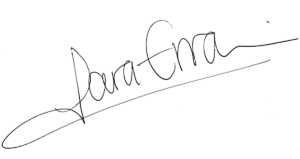Non riguardo quasi mai le mie partite.
Non ci ripenso nemmeno a lungo, nemmeno a quelle belle, nemmeno alle vittorie più importanti. Mi sembra di sprecare del tempo, tempo che posso usare per rivolgere lo sguardo avanti, per scoprire cosa c’è dopo, cosa mi riserva il futuro.
Eppure, anche se non li riguardo, ogni singolo match, ogni singolo set, persino ogni singolo game ha contribuito a creare la giocatrice e la donna che sono oggi, e quella che sarò domani.
Preferisco conservare nella mia memoria le emozioni forti, quelle che si distinguono da tutte le altre, come quando ho superato per la prima volta la convinzione che non avrei mai potuto battere determinate giocatrici, quelle che consideravo troppo più forti di me.
È successo con Ana Ivanovic nel 2012, e lì è scattato qualcosa.
Lì ho capito, mentre giocavo, dopo un primo set perso 6-1, che potevo farcela, che potevo dire anche io la mia, che potevo essere forte anche io Era tutto nella mia testa.
E quando mi sono seduta sulla panchina dopo la finale con Sharapova, aspettando la premiazione mi sono emozionata. La gente probabilmente poteva pensare che stessi piangendo dal dispiacere per aver perso, ma in realtà stavo sentendo di tutto dentro di me. Solo in quel momento mi sono fermata a pensare e mi sono resa conto di cos’ero riuscita a fare in quelle due settimane.
E’ stata una delle emozioni più forti che abbia mai sentito. Impossibile da descrivere a parole. Ci sono emozioni che conosciamo solo su carta, parole di cui possiamo immaginare il significato ma che solo quando senti lungo la schiena e lungo le gambe stanche, comprendi davvero.

È una vita strana, quella dell’atleta.
Non ricordo esattamente il giorno in cui ho deciso di diventare una tennista, è impossibile andare così indietro con la memoria perché ho preso una racchetta in mano prima ancora di imparare a correre.
Se chiudo gli occhi vedo papà che gioca con mio fratello Davide in giardino, e io che li seguo e li imito per fare come loro.
Non ricordo quando il tennis è arrivato nella mia vita, è stato li da sempre, ma quello che ricordo è quando ho capito che potevo aspirare a fare della mia passione, il mio lavoro.
Avevo 12 anni e sono stata selezionata per partecipare a un raduno con le migliori 64 giocatrici italiane della mia fascia d’età, andare in finale per me è stato come scoprire che si poteva fare, che era una prospettiva reale.
Quello è stato il mio inizio, perché da quel giorno ho iniziato a collezionare le mie piccole perle colorate. I momenti speciali, quelli creati da me e poi infilati in una collana, come si faceva da bambini.
Ognuna con il suo peso, la sua forma la sua grandezza.
Alcune valgono più di altre, ma se non fossero proprio in quel preciso ordine, necessarie e bellissime, faticose e difficili, io non sarei qui.
O magari sarei qui lo stesso, ma sarei diversa.

Ci vuole coraggio, e forse un po’ di incoscienza, a partire per la Florida ed entrare nell’Academy di Nick Bollettieri a 12 anni.
Un’esperienza forte. Formativa, allenante, ma anche un po’ traumatizzante.
Ero la più piccola ad essere lì senza accompagnatori, condividevo l’appartamento con ragazze di 16 anni, che mi sembravano donne adulte e sicure.
Io invece ero un po’ allo sbaraglio, non conoscevo l’inglese, non ero mai stata lontana da casa e certo all’epoca non era facile restare in contatto con la famiglia come lo sarebbe ora. In un certo senso, 25 anni dopo, porto ancora addosso le scorie di quel periodo, ma dall’altro lato non possiamo sapere come sarebbe andata la mia carriera senza quel tassello così importante.
Senza quello scoglio.
Sono tornata a casa convinta che da quel momento in poi avrei vinto ogni singolo incontro, di essere invincibile.
Ovviamente non era vero.
Mi sono trasferita a Valencia a 16 anni, e ho iniziato a vivere la mia vita con la valigia in sempre in mano, comprando solo i voli d’andata per i tornei, perché potrebbero durare un giorno oppure una settimana.
Ci vuole una famiglia che può permettersi di investire energie, soldi e risorse nel tuo sogno mentre, anche se magari non lo dici a voce alta, aspetti il giorno in cui la bilancia tra quanto speso e quanto guadagnato inizi a pendere dal lato giusto.
E, per questo, ci vuole tempo.

Ci vuole pazienza, non un tratto del carattere facile da far emergere a 12 o 16 anni.
Anzi forse a nessuna età.
Ma questo, lo sport, te lo impone.
È una giostra che non smette di girare e tu devi salire in corsa, il ranking è sempre li, sta a te riuscire a fare il salto, mettere in fila i risultati per riuscire ad a vedere per la prima volta il tuo nome accanto a un numero della classifica.
Non è qualcosa che semplicemente capita. Perché per entrare a far parte di del ranking WTA serve ottenere almeno un punto in almeno tre tornei.
E quando pensi di esserci riuscita non puoi fermarti un secondo.
Devi continuare a muoverti, per raggiungere lo step successivo, puntare ai 100, puntare alla top 10: non esistono sedute comode in questa scalata.
Tutto ha un prezzo.
Tutto richiede fatica.
Ricordo che quando ero piccola il vero obiettivo, quello che sognavo la notte e pure ad occhi aperti, non era un determinato posizionamento nel raking, o uno specifico torneo: io volevo chiudere un contratto con la Nike. Quello per me avrebbe sancito il mio ingresso nel tennis dei Grandi, proprio come Andre Agassi e Rafa Nadal i miei modelli e idoli da sempre.
Ma in fondo sono i dettagli più piccoli a farti innamorare di una storia.

Ci vuole equilibrio, non una caratteristica propria dei tennisti in genere.
Io sono competitiva, sono caparbia e agguerrita. E la maggior parte dei giorni questo mi rende una giocatrice migliore.
Però in campo è facile perdere la visione d’insieme, farsi condizionare da un singolo punto, da una palla uscita per un solo millimetro.
Quanto mi fa impazzire quando si vince o si perde per un solo millimetro.
Non sono mai stata un’atleta super tecnica, o estremamente forte fisicamente, ma credo di essere capace a leggere il gioco.
Leggere il gioco non significa solamente sapere con che colpo rispondere, significa comprendere il momento, l’avversario che hai di fronte.
Significa ascoltare il rumore del campo, quanto tira il vento o la temperatura dell’aria. Significa non dover imporre a tutti i costi chi sei, ma adattarti e diventare la versione di te più utile a portare a casa la partita, anche se non sarà il tuo tennis più bello.
Ci vuole tempismo, incontrare le persone giuste, al momento giusto.
Ho iniziato a lavorare con il mio allenatore quando avevo sedici anni, e più di vent’ anni dopo siamo ancora qui.
Non è una cosa molto comune nel tennis, si tende a cambiare, a cercare stimoli diversi, per noi invece le cose funzionano, siamo maturati entrambi nel corso del tempo ma sempre adattando il nostro rapporto alle necessità della vita.
Sono la madrina dei suoi bimbi, non penso esista un manifesto migliore per raccontarci.
Io lo so che non può più passare tutto l’anno in giro per il mondo, ha voglia di stare in famiglia.

È fondamentale non scambiare il tennis con la vita reale.
Certo che è reale, e riempie praticamente tutte le mie giornate, ma io lo so che viviamo in una bolla. Che gli occhi che sentiamo addosso sono più distratti di quelli che noi pensiamo. Che molto spesso scorrono le immagini delle partite durante i pranzi annoiati delle famiglie e il giorno dopo nessuno passerà la giornata a parlare di quanto male ha giocato Sara Errani.
Dare il giusto peso alle cose aiuta a godersele a pieno. Sapere che fuori il mondo continuerà a girare nonostante il mio doppio fallo o il mio errato scivolamento a fondo campo, mi solleva di una peso che, di fatto, non esiste.
Ci vuole anche fortuna, perché non sempre chi più si impegna, più vince.
Ci vuole infine qualcosa in più, all’origine di tutto che non mi ha mai abbandonato, l’amore per il gioco.
Sara Errani / Contributor