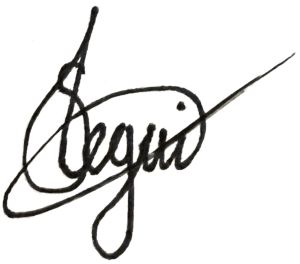La fragilità mi ha reso più forte.
Molto più forte.
Riconoscere la mia mortalità ha reso tutto infinite volte più profondo.
Ogni volta in cui ho permesso a qualcuno di vedere i miei limiti, le mie mancanze o i miei dolori sono diventato una persona migliore.
Più paziente.
Più calma.
Più riconoscente.
Il corpo arriva prima di tutto il resto.
Ed è facile da vedere.
Grande, grosso, muscoloso.
Sembra costruito apposta per andare in guerra, per andare in trincea, per sbattere contro le linee nemiche. Cade e si rialza, e nel processo di collisione consuma gli avversari, consuma la linea del vantaggio.
Graffia la difesa.
Un centimetro alla volta: la costanza del martello, che colpisce con la ferocia di chi crede che sarà proprio questo impatto, questa accelerazione, questo break, a vincere la partita.
Anche a 80 metri dalla linea di meta.
Anche nel momento di massimo sforzo.
Anche quando ormai si sta muovendo per inerzia.


Il corpo si presenta immortale e perfetto, in un sottile equilibrio di convinzioni, di sicurezze e di proiezioni, che si manifesta nel primo placcaggio, e si esaurisce, se tutto va bene, soltanto il mattino seguente.
Il mattino seguente.
Ecco la vera faccia del rugby.
La vera faccia dello sport.
Quante persone conosco le difficoltà del giorno dopo?
A quante ho concesso di vedermi soffrire mentre provavo ad alzarmi dal letto?
Quante hanno avuto il privilegio di mettermi un braccio intorno al corpo per aiutare a mettermi in piedi?
Per anni ho pensato, creduto e agito come se il mio corpo fosse uno scudo.
La corazza del cavaliere.
Come se nulla potesse davvero ferirlo, neppure le fratture ossee o gli strappi muscolari, i lividi sul volto o le commozioni cerebrali.
Perché ciò che non uccide rende più forti e perché ogni cicatrice ti rende più spesso, più duro, più abituato alla sofferenza.
Peccato che non sia esattamente così.
Peccato che ogni singolo colpo ricevuto ti avvicini a quello che sarà l’ultimo che prendi, su un campo da rugby.
L’infortunio finale.
La giocata da cui non torni più.
Ogni contatto ti assottiglia, ti rende più trasparente.
Più fragile.
Ed è solo imparando ad abbracciare quella fragilità, a mostrarla a chi ti vuole bene, che diventi davvero libero.
Libero dalla paura e dalla narrativa.
Libero dai luoghi comuni e dall’immagine che hai di te.
Libero di chiedere aiuto, quando serve.
O anche solo quando vuoi.


E così come il corpo è anche la mente, che deve sopravvivere per anni alla durezza della selezione, alle difficoltà della concorrenza.
Al desiderio di primeggiare e al tempo che occorre per arrivare a farlo davvero.
Quando sei giovane non riesci a pensare ad altro.
Vuoi eccellere.
Vuoi spaccare il Mondo.
Vuoi diventare il migliore di tutti.
E il corpo è lì, robusto come un albero, a sostenere i tuoi sogni.
Tutto è assoluto.
Tutto è eterno.
La vittoria è per sempre.
La sconfitta è per sempre.
Il successo, la disperazione, la fame, la sete, la gloria: tutto è per sempre.

Poi invecchi.
Poi cresci.
E il tempo ti lavora ai fianchi, come un pugile esperto.
Come un pugile che conosce i tuoi punti deboli.
Stagione dopo stagione, inizi a capire di non essere soltanto un giocatore di rugby.
E in quella ricchezza di significato, che ti fa apprezzare anche l’essere un amico, un fidanzato, un padre o un figlio, il gioco rallenta, diventando così molto più comprensibile.
E nonostante il corpo perda ogni giorno qualcosa, la testa sopperisce, e ti trasforma.
Diventi più preciso.
Diventi più capace.
Inizi a capire i momenti della partita, il suo flusso, l’impatto che serve quando serve.
Perché hai smesso di sentirti un supereroe, e hai cominciato ad accettare i limiti della tua mortalità sportiva. Il fascino della finitezza.
Un sistema di specchi che ti aiuta a guardare dentro, nel profondo, riempiendo di significati ogni singolo placcaggio, ogni mischia, ogni collisione.

Il talento che hai sempre saputo di avere sparisce, perché si riflette in quello degli altri, che è puro quanto il tuo.
I dubbi diventano il carburante del tuo immediato futuro, quello che muore alla fine del match, e che poi rinasce, come per magia, al momento del captain’s run.
Così, ogni incontro diventa il riassunto di una vita intera.
La somma delle esperienze passate.
Una chiave di lettura per la carriera che hai costruito.
Per le paure che hai affrontato.
Per le esperienze che hai vissuto.
Ogni volta che scendo in campo, rivedo la strada fatta, in tutta la sua complessità.
Rivedo l’infanzia trascorsa correndo nei grandi spazi aperti della fattoria di famiglia.
Rivedo i miei fratelli e mia sorella.
Rivedo il tabacco, il grano, le mandrie.
Gli alberi di mele.
Rivedo il giorno che ha cambiato nel nostre vite, insieme a quelle di milioni di altre persone. Un Paese in rovina, le occupazioni armate, il suono dei proiettili.
Rivedo mio padre che rientra di corsa a casa, che ci ordina di fare le valigie e di scappare, lasciando tutto quello che avevamo alle nostre spalle.
Rivedo i nuovi inizi e la normalità da ricostruire lontano da dove sono cresciuto.
Una casa lontano da casa.

E poi rivedo i sacrifici fatti dai miei genitori per normalizzare il cambiamento, per farci studiare, per permettermi di esprimere chi sono attraverso lo sport.
Rivedo il ragazzo che diventa uomo.
La prima convocazione in Under20, l’accademia degli Sharks.
Rivedo il trasferimento in Gran Bretagna, gli anni al Benetton.
Rivedo tutte le persone care e tutti gli infortuni.
Rivedo tutte le sconfitte e tutte le vittorie.
E ogni cosa partecipa alla costruzione del mio bagaglio emotivo.
Della mia persona.
Del rugbista che sono.
Un atleta forte e un uomo fragile.
Un uomo forte e un atleta fragile.
Felice della sua storia e della sua mortalità.
Pronto ad affrontare il prossimo placcaggio come se fosse il primo.
O come se fosse l’ultimo.
Perché, in fin dei conti, non c’è alcuna differenza.
Sebastian Negri / Contributor