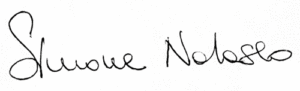Il cuore è un muscolo involontario.
Capita che si invaghisca di un’ombra o, peggio, di un profumo.
A volte si perde ad inseguire ciò che, di fatto, lo ha appena sfiorato.
Può ignorare il dolore che gli viene inflitto, in nome di un qualcosa di intangibile, che non si comprende appieno.
È in grado di sopportare pesi enormi per poi finire con l’indurirsi, un giorno dopo l’altro.
Sa essere capace di trovare la luce a cui ancorare ciò che resta di sè, per aiutarci ad ignorare il buio che a volte ci inghiotte.
Il mio mi ha guidato verso l’ingresso di una piccola scuola di ballo a Torvaianica, sul litorale della Capitale, ormai tanti anni fa.
Quel giorno lui, il cuore, prese le sembianze di mia madre e del suo sconfinato amore per spingermi a seguire quelle orme che aveva da tempo iniziato a lasciare davanti a me.
La mia strada.
Avevo avuto fin da piccolo una predilezione per un certo tipo di arte, ero davvero dotato di una spiccata sensibilità.
Cantavo sempre e mi dimenavo al ritmo della musica.
Tutti riuscivano a percepire immediatamente che nel mio sangue scorreva un ritmo speciale, decisamente elegante e me ne accorgevo anch’io.
L’animo più profondo e riflessivo impiega più tempo di quello matematico ed analitico a trovare sé stesso e per questo ho impiegato un po’ a comprendermi appieno.
Persino in un’età, l’infanzia, nella quale ogni decisione che si prende assume sempre i contorni della legge divina.
Ho fatto nuoto.
Ho giocato a pallavolo ed a calcio.
Ma è mettendo il piede in quella palestra, a dieci anni da poco compiuti, che ho capito che cosa io, intimamente, desiderassi fare.
Il mio pianto, vezzo di un bambino insicuro, si è spento immediatamente, perché gli occhi da pesti e gonfi di lacrime sono diventati come adoranti palle di biliardo bianche e scintillanti, che seguivano con crescente ammirazione i passi ed i salti, le piroette ed i movimenti.
E la musica!
La musica!
Mi è stato chiaro fin dal principio quanto volessi ardentemente danzare, anzi quanto volessi rendere quella la mia vita nel senso più ampio possibile del termine.
Iniziai fin da subito a viverla come se fossi diventato il portatore sano di una malattia bellissima: ossessivo nell’allenamento, appassionato nella scoperta, abbandonato completamente all’energia.
Più che un sogno.
Più di un’arte.
Più che un mestiere.
Il ballo è diventato il mio cantuccio, la mia dimora.
In quell’angolo magnifico trovavo riparo; nella luce calda e rassicurante di quel mondo io ho trovato la forza di resistere all’oscurità che invece mi circondava.
Un maschietto che si appassiona al ballo, che lo vive con tanto trasporto può essere facilmente preso di mira dai coetanei.
Il bullismo è una piaga grave, crea cicatrici profondissime che si radicano nell’anima dei più piccoli e non li abbandona mai, neanche a tantissimi anni di distanza.
Questo non mi ha mai condizionato, né ferito, davvero.
La danza era diventata in così breve tempo il mio mondo, in una maniera talmente forte da aver escluso con naturalezza le cattiverie dei coetanei dall’insieme di tutte quelle cose che andavano formando il mio carattere.
I compagni di danza erano i miei amici.
Erano buoni.
Capivano.
Condividevano quest’amore.
Mi hanno sempre protetto.
Mia madre mi seguiva dappertutto, mi stimolava.
Avevamo un rapporto simbiotico: era il mio braccio destro.
Guidava a lungo quasi tutti i giorni, nel traffico della Capitale, ascoltava i miei pensieri, si era appassionata ai termini tecnici.
Mi ha sostenuto e sorretto, pur senza spingere.
Ma ciò che più ha unito me, mia madre e mio fratello minore durante la mia adolescenza è stata la costante lotta per la normalità dentro le mura domestiche.
Non esiste guerra più straniante di quella che combatti per riguadagnare la normalità.
Perché se non ce l’hai, come ce l’hanno gli altri, tutto cambia, i contorni della vita si sfuocano e le giornate sembrano solo una lunga sequenza di puntate al tavolo della roulette.
Non è sempre stato facile trovarla per noi a casa.
Il rapporto con mio padre è stato certamente complesso.
Facevo molta fatica a comprenderlo appieno.
A volte faticavo a riconoscerlo da un giorno all’altro.
Era adorato da tutti gli amici, miei e di famiglia, perché mostrava al mondo un guscio scintillante: era sempre disponibile, rideva, scherzava, sosteneva le nostre scelte.
Chiusi nelle stanze della nostra casa però quell’uomo se ne andava e lasciava spesso spazio ad un estraneo: irascibile ed umorale.

The Dark Side of The Moon
I suoi continui cambiamenti d’umore ci sfiancavano terribilmente, certe trasformazioni inaspettate lasciavano talvolta mia madre e mio fratello scossi.
Tutto questo ha unito noi tre.
Ci ha uniti come non mai perché potevamo contare soltanto uno sull’altro, e nulla più, per ricreare l’armonia di cui tutti, in casa, dovrebbero godere.
Ed io, ometto coscienzioso, costretto a crescere prima del tempo, mettevo tutto ciò che avevo: forza, tenacia ed orgoglio tra i miei genitori.
In mezzo intendo.
Cercando di istruire.
Cercando di costruire.
Cercando di ricostruire.
Fino a che non sei completamente cresciuto, per quanto velocemente tu sia costretto a farlo, capire tutte le dinamiche che ti circondano con chiarezza è davvero impossibile.
Ricordo con disarmante lucidità la sensazione che provavo quando dovevo parlare a lui, magari per fare una semplice richiesta.
Chi mi avrebbe risposto?
Il padre buono, quello che rideva e scherzava, quello che mi spronava a ballare, quello che mi viziava con molti regali?
O avrebbe risposto l’ombra di quell’uomo, quello sconosciuto estraneo che poteva intervenire e gettarmi in un luogo sconosciuto del cuore, fatto di paure e frustrazione?
Ho imparato prestissimo a pesare ogni singola parola.
Ad usarne poche.
A sceglierle con cura.
Ad interpretare il suo volto a mano a mano che parlavo.
Nel costante impegno di dire un qualche cosa che non lo alterasse, che non lo facesse scaldare e non lo spingesse a mostrare il peggio di sé.
L’uomo che sono oggi è il bambino che ero ieri.
Ancora adesso, che ho scelto e percorso il mio sentiero, non riesco a non riflettere a lungo su ogni parola che dico.
Non riesco a non analizzare metodicamente ogni parola che mi viene detta.
Molti possono pensare che sia semplicemente il risultato di un carattere riflessivo, non è così.
Talvolta questo enorme casco di ragionamenti mi pesa al punto di indolenzirmi il collo e le spalle.
Talvolta mi sento come se la lingua si gonfiasse e non riuscisse più ad articolare le parole, fino a che la mia mente non è riuscita, oggi come allora, a formulare un pensiero finito, perfetto ed equilibrato.

Forse, con il tempo, con il passare lento degli anni, quelle che oggi sono ferite diventeranno cicatrici ed io sarò in grado di togliermi dalla testa i filtri che, per proteggerci, ho costruito da bambino.
Un castello di pensieri per tenere i nemici fuori.
Gli anni passavano e il mio amore per la danza iniziava anche a regalarmi traguardi prestigiosi, non senza dei sacrifici pazzeschi.
Ho studiato danza classica alla Royal Academy School of London, mi sono diplomato al Lachance Ballet di Steve Lachance.
Iniziavo già a fare dei piccoli lavoretti con qualche compagnia in giro per l’Italia e, ovviamente, avevo inziato ad accumulare un consistente numero di assenze a scuola.
Questo fu motivo di discussione molto forte, con mio padre.
Se agli inizi del mio percorso artistico era un mio accanito fan, col passare dei mesi iniziava a vederne i lati negativi per il mio futuro, e questo mi dispiaceva.
Ma, in fondo, ciò che più rapidamente stava cambiando ero io.
Crescendo mi rendevo maggiormente di quanto gli attriti in casa avessero degli effetti indelebili su di noi.
La mia comfort zone, che adesso era diventata itinerante perché avevo iniziato a viaggiare con la danza, era sempre lì, capace di ripulire la mia anima dai graffi che si andavano ad accumulare.
Ma per mio fratello, di quattro anni più piccolo, e per mia madre non c’erano uguali valvole di sfogo ed io mi sentivo sempre più responsabile del loro benessere, della loro felicità.
Con me fisicamente spesso fuori casa, il peso della situazione ricadeva sulle spalle di mio fratello, oltre a quelle, larghissime, di mia madre.
Volevo diventare per loro ciò che la danza era per me.
Ancora oggi mi riaffiorano spesso dei dubbi, un piccolo, latente senso di colpa che mi spinge a domandare a me stesso se ho fatto abbastanza.
Se potevo fare di più per proteggerli.
A volte mi chiedo se questo enorme amore per la danza, che ha salvato me, non abbia tolto un pochino a loro, privandoli di una parte del mio sostegno.
Devo comunque ammettere che questo mormorio distante mi ha dato una carica pazzesca e la determinazione più selvaggia ad arrivare, una forza che non credevo di avere.
Ho visto e conosciuto tanti ragazzi con dei problemi simili. Li ho visti deragliare verso binari senzia via d’uscita, perdersi in strade torbide e rifugiarsi nelle dipendenze.
La danza mi ha protetto da questa deriva.
Ricordo come io e mia madre rimanessimo tutti i giorni incollati alla tv a guardare Amici, non ne perdevamo una puntata.
Osservare gli artisti sullo schermo era diventato uno di quei silenziosi riti laici che si ripetono costantemente in casa, creando essi stessi il significato di famiglia.
Come il telegiornale durante la cena.
Come Tom e Jerry quando si fa la colazione.
Indescrivibile è il ricordo del momento in cui le ho detto che avrei fatto parte del cast.
La realtà che supera il sogno più sfrenato; la luce accecante in fondo al tunnel, un tunnel però non semplicemente percorso, ma scavato in prima persona, aperto a picconate come fanno i carcerati che evadono nei film americani.
Evasione.
Metafora di una fuga.
Fuga da ciò che non capivo, dalle incomprensioni. Rifugio trovato nella fatica e nel lavoro.
La pentola piena di monete d’oro in fondo all’arcobaleno comparso dopo una tempesta terribile.
Nel 2011 facevo parte del cast del Peter Pan World Arena Tour, uno spettacolo itinerante gigantesco.
1800 metri quadrati di palco, centinaia di professionisti.
Giravamo le più moderne arene d’Europa.
Dopo aver trascorso alcuni giorni a Bruxelles per le tappe in Belgio ci siamo spostati ad Amsterdam, allo Zigodome.
In cartello Rihanna.
Il giorno seguente: noi.
Nella platea più di otto mila persone.
Mi sono sentito un niente ed un tutto allo stesso momento.
Non importa quanti compagni hai al tuo fianco quando ti esibisci, perché comunque tu ti sentirai sempre ogni coppia di occhi puntati fissi solo su di te.
A prescindere.
Avevo toccato il cielo con un dito.
Al rientro a casa mi sono sentito teletrasportato in una realtà parallela, ripiombato in una situazione estenuante di incomprensioni e di esasperazione.
La differenza principale tra le due realtà era che una era sognante e liberatoria e l’altra era cruda, ma più vera e consistente.
Mentre vivevo in quella del palco la mia mente non poteva certo dimenticare quella famigliare, al contrario invece nelle ore trascorse a casa il peso di quella sofferenza cancellava tutto il resto, anche le mie gioie più intime.
La realtà, quella vera è sempre e soltanto quella della propria casa, della propria famiglia.
Questa è la realtà che ogni giorno affrontano migliaia di bambini che vivono con genitori separati, o, peggio, che fingono di non esserlo ancora.

Affrontare un divorzio non è stato difficile.
Tutto ciò che ha portato lì invece lo è stato moltissimo.
Oggi per le coppie tutto è più liquido, ci si prende e ci si lascia con una leggerezza maggiore, schiavi del culto della felicità individuale a tutti i costi.
Le generazioni precedenti sono cresciute nella convinzione che certe cose vadano aggiustate e non buttate.
Magari anche aggiustate per forza.
E se cadendo il vaso ha lasciato qualche coccio a terra è bene nasconderlo sotto il tappeto.
Credo sia impossibile ritenere una via migliore dell’altra in assoluto.
Forse non è giusto vivere tutto nell’incostante insoddisfazione dell’uomo moderno.
Forse non è neppure giusto nascondere sé stessi in fondo al cuore perché le cose devono funzionare.
Ma di una cosa sono certo.
I figli vengono prima.
Semplice. Forse semplicistico.
Non importa.
I figli captano tutto, tengono in fondo all’anima e lo fanno riemergere piano, diventando uomini e donne diversi via via che il tempo dona loro le armi per interpretare ciò che hanno visto e sentito.
Un nucleo che si sfalda non è soltanto uno dei possibili sviluppi naturali di una relazione.
Un nucleo che si sfalda per un bambino è la caduta degli dei dall’Olimpo.
È un mito fondativo che viene sbugiardato.
È una magia potentissima.
Avere fede può significare tutto.
O il contrario di tutto.
Ma fede e amore non sono forse sinonimi?
Avere fede non significa forse sentirsi in ogni momento della propria vita parte di un insieme perfetto?
Che è più grande di noi, che è più cosciente rispetto al nostro pensiero, come se conoscesse una verità che da soli non possiamo sostenere?
La fede ci rassicura.
Non è tutto questo anche amore?
Nel dramma personale che ogni uomo può essere costretto ad affrontare, nello scorrere lento delle difficoltà ogni persona, ogni bambino, deve avere la forza di trovare fede in qualcosa: fede in dio, fede in sé stesso, fede in qualcuno.
La fede, che è amore, tiene accesa la fiamma in fondo al tunnel e ti spinge a raggiungerla.
Ci si deve ancorare ad uno scoglio, nella tempesta.
E credere con tutte le proprie forze che le mani non lo molleranno fino a che non sarà tornato il sole.
A scuola ero bravo.
Non il migliore della classe.
Ma studiavo.
Ci hanno insegnato che il cuore è un muscolo involontario.
Anni dopo ho capito il perché.
Simone Nolasco / Contributor