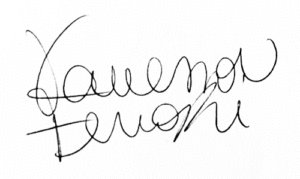La mia carriera ad oggi potrebbe già considerarsi lunga.
In effetti dagli inizi fino a qui di strada, e di diagonali, ne ho consumate parecchie sotto ai piedi, non senza pagare per questo viaggio un prezzo piuttosto alto.
Ho dovuto spesso convivere con il dolore fisico che per settimane, in alcuni casi per mesi, mi ha seguito come un’ombra, come una fastidiosa tassa da pagare con una scadenza ben precisa impressa sopra.
Il dolore fisico è un’esperienza ogni volta diversa, anche quando si ripete uguale nei modi e nelle manifestazioni. Persino dopo anni che hai fatto la sua conoscenza lui comunque ti sorprende ancora: è come se fosse sempre nuovo ed è difficile tenerlo al guinzaglio.
A volte riesci a sedarlo per un po’, giusto per qualche ora, per qualche giorno o per il pomeriggio di una gara importante. Puoi provare a mettergli il silenziatore con le terapie, con il riposo, ma lui borbotta e torna a galla, come una sirena in lontananza che senti avvicinarsi piano piano e non puoi far altro che aspettare. Oppure come un’ospite inatteso che suona al campanello senza alcun preavviso e che devi far accomodare in casa per forza.
La sfida al dolore, la sua difficile sopportazione, è un capitolo della biografia di ogni grande atleta esattamente quanto lo sono le vittorie e le sconfitte. La differenza è che di una medaglia si racconta per anni mentre di un infortunio ci si dimentica appena l’inchiostro del giornale è asciutto e della fatica richiesta per ritornare non si racconta quasi nulla.
Da quando sono rientrata in pedana, all’inizio di quest’anno, non è passato tanto tempo, almeno non quanto avrei voluto, soprattutto dopo un’assenza dolorosa e lunga come quella degli anni scorsi.
500 lunghissimi giorni, tra il 2016 e il 2018, senza la ginnastica e senza la competizione.
Nonostante quest’anno siano arrivati subito dei buoni risultati purtroppo mi devo fermare ancora perché non riesco ad allenarmi con la giusta serenità a causa di un martellante problema al piede sinistro. Devo tornare sotto ai ferri.

La gamba sinistra è quella che ha sofferto più di tutto il resto nel corso mia carriera ed è quella in cui mi hanno operato al tendine d’Achille. Proprio alla base, sull’inserzione del tendine ricostruito, oggi c’è uno sperone osseo, un pezzetto in più di scheletro che gratta e mi fa male ogni volta che salto e che mi alleno.
Va tolto, e ho deciso di farlo subito perché ho davanti agli occhi il sogno grande e limpido di Tokyo 2020 e voglio arrivarci libera da qualunque condizionamento esterno indesiderato.
Voglio rivivere l’ebbrezza che finora ho provato soltanto a Londra 2012: quella di un’Olimpiade senza dolori, al massimo della forma e libera di giocare tutte le carte che ho nel mazzo senza pensieri per la testa, senza asterischi preoccupanti di cui tenere conto.
Affronto, quindi, un’operazione nuova e ne approfitto per dare una ripulita anche all’altra caviglia, quella destra, che sta meglio ma che non sta bene, e che vorrei ritrovarmi ad agosto leggera e forte.
Aspettare non sarà facile perché anche se le ginocchia scricchiolano l’unica cosa peggiore di allenarsi sopra il dolore è non poterlo fare in assoluto.
Ci vorranno tre mesi per tornare a correre e saltare ma questa volta li affronterò con tutta la calma che il mio corpo mi chiederà di avere perché voglio ricominciare a godermi la pedana senza affanni e senza dolori di alcun tipo.
Questa non sarà certo la mia prima operazione ma la sto affrontando con uno spirito diverso rispetto a tutte le altre sostenute in precedenza.
Oggi infatti torno in sala operatoria perché scelgo di farlo consapevolmente, convinta di guadagnarci nel lungo termine molto di più di quanto perderò in questi mesi, nei quali sarò costretta a saltare diversi allenamenti.
Questa certezza mi sorregge e mi aiuta: una convinzione che è già metà della terapia.
Gli orizzonti di un atleta invece cambiano profondamente quando ad essere sdraiata sul tavolo del chirurgo è la tua carriera intera perché quello che stai rimettendo insieme è un pezzo del tuo corpo che da rotto non funziona proprio più.
Lì è naturale provare paura, anche a me è successo, perché non puoi sapere con certezza se ti sapranno aggiustare e se sarai capace di tornare esattamente com’eri prima.
Non ti operi per migliorare qualcosa, lo fai, al massimo, per tornare quel che eri.
È difficile ed è spaventoso.
Ma è anche necessario.
Il giorno in cui mi sono rotta il tendine, ormai quasi due anni fa, a Montreal, ho sentito dentro una paura profonda esplodermi all’improvviso. Il mio cervello ha fatto un milione di calcoli in tempo reale, ha valutato mille ipotesi, come se fosse un computer, nel tentativo di scartare quella che già sapeva essere quella giusta.
In realtà ho capito subito che si trattava di un problema grave perché al momento dello stacco è successo qualcosa di strano e di rapidissimo che mi ha sbalzato verso l’alto.
Mentre roteavo, prima di cadere, ho fatto in tempo persino a dirmi che forse si era solamente rotta la pedana. Poi però, un millesimo di secondo dopo, ho sentito un suono sordo e secco, come delle dita schioccate a pelo dell’acqua quando tieni le orecchie sotto, e un colpo, come una sassata lanciata precisa a colpirmi dietro il polpaccio.

Quando sono atterrata ho preso in mano il piede, ho visto un buco tra il tallone ed il polpaccio e immediatamente ho cancellato tutte le altre opzioni.

Quella che ne è seguita è stata la riabilitazione più dura tra tutte, il percorso più impegnativo che abbia mai sostenuto in assoluto, anche perché ho dovuto affrontarlo sapendo di non essere più un’atleta giovanissima.
Con l’età i dubbi si moltiplicano, come le ore di riposo che ti occorrono tra una seduta e l’altra.
Nei momenti immediatamente successivi all’infortunio mi dicevo che la prossima Olimpiade era vicina, forse troppo vicina, e che non avrei avuto il tempo e la forza per tornare dove stavo prima. Mi chiedevo se sarebbero riusciti a sistemarmi sufficientemente bene per fare di nuovo quello che avevo sempre fatto in pedana.
Ma più di ogni altra cosa ho passato ore a chiedermi se avessi la voglia di intraprendere questo viaggio.
Non è stato affatto semplice darmi una risposta chiara e decisa, direi che è stato piuttosto un processo lento e doloroso fatto scavando dentro me stessa, nel quale ho iniziato a capire quello che volevo davvero solo giorni dopo l’operazione.
Ci sono voluti i primi passi, i primi segnali di ripresa, per iniziare a pensare positivo e cominciare a credere che forse alla fine del percorso avrei nuovamente incontrato la mia amata pedana.
Vivere il quotidiano per un atleta che rientra da un grosso infortunio è un esercizio complicato perché occorre conoscersi molto a fondo per riuscire a non perdere la calma. È necessario stringersi forte alle cose che continuano a funzionare anche quando un pezzo di te è rotto: come gli affetti, come la famiglia.
Poi, se il calore e il conforto che ricevi da chi ti circonda sono sufficienti a resistere ai momenti più bui, all’improvviso il tuo corpo inizia a reagire, riprende a rispondere agli stimoli e ti dimostra con i fatti che sei più forte di quel che ricordavi.
Le lunghe giornate di fisioterapia iniziano ad accorciarsi lentamente e da lì in avanti cominci a scorgere un angolo di pedana con la coda dell’occhio, cominci a capire che forse ce la fai a tornare.
Durante gli oltre cinquecento giorni passati senza poter gareggiare ho avuto anche modo di leggere molti messaggi sgradevoli.
Molte cose scritte con superficialità e cattiveria.
Questa è la fine per lei
dicevano in tanti e, ad essere sincera, mi hanno motivato in maniera incredibile. È troppo facile saltare alle conclusioni dalle proprie scrivanie per decretare la fine della carriera di qualcun altro, ma è bene ricordare che io decido per me, e nessun altro.
Io ce la posso fare ogni volta che decido di farlo.
Sarò io a decidere quando sarò abbastanza soddisfatta da potermi ritirare, nessun infortunio lo farà al posto mio.
E se ho deciso di tornare in pedana è stato principalmente perché non voglio rimpianti.
Di nessuna forma e di nessuna specie: non ne voglio neppure uno.
Volevo ricominciare da dove avevo lasciato.
Voglio ripartire in direzione di Tokyo e voglio viverla con la gioia di un fisico senza dolori per potermi dire in futuro, a prescindere dal risultato: brava, hai fatto tutto quello che dovevi!

© Ginnastica Artistica Italiana
Rientrare dopo così tanti giorni è stato emozionante quanto una vera e propria prima volta. Mi sentivo agitata e vulnerabile perché la gamba mi dava ancora dolore e non avevo avuto il tempo necessario a prepararmi come sono solita fare per le gare.
Avevo il dubbio di non esser pronta a fare bene il mio esercizio e l’insicurezza nel mio sport è un avversario invisibile ma cattivo.
Tutto è andato come programmato, i primi segnali dal rientro sono stati più che positivi e riannodare il filo tecnico ed emotivo con il mio passato agonistico è sicuramente un benaugurante motivo di felicità.
Il percorso di completa riabilitazione non è ancora concluso purtroppo e questa nuova operazione mi servirà a sistemare le ultime cose per dare poi l’assalto alla mia ultima Olimpiade tanto attesa.
La strada è ancora lunga e tutt’altro che priva di difficoltà ma sono decisa a percorrerla tutta fino in fondo, cercando di ottenere il massimo di quello che vorrei.
Sogno una medaglia che fino ad ora ho soltanto sfiorato e sogno dei ricordi a 5 cerchi privi di rimpianti per quando avrò deciso, io e io soltanto, di dire basta.
Tornerò presto in pedana, con grandi obiettivi dentro agli occhi.
Farò un respiro profondo e per darmi la carica sbatterò i palmi forte prima di cominciare l’esercizio. Lo farò senza guardarli perché le mani sanno sempre dove devono incontrarsi.
Non tutto però funziona sempre così, in automatico, perché insieme alle ossa, ai tendini e ai muscoli mi porto appresso anche qualche cicatrice.
Cicatrici invadenti e necessarie, che servono a tenere insieme quelle parti del corpo che si erano rotte e non sapevano più trovarsi l’una con l’altra.
Le aggiustiamo, le alleniamo e con loro andremo lontane.
Vanessa Ferrari / Contributor